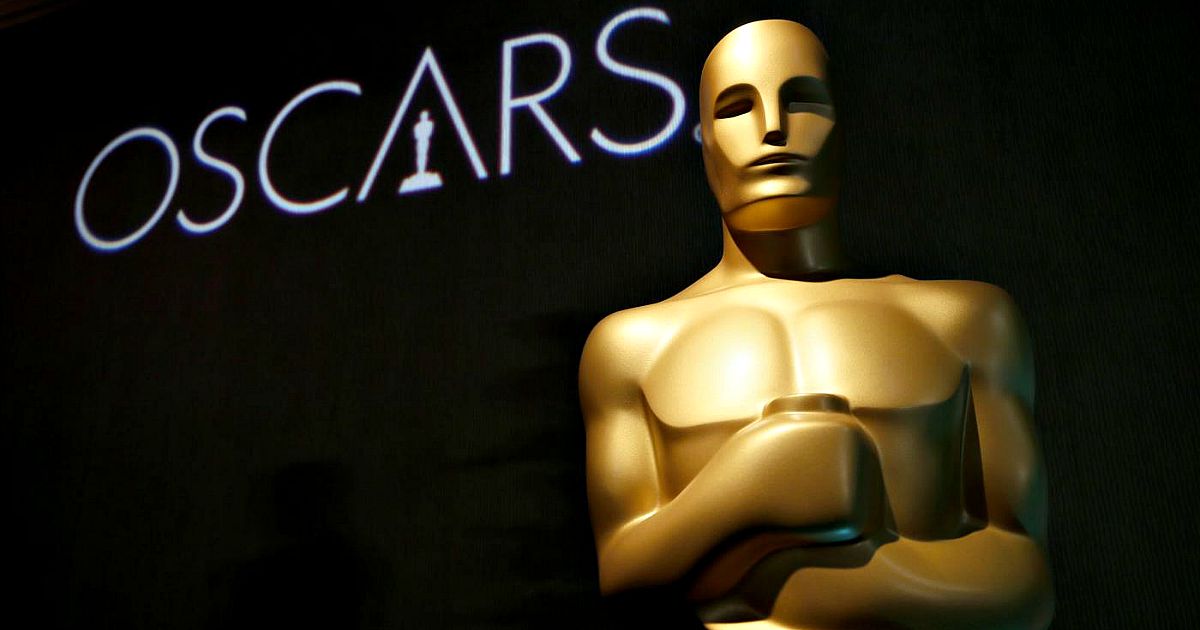A noi gli Oscar telefonati con grande anticipo piacciono poco. Del resto le recenti vittorie nella categoria del miglior film di titoli come Moonlight (2017) e Green Book (2019) ne sono un esempio: mai pensare che tutto sia già scritto. Insomma l’annuncio di un titolo pigliatutto come Nomadland di Chloé Zhao (Searchlight Pictures), pigliatutto in primis con l’Oscar come miglior film, non ci convince. Anzi, speriamo proprio in una busta sbagliata alla Warren Beatty.
Tanto per dire, tra le otto nomination come miglior film per gli Oscar 2021 ci sono almeno cinque titoli che sono di gran lunga più interessanti di Nomadland. Partiamo da Mank, il film diretto da David Fincher (produzione Netflix) una sorta di soggettiva etilico-onirico-creativa di Herman J. Mankiewicz (interpretato magistralmente da Gary Oldman) alle prese con l’immobilità dovuta a una gamba ingessata e lo script di Quarto Potere da realizzare entro 60 giorni. Mank avrà sicuramente qualche forzatura storica (la sovrapposizione tra lo script di Mankiewicz contro il potente magnate Hearst e la vicinanza politica con lo scrittore socialista Sinclair, ad esempio) ma è un’opera calata nel cuore profondo dell’industria hollywoodiana anni ’30 che si pone l’obiettivo di riempire il quadro, perfino di ostentare il proprio virtuosismo stilistico (ampi movimenti di macchina; dettagli/campi lunghi; metacinema a go-go) nella sua parossistica autoreferenzialità. Difficile schiodarsi dai mille sottotesti e co-protagonisti oltre Oldman, ma soprattutto uscire dal vortice pullulante maestranze e sequenze corali che quasi per sottrazione fanno emergere lo spessore storico, intellettuale, ironico, a suo modo anticonformista del protagonista. Insomma, se ci fosse un giudice dalla Corte Suprema del cinema, Mank sarebbe Oscar assicurato.
Non passa inosservato nemmeno Judas and the black messiah (Warner Bros), stralcio dei fine anni sessanta antisistema statunitensi – l’altro è Il processo ai 7 di Chicago (Netflix) – incentrato sulla vicenda di William O’Neill, un ladruncolo di auto che finisce per essere infiltrato nelle Pantere Nere, prima come autista poi capo della sicurezza, infine fidato compagno e traditore del giovanissimo leader afroamericano Fred Hampton che verrà venduto all’FBI. Diretto da Shaka King, Judas… è un’opera di ricostruzione storica per nulla scontata, formalmente impeccabile, con un’immersione mimetica del dispositivo di ripresa che sembra come abbaiare addosso alle ingiustizie urbane e razziali con un doppio carpiato politico davvero rivoluzionario nella sua contezza storica: la rivolta afroamericana delle Pantere Nere a Chicago che trova come volontaria alleanza nella lotta tra gruppi organizzati di portoricani e di bianchi poveri accomunati dal desiderio rivoluzionario di emancipazione socio-economica. Hampton parla in continuazione di socialismo, l’anello mancante della lotta di classe nell’atomizzato novecento statunitense che qui viene mostrato in tutta la sua logica naturalezza.
Un’altra unione tra gruppi sociali ed etnici echeggia sul banco degli imputati anche nel buon Il processo ai 7 di Chicago (Netflix) di Aaron Sorkin. Sono i sette agnelli sacrificali – uno per ogni movimento dei protestatori – che finiscono a processo per cospirazione e incitamento alla rivolta durante la convention del partito democratico a Chicago nel 1968. Il processo ai 7 di Chicago è un court room movie articolato e spettacolare, con incursioni negli scontri in esame, e con una sottesa idea (un po’ come in Judas…) di una rivoluzione, tra poveri di tasca ma idealisti nello spirito, della società statunitense che non riesce a penetrare, diffondersi, diventare realtà proprio per la controffensiva violenta dei poteri forti, qui di un giudice corrotto, di una polizia inqualificabile e di un FBI reazionaria. Due film estremamente politici che espongono idee di eguaglianza che vanno oltre gli steccati attuali Biden-Trump (ma molto Sanders, per dire) interpretati da star popolarissime: ne Il processo… ci sono Sacha-Baron Cohen, Eddie Redmayne e Mark Rylance, mentre in Judas … uno strepitoso Daniel Kaluuya.
Altro titolo di rilievo assolutamente oscarizzabile è la meteora Minari (prodotto dalla A24, già a segno con Moonlight) di Lee Isaac Chung. Storia di una famiglia coreana che nei primi anni ottanta si muove dalla California in Arkansas per iniziare a lavorare la terra in un appezzamento che si spera fertile. Il minari è una specie di sedano sottile che si coltiva in oriente e che la famigliola coreana cerca di far crescere nella continua e complessa ricerca dell’acqua sottoterra. L’opera è sensibilmente minimale, i protagonisti fluttuano tra i campi come possibile fonte di sopravvivenza e un lavoraccio orribile di selezione dei pulcini maschio o femmina, ma al centro c’è comunque il piccolo figliolo (Adam Kim, una sagoma incredibile) che ci introduce il film su dei titoli di testa delicati ed accattivanti.
Origini coreane ma americano di Denver, Chung esordì nel 2007 con un gioiellino di film a Cannes, ambientato in Ruanda e intitolato Munyurangabo, poi dopo altri tre lunghi ha raggiunto una specie di sospeso e poetico apice in questa sua opera semibiografica, declinazione del sogno americano in chiave orientale, u-turn dal west all’east, rallentamento sapiente della pulsazione del cinema in chiave contemplativa e tenuemente ironica. Il film uscirà proprio il 26 aprile in Italia grazie ad Academy Two e potrete rimirarlo in sala. Non è per nulla malvagio anche Sound of metal (produzione Amazon Studios), titolo di cui nessuno parla tra gli otto in nomination, ma che merita molta attenzione (e sicuramente tanta quante se ne vampirizza in continuazione Nomadland). Diretto da Darius Marder, il film racconta la storia di un batterista metal (il febbrile, spaesato, intenso Riz Ahmed – Four Lion, Venom) che suona in coppia con la compagna chitarrista, ma che si scopre improvvisamente nel fulminante annientamento di una irreversibile sordità. La macchina da presa di Marder diventa così come una sorta di semisoggettiva alla Dardenne e pedina, insegue, si inabissa negli sbalzi sempre più frequenti di silenzio del ragazzo e della sua personalissima tragedia che non trova ovviamente soluzioni nel sistema sanitario privato statunitense e non riesce più ad attagliarsi ad una vita nomade di concertini. Curioso tra l’altro che sia Minari, Sound of metal e Nomadland mostrino tutti gli esemplari della concessionaria di camper, caravan, case e casette viaggianti, macchine protagoniste di un nomadismo rapsodico e socio-politico inesausto nella storia statunitense.
Infine, forse un gradino, ma anche due, tre e perfino quattro indietro rispetto a Nomadland sono The Father (Sony Pictures Classics) e Promising young woman (Focus Features). Nel primo, cinema da camera tutto imperniato sulla performance del protagonista Anthony Hopkins, assistiamo alla scelta di un anziano signore che non vuole alcuna assistenza nonostante i problemi fisici e mentali dovuti all’età; nel secondo, film che vive eminentemente su un’idea bizzarra e poco più, assistiamo alla storia di una ragazza (Carey Mulligan) che si vuole vendicare con gli uomini per la violenza sessuale subita anni prima da una sua amica. Per concludere: difficile che Nomadland, vincitore del Globes e del Bafta come miglior film, abdichi la casella più importante che tutti ventilano come già sua. Però proprio, e solo, in questa casella gli Oscar ci hanno abituato a notevoli sorprese. E si spera che il 2021 si uno di queste.