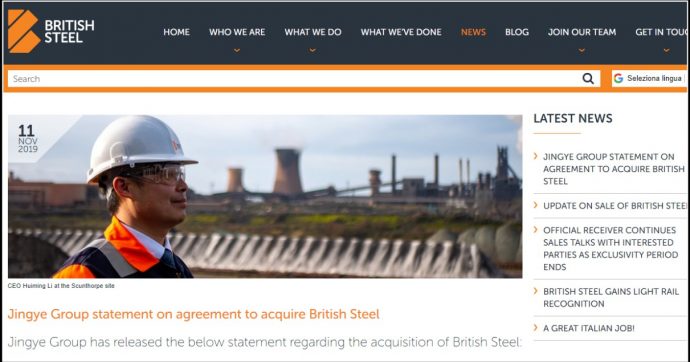Un’azienda siderurgica prima privatizzata, poi finita nel mirino per l’inquinamento e comprata da un gruppo indiano che licenzia e infine se ne va. Non è l’ex Ilva ma l’acciaieria inglese British Steel. Che ha avuto una parabola molto simile a quella della fabbrica di Taranto, contrassegnata dal declino strutturale del comparto, problemi ambientali ancora irrisolti e una sequenza di scelte sbagliate che l’hanno portata al collasso. La conclusione della storia, letta con questa lente, non è un dettaglio: British Steel è stata rilevata dal colosso cinese Jingye, che l’ha messa al riparo dal fallimento. E, secondo Il Sole 24 ore, mentre prosegue sottotraccia il dialogo con ArcelorMittal esponenti dell’esecutivo italiano incontreranno i consulenti di Ernst&Young che hanno fatto da intermediari nell’operazione.
La parabola di British Steel: dalla nazionalizzazione alla vendita agli indiani di Tata
I problemi di quella che un tempo era una delle più grandi aziende del Regno Unito sono peggiorati di pari passo con il declino del settore siderurgico. Nel 1967 il governo laburista guidato da Harold Wilson decide di fondere 14 gruppi industriali e di dare vita alla British Steel. Di fatto l’intera industria britannica dell’acciaio viene nazionalizzata e oltre 270mila lavoratori passano alle dipendenze dello Stato. Nel giro di trent’anni la forza lavoro si riduce drasticamente a 52mila unità, finché nel 1988 – con Margaret Thatcher a Downing Street – l’azienda viene di nuovo privatizzata. Un’operazione che culmina a cavallo del terzo millennio, quando British Steel e il gruppo olandese Koninklijke Hoogovens si fondono per dare vita a Corus Group, il più grande produttore di acciaio in Europa e il terzo del mondo. Ma non basta. Nel 2000, come riporta il Guardian, le perdite ammontano a 20 milioni di sterline al mese. Seguono licenziamenti di massa ed esplodono le polemiche sull’inquinamento prodotto dagli altiforni: secondo un report dell’Agenzia dell’ambiente americana trapelato in quel periodo, infatti, gli stabilimenti dell’ex British Steel risultano essere i principali produttori di diossina del Paese. Eppure gli investimenti continuano a latitare e nel 2007 la proprietà passa un’altra volta di mano. Gli indiani del gruppo Tata sborsano 12,2 miliardi di dollari con l’obiettivo di “diventare un grande player nel mercato globale”, capace sulla carta di produrre 25 milioni di tonnellate di acciaio all’anno. Ma già all’epoca, come scriveva il New York Times nei giorni dell’acquisizione, gli specialisti consideravano “eccessiva” l’offerta di Tata.
Il ruolo della Cina nella crisi (e nel salvataggio) del siderurgico inglese
Complice la grande recessione, l’aumento del prezzo dell’energia e una lunga scia di incidenti, tra il 2009 e il 2015 vengono persi oltre 8mila posti di lavoro. Il punto di non ritorno però arriva nel 2016, quando Tata annuncia di voler uscire dall’industria siderurgica del Regno Unito. Il motivo? L’ostilità del governo britannico a rafforzare le tariffe europee sull’acciaio per contrastare la concorrenza sleale cinese, scrive il Telegraph. Di fronte al boom dei prodotti a basso costo provenienti da Pechino, infatti, a niente servono gli aiuti di Stato messi sul piatto dal premier conservatore David Cameron. Nel giro di pochi mesi la divisione “prodotti lunghi” del gruppo indiano (quella più in difficoltà) viene ceduta al fondo Greybull Capital per il valore simbolico di una sterlina. La neonata società eredita il vecchio marchio British Steel, 4.800 dipendenti e il grande stabilimento di Scunthorpe, nel nord dell’Inghilterra. Eppure nel giro di tre anni l’operazione naufraga e, ironia della sorte, è proprio un gruppo cinese a mettere in salvo l’azienda.
L’ex Ilva come British Steel?
Tutto precipita il 22 maggio 2019, quando British Steel porta le carte in tribunale e finisce in amministrazione controllata. Fra le cause del tracollo, l’ex amministratore delegato parla delle incertezze legate alla Brexit, dei costi del mercato europeo del carbonio e del mancato supporto finanziario da parte del governo britannico. Le conseguenze rischiano di essere pesantissime: quasi 25mila lavoratori a casa (tra dipendenti e indotto), spegnimento dell’unico altoforno rimasto nel Paese oltre a quello di Port Talbot (ancora in mano a Tata) e costi ambientali di bonifica a carico dello Stato. Non è un caso, infatti, che secondo l’ultimo report dell’Organizzazione mondiale della sanità proprio Scunthorpe risulti essere la seconda città più inquinata del Regno Unito. Per l’acquisizione si è fatta subito avanti Ataer Holding, una società di proprietà del Fondo pensione militare della Turchia. Ma pochi giorni fa ecco spuntare l’offerta di Jingye, che ha messo sul piatto 70 milioni di sterline oltre a 1,2 miliardi di investimenti per “il rilancio del sito e la riduzione dell’impatto ambientale”. In cambio, il governo di Boris Johnson erogherà sgravi e prestiti pari a 300 milioni di sterline e – precisa il Financial Times – “garanzie a copertura del rischio ambientale o il potenziale sostegno per le nuove tecnologie”. Un modello che potrebbe essere di ispirazione per l’ex Ilva di Taranto, nonostante abbia dimensioni doppie rispetto all’impianto di British Steel e resti l’incognita sull’eventuale scudo penale per la futura newco. Con la speranza che le buone relazioni con la Cina avviate dal governo Conte I nell’ambito della Nuova via della Seta possano favorire il dialogo fra i due Paesi.
Articolo Precedente
Pignoramento dei conti per multe non pagate? È una bufala, ecco come stanno le cose

Articolo Successivo
Fondo salva-Stati, Moscovici: “Contiene anche la rete di sicurezza per le banche”. Salvini: “Quelle francesi e tedesche, per noi disastro”