Quella regola non scritta era diventata consuetudine. Calcio e letteratura non legano bene. Punto. Inutile perdere tempo a presentare a un editor un romanzo che avesse come sfondo un campo di pallone. Una ferrea legge che è andata avanti per anni. Con pochissimi corollari. Poi qualcosa ha iniziato a cambiare. Lentamente. Il calcio si è insinuato pian piano fra le righe della letteratura, dimostrando di poter scrivere pagine interessanti, di poter portare avanti una sperimentazione. Una tendenza che nella lettura anglofona era arrivata quasi con un decennio di anticipo. “Nel 1998 il Premio Pulitzer se lo giocano Underworld di Don De Lillo e Pastorale americana di Philip Roth – ci racconta Alessandro Gazoia, editor di 66thand2nd, la casa editrice che negli ultimi anni ha rivoluzionato il racconto calcistico (e non solo) – sono due romanzi in cui la componente sportiva è fondamentale, perché il racconto dello sport dice molto dei personaggi. Prima il grande scrittore poteva seguire magari il Giro d’Italia, poteva raccontarlo come se fosse un giornalista, ma un romanzo di sport era inconcepibile, era considerato ancora troppo settoriale”. Un preconcetto che è stato abbattuto lentamente, mattone dopo mattone. “Ora per una persona di trenta o quarant’anni è normale parlare di sport – continua Gazoia – perché è entrato nella nostra cultura e ci permette di costruire quell’immaginario collettivo. E il mercato editoriale ha capito che quando questi prodotti vengono fatti nel modo giusto, anche con un investimento importante, allora possono portare ottimi risultati”. Vero, perché negli ultimi anni si sono susseguiti una serie di romanzi che hanno avuto il merito di aprire una nuova era per la letteratura sportiva.
——————————————————————————-
CALCIO IN STILE WESTERN
 L’impresa non era esattamente delle più semplici. Perché l’idea di raccontare in un romanzo una squadra da romanzo si portava dietro un rischio. Quello di esagerare, di caricaturare, di estremizzare. D’altra parte la Lazio che ha trovato il suo apice nello scudetto del 1974 non era un’entità singolare, ma un qualcosa di irripetibile. Un po’ gruppo e un po’ masnada. Un po’ famiglia allargata e un po’ ammasso di estranei. Individui tenuti insieme dal pallone e dalle pistole, in parti non sempre uguali, come in un film western applicato al calcio. Un bosco di alberi cresciuti storti che ha costruito un peculiare concetto di autoaffermazione. Prima la promozione in Serie A. Poi un sorprendente titolo nazionale. Quella squadra che per anni era stata considerata brutta, sporca e cattiva era riuscita a dar vita a qualcosa di bellissimo. Il gruppo come generatore di contraddizioni continue. Commedia e tragedia che si sovrapponevano giorno dopo giorno. Fino a quando non si riusciva più a capire dove iniziava l’una e finiva l’altra. Un terreno accidentato sul quale Angelo Carotenuto si è mosso con grazia, costruendo uno dei romanzi sportivi più belli degli ultimi anni. Personaggi reali e immaginari si intrecciano insieme per raccontare la storia non solo di un club, ma di un Paese intero che in quegli anni si era riscoperto diviso. Proprio come la Lazio. Non una, ma due squadre. Un gruppo spaccato a metà e che ruotava intorno a Giorgio Chinaglia, il primo grande irregolare del calcio tricolore. I suoi devoti da una parte, gli eretici dall’altra. Nel vero senso della parola. Perché quell’insieme di calciatori che la domenica diventava improvvisamente squadra, si cambiava in due spogliatoi diversi. Una guerra civile che ha portato a risultati eccezionali ma con un costo altissimo: l’autocombustione di molti dei suoi protagonisti.
L’impresa non era esattamente delle più semplici. Perché l’idea di raccontare in un romanzo una squadra da romanzo si portava dietro un rischio. Quello di esagerare, di caricaturare, di estremizzare. D’altra parte la Lazio che ha trovato il suo apice nello scudetto del 1974 non era un’entità singolare, ma un qualcosa di irripetibile. Un po’ gruppo e un po’ masnada. Un po’ famiglia allargata e un po’ ammasso di estranei. Individui tenuti insieme dal pallone e dalle pistole, in parti non sempre uguali, come in un film western applicato al calcio. Un bosco di alberi cresciuti storti che ha costruito un peculiare concetto di autoaffermazione. Prima la promozione in Serie A. Poi un sorprendente titolo nazionale. Quella squadra che per anni era stata considerata brutta, sporca e cattiva era riuscita a dar vita a qualcosa di bellissimo. Il gruppo come generatore di contraddizioni continue. Commedia e tragedia che si sovrapponevano giorno dopo giorno. Fino a quando non si riusciva più a capire dove iniziava l’una e finiva l’altra. Un terreno accidentato sul quale Angelo Carotenuto si è mosso con grazia, costruendo uno dei romanzi sportivi più belli degli ultimi anni. Personaggi reali e immaginari si intrecciano insieme per raccontare la storia non solo di un club, ma di un Paese intero che in quegli anni si era riscoperto diviso. Proprio come la Lazio. Non una, ma due squadre. Un gruppo spaccato a metà e che ruotava intorno a Giorgio Chinaglia, il primo grande irregolare del calcio tricolore. I suoi devoti da una parte, gli eretici dall’altra. Nel vero senso della parola. Perché quell’insieme di calciatori che la domenica diventava improvvisamente squadra, si cambiava in due spogliatoi diversi. Una guerra civile che ha portato a risultati eccezionali ma con un costo altissimo: l’autocombustione di molti dei suoi protagonisti.
Angelo, come si scrive un romanzo ispirato a fatti realmente accaduti?
Qui servirebbe una risposta gigantesca.
Allora andiamo per gradi. Da dove si comincia?
Le Canaglie ha la struttura e la mentalità del romanzo storico, anche se è tutto sommato vicino. La fantasia invece è nelle pieghe, dove i personaggi di finzione incontrano quelli reali. Quello è il regno della fantasia pura, perché è lì che puoi inventarti l’incontro fra Re Cecconi e il mio fotografo, Marcello Traseticcio.
E come si tiene a freno la fantasia?
Io mi sono dato delle regole. Quando il mio fotografo chiacchiera con Fellini, perché hanno lavorato insieme nel periodo della Dolce Vita, le parole del regista sono tratte da alcune interviste che ha rilasciato in quegli anni. Io le ho romanzate, ma c’è un’adesione al vero anche nelle cose inventate. Usi la fantasia quando devi ricostruire una passeggiata pomeridiana, anche se c’è ormai un’ampia letteratura sulla Lazio di quegli anni. Penso alle autobiografie di Martini, di Wilson e a quelle scritte su Frustalupi, Re Cecconi, Maestrelli, ma soprattutto al libro di Guy Chiappaventi (Pistole e Palloni, Ultra Sport, 2018).
Che ruolo hanno avuto i quotidiani dell’epoca?
Ho trascorso moltissimo tempo in archivio. Credo di aver letto tutto quello che è stato scritto sulla Lazio di quel periodo. Quando facevo parlare i protagonisti reali, sia fra di loro che con quelli di finzione, sono stato molto attento a non andare sopra le righe, a non attribuirgli cose che non appartenevano al loro carattere, a non esagerare. Anche perché hanno ancora parenti e figli. E non volevo essere irrispettoso.
Nel libro usi una lingua molto interessante, in bilico fra dialetto e invenzione. Come nasce questa scelta?
Il lessico è stato il terzo livello di documentazione. Il primo ha riguardato la Lazio come squadra. Il secondo Roma città e l’Italia degli anni Settanta, che è parte integrante della storia. E poi è arrivato il linguaggio. Vedi, a me sembra che in quegli anni Roma abbia perso la sua lingua. Nel momento in cui cinema e televisione trasformano Roma in una specie di macchietta di sé stessa, il romanesco è diventato una specie di romanoide, la lingua degli improbabili, degli estremi, di cialtroni. Così si è rubata la lingua di Roma che negli anni Settanta è stata oggetto di sperimentazione e studio da parte di Pasolini e Gadda, due non romani che lavorano e riflettono sul dialetto della capitale.
Anche tu, in questo senso, hai portato avanti una sperimentazione.
Il romano era diventata una lingua chewing gum, stuprata dai prodotti dell’entertainment. Sono andato a recuperare un po’ di lessico perduto, ho riaperto vecchi dizionari, ho creato un lessico artificiale. Ci sono parole che non si sa cosa significhino ma che sono comprensibili in quel contesto.
Nel tuo libro la Lazio viene narrata anche attraverso la lente di Marcello Traseticcio, ispirato a Marcello Geppetti, un fotografo che ha seguito la Dolce Vita. Lo stacco con la realtà di quella squadra non poteva essere più netto.
Il mio Marcello racconta quella storia a quarant’anni di distanza. Il fotografo fa un lavoro di testimone, era molto utile per i fatti che dovevo mettere in fila. A differenza del giornalista, il fotografo può raccontare per immagini ed era perfetto per uno che doveva cucire insieme calcio, cronaca e politica. Ho auto la possibilità di giocare con alcune immagini molto forti di quegli anni. Ce n’è una bellissima di un ragazzino di 10 anni che si accende una sigaretta con una fiamma ossidrica. Poi c’è un altro aspetto: il fotografo dell’era pre-digitale è uno che ferma il tempo, che non può correggere lo scatto. Non può trasformare l’immagine con un trucco, un filtro. Mi sembrava molto simbolico, perché trasformava Marcello in un custode della memoria.
Quanto c’è dell’Italia di quegli anni, con i suoi mutamenti e le sue trasformazioni, in quella squadra?
Più leggevo, più mi documentavo, più le assonanze erano impressionati. Le cronache di quegli anni sono terribili, cupe, ma hanno una incredibile corrispondenza nelle vicende di quella Lazio. Il fatto che la squadra fosse spaccata in due gruppi, tanto da cambiarsi in due spogliatoi diversi, era fortemente allegorico di un’Italia divisa dai referendum, spaccata fra studenti di destra e di sinistra, fra uomini e donne con le prime rivendicazioni dal parte del movimento femminista. Alcuni giocatori sono portatori di questo parallelismo in modo molto accentuato. Nel momento in cui Martini, prima delle elezioni, dà un’intervista in cui dice che voterà per il Movimento Sociale fa una cosa molto eretica per l’Italia, dove Almirante dice in Parlamento: “O c’è giustizia o ce la faremo da soli”.
Ma quella Lazio è anche una squadra a mano armata.
Il momento in cui allestiscono il poligono e si sfidano è un’evocazione di quello che succede fuori da lì. È impressionante come a un certo punto i giornali rinuncino a dar conto delle morti casuali che avvengono per via delle armi. Le notizie frequenti e inquietanti: un padre che esce per andare allo stadio e la figlia è morta perché i bambini giocavano con le armi, un ragazzo che fa l’aiuto garagista che prende la pistola del suo superiore per gioco e ammazza il nipote. C’erano armi che giravano incustodite e seminavano lutti e morti. Ma ogni vita che si spegne diventa un trafiletto di cinque righe. Ci si arrende a un qualcosa che diventa quotidianità.
Maestrelli svia, dribbla, a volte quasi imbroglia pur di mantenere insieme i suoi ragazzi. È davvero un padre. Senza di lui ci sarebbe stata quella squadra?
Questa squadra è esistita perché è esistito Maestrelli. È una figura che per immacolatezza metto accanto a quella di Scirea. Ha delle sfumature non ingenue, ma sempre sincere, con un candore in un altro tempi. Maestrelli è un disertore dei conflitti e all’improvviso si trova in mezzo a questi due blocchi. Il suo lavoro è tenerli insieme. Penso a quanto debba essergli costato questo compito, in termini di energia e di intossicazione. È quasi un martire, è il santo del calcio italiano. La cosa che mi impressiona di Maestrelli, però, è un’altra.
Ovvero?
La Federazione aveva scelto lui per succedere a Valcareggi nel 1974, Maestrelli però nel frattempo si ammala e non se la sente di accettare. Mi impressiona tantissimo pensare che magari l’Italia sarebbe stata campione del Mondo nel 1982 con Maestrelli in panchina. Ce lo vedo benissimo al posto di Bearzot perché è un altro Bearzot, uno che cura l’idea di gruppo, di lavoro. È una figura affascinante. Anche per un mondo di estranei al calcio. È un personaggio gigantesco.
Trasformare una squadra in famiglia era l’unica possibilità di tenere insieme quel gruppo?
La commistione fra famiglia e squadra viene accettata anche da sua moglie, quando capisce che è l’unico modo per avere Maestrelli di più a casa. La moglie diventa un altro collante, con il rito della cena, con la pasta e piselli. Quando Chinaglia si accorge che i gemelli chiamato “Tato” Re Cecconi, impazzisce di gelosia. E nasce il “quinto figlio” Chinaglia. È un mondo ormai perduto, ma lo vediamo dall’atteggiamento che tanti calciatori hanno avuto durante la pandemia, quando si sono sentiti al di sopra di tutti. Quegli erano ragazzi dentro la società, sposavano ragazze conosciute al paese, non c’era ancora quell’incrocio di mondi che c’è adesso.
Chinaglia è qualcosa di inedito per il calcio italiano?
Forse è il primo grande calciatore irregolare, ma non alla Meroni, in maniera folcloristica, che porta la gallina a spasso col guinzaglio. Lui irrita, è l’annuncio di Balotelli. Chinaglia è uno che provoca gli avversari, poi dopo il Mondiale del 1974 diventa il grande nemico di tutta Italia, un capro espiatorio. Carraro lo definisce addirittura un “disadattato”. La Lazio inizia a sfaldarsi perché urlano “fascista” a Martini. E poi perché Chinaglia manda a quel paese Valcareggi. Nel campo di Tor di Quinto montano degli altoparlanti in modo che Giorgio si abitui a giocare fra i fischi, lui regala fiori agli avversari per provare a creare un nuovo clima.
Nel libro c’è un’immagine fortissima: la nonna anziana che lava i piedi al piccolo Giorgio prima di mandarlo dal padre in Galles. Quanto racconta di Chinaglia questo episodio?
Racconta tutto. È in quel modo perché ha avuto quell’infanzia. A sette-otto anni fa i conti con il fatto che il padre se n’è andato portandosi via l’altra figlia. Lui si interroga: perché ha lasciato me qui? Perché io devo crescere con la nonna? Quando la nonna lo prepara per il ricongiungimento, Chinaglia va da solo dalla Toscana al Galles. Parte verso l’ignoto, non sa nemmeno che faccia abbia suo pare. Alla fine lui non ha fatto altro che creare un altro padre, che trova in Maestrelli. E si ribella alle autorità, alle figure paterne come Lenzini e Valcareggi. Un suo vecchio collega che faceva con lui il cameriere in Inghilterra lo raggiunge in ritiro alla vigilia di Italia-Inghilterra e inizia a ricordare il passato davanti ai compagni di squadra e Chinaglia si vergogna. La sua infanzia è decisiva.
C’è una frase che mi ha colpito: “Più aumenta la quantità di calcio che vedono, più si riduce il margine di libertà con cui lo guardano”.
È una mia ossessione. Ebbi un confronto a distanza con Francesco Costa, lui che è più aperto a una cultura digitale era colpito dal fatto che le società erano diventate delle media company, che producevano da sole i contenuti multimediali. Lui contrapponeva questa cosa mondo di chi rimpiante il calcio pane e salame. Il punto secondo è questo: io non è che non veda quanto sia bellissimo oggi poter avere accesso a una serie di informazioni che negli anni Settanta ci potevamo sognare. Oggi è possibile misurare da quanti metri ha tirato in porta il mediano. È meraviglioso sapere quante volte tocca il pallone con i piedi Donnarumma. È come se il calcio ti facesse vedere più cose, ma allo stesso tempo te le facesse vedere da più lontano. Ora se un nonno vuole portare il nipotino all’allenamento non lo può fare, le squadre sono bande asserragliate dietro i cancelli, chiuse nelle loro bolle, in totale isolamento. C’è un’ossessione che rende impossibile guardare l’allenamento. Il calcio ha messo una distanza incredibile fra sé e i tifosi, senza calcolarne gli effetti. Perché se non ha prossimità alla squadra, l’avvertirà come estranea.
Angelo Carotenuto, Le Canaglie, Sellerio, 2020, 364 pagine, 16 euro.
Piacerà a: chi vuole leggere in maniera originale la storia di una squadra che è stata anche lo specchio di un Paese.
——————————————————————————-
IL TALENTO COME CONDANNA
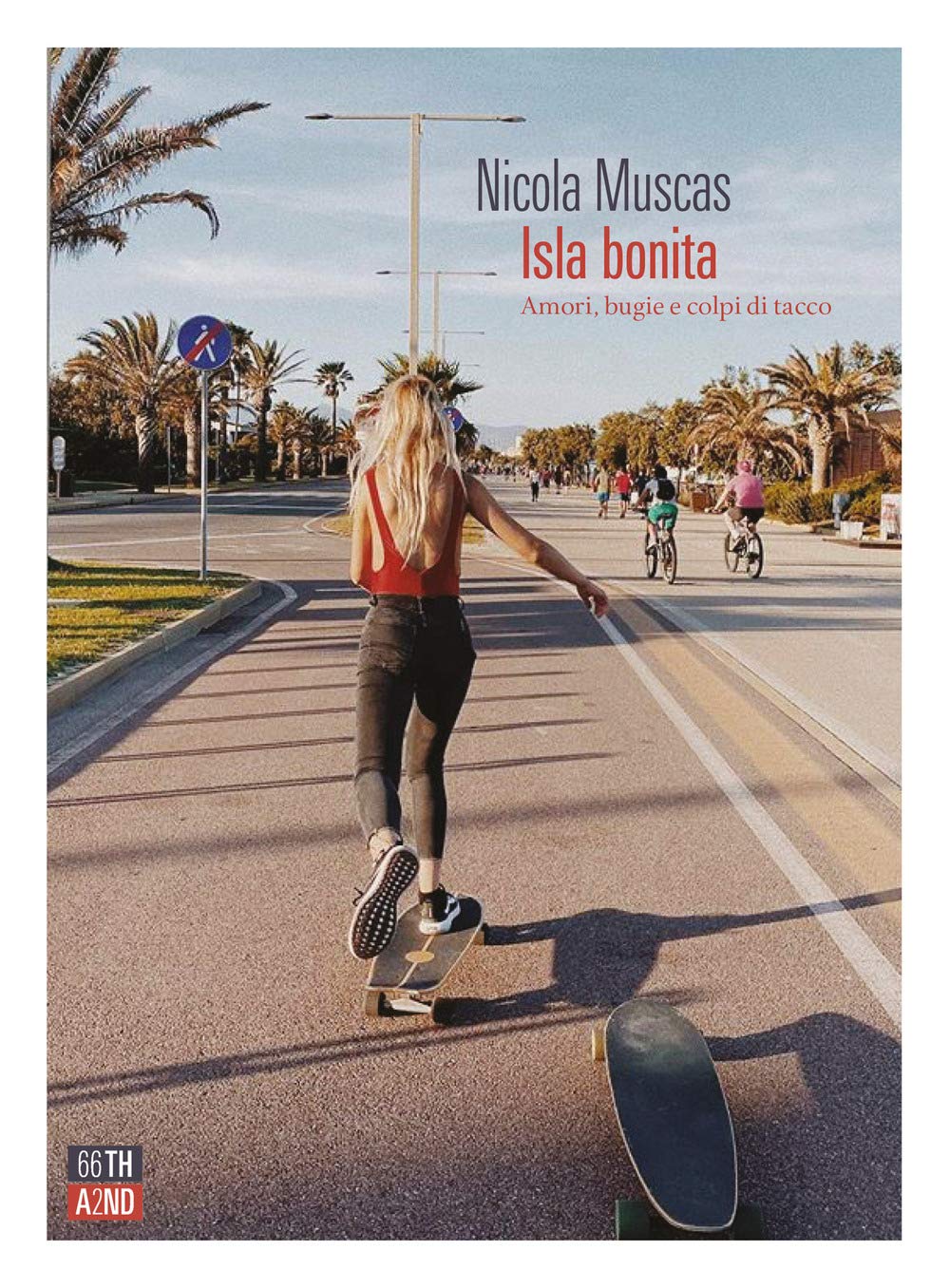 Niente è stato più frainteso del talento. In molti lo considerano un dono, una benedizione divina. Eppure spesso si rivela il suo esatto contrario. Una maledizione, una pietra legata intorno al collo capace di trascinare giù, fin dentro l’abisso. Il fondo diventa polo d’attrazione impossibile da dribblare, la polvere dell’insuccesso un dolce rifugio. È così anche per il protagonista di Isla Bonita, il sorprendente romanzo di Nicola Muscas uscito qualche settimana fa per 66thand2nd. Si chiama Santiago Ramiro Rodriguez, ma per tutti è semplicemente El Gordo, il grassone, appellativo conquistato per via della prominente pancia coltivata con generose dosi di alcool. Un freak con un genio smisurato e un talento ancora più vasto nel dilapidarlo, un derelitto che sul finire della carriera si è andato a rintanare nel suo Uruguay, dove tira avanti dimenticato da tutti tranne che dai suoi creditori. El Gordo vive per il brivido al contrario, perché la sconfitta può essere molto più inebriante della vittoria. Un concetto che diventa stella polare, filo conduttore di tutta un’esistenza. Rodriguez colleziona ex mogli e cavalli lenti. Fino a perdere tutto. D’altra parte lo diceva Ennio Flaiano: “La ricchezza è per gli altri, l’eroe ha bisogno solo di denaro“. Un inferno permanente che cambia quando da Cagliari gli offrono un’insperata remissione dei peccati. El Gordo torna in quella Isla Bonita dove anni prima era riuscito a distillare l’essenza più pura del suo calcio. Il suo corpo martoriato diventa speranza per gli altri. Il suo radioso passato diventa possibilità di illuminare un presente oscuro, tanto individuale quanto collettivo. Perché come scrive Georges Simenon in La Mano: “Ci si abitua talmente alle persone che continuiamo a vederle come le abbiamo viste la prima volta”. El Gordo stravolge le vite di tutti quelli che entrano in contatto con lui. Un re Mida al contrario che trasforma in sregolatezza tutto quello che tocca, che contamina un direttore sportivo che sembra uscito da un romanzo di Ellroy, un po’ estortore, un po’ imprenditore, un po’ gangster, un medico tormentato che diventa grillo parlante, una giornalista che scova notizie e attrae pettegolezzi. Tutto in un romanzo collettivo perfetto che avvolte il lettore e lo tiene incollato a sé. Dalla prima all’ultima pagina.
Niente è stato più frainteso del talento. In molti lo considerano un dono, una benedizione divina. Eppure spesso si rivela il suo esatto contrario. Una maledizione, una pietra legata intorno al collo capace di trascinare giù, fin dentro l’abisso. Il fondo diventa polo d’attrazione impossibile da dribblare, la polvere dell’insuccesso un dolce rifugio. È così anche per il protagonista di Isla Bonita, il sorprendente romanzo di Nicola Muscas uscito qualche settimana fa per 66thand2nd. Si chiama Santiago Ramiro Rodriguez, ma per tutti è semplicemente El Gordo, il grassone, appellativo conquistato per via della prominente pancia coltivata con generose dosi di alcool. Un freak con un genio smisurato e un talento ancora più vasto nel dilapidarlo, un derelitto che sul finire della carriera si è andato a rintanare nel suo Uruguay, dove tira avanti dimenticato da tutti tranne che dai suoi creditori. El Gordo vive per il brivido al contrario, perché la sconfitta può essere molto più inebriante della vittoria. Un concetto che diventa stella polare, filo conduttore di tutta un’esistenza. Rodriguez colleziona ex mogli e cavalli lenti. Fino a perdere tutto. D’altra parte lo diceva Ennio Flaiano: “La ricchezza è per gli altri, l’eroe ha bisogno solo di denaro“. Un inferno permanente che cambia quando da Cagliari gli offrono un’insperata remissione dei peccati. El Gordo torna in quella Isla Bonita dove anni prima era riuscito a distillare l’essenza più pura del suo calcio. Il suo corpo martoriato diventa speranza per gli altri. Il suo radioso passato diventa possibilità di illuminare un presente oscuro, tanto individuale quanto collettivo. Perché come scrive Georges Simenon in La Mano: “Ci si abitua talmente alle persone che continuiamo a vederle come le abbiamo viste la prima volta”. El Gordo stravolge le vite di tutti quelli che entrano in contatto con lui. Un re Mida al contrario che trasforma in sregolatezza tutto quello che tocca, che contamina un direttore sportivo che sembra uscito da un romanzo di Ellroy, un po’ estortore, un po’ imprenditore, un po’ gangster, un medico tormentato che diventa grillo parlante, una giornalista che scova notizie e attrae pettegolezzi. Tutto in un romanzo collettivo perfetto che avvolte il lettore e lo tiene incollato a sé. Dalla prima all’ultima pagina.
Nicola, la letteratura sportiva è piena di protagonisti irregolari, eccessivi, di freak. Il Gordo però riesce sempre a non cadere nello stereotipo. Come è nata la sua figura?
Il Gordo è stato una sfida. Per me come autore. E per tutti i personaggi del libro.
Partiamo dalla dimensione personale allora.
Arrivavo da una serie di racconti in cui mi ritrovavo bene a riprodurre una serie di situazioni familiari molto intime. Per me era facile rendere l’idea di una cena di natale, di uno zio particolare, di un cugino sopra le righe. Ma facevo fatica sulla lunga distanza, a trasformare tutto questo in un romanzo. Il Gordo mi ha permesso di alzare l’asticella.
Nel libro, invece, stravolge tutte le vite contro cui va a sbattere.
Esatto. Mi sono chiesto: cosa succede nella vita persona normale se l’eccezionale entra a gamba tesa nel suo quotidiano? Tutti i personaggi affrontano un cambiamento, ognuno finisce il proprio percorso in modo molto diverso da come era iniziato. Perché si sono dovuti confrontare con le proprie paure, le proprie ambizioni, i propri sogni.
Il Gordo assomiglia molto al Magico Gonzalez. Altri calciatori che ti hanno ispirato?
La letteratura sugli irregolari è sterminata. Io ne cito tre: Maradona, ovviamente. Poi Paul Gascoigne. La storia dei baretti del Poetto dove viene ripescato il Gordo assomiglia a quella del centrocampista inglese che, durante i Mondiali del 1990, a 23 anni, fugge dal ritiro della Nazionale e va a bere in questi chioschetti. Lo riprendono per i capelli, ma quando scende in campo riesce a fare la differenza. Il più somigliante, però, è Fabián O’Neill, uno che ha sperperato davvero 14 milioni di euro, uno che ha parlato di donne veloci e cavalli lenti, che vivacchia in un bar di Montevideo. Mi sono chiesto: cosa sarebbe riuscito a fare se avesse avuto una seconda possibilità?
Dove nasce questo rapporto speciale fra Cagliari e l’Uruguay?
Ormai dai primi anni Novanta sono diventati una trentina gli uruguaiani che hanno vestito la maglia del Cagliari. E molti sono stati tutt’altro che indimenticabili. Ogni volta, però, scocca sempre quella scintilla che porta a Enzo Francescoli. Era una storia incredibile. Una squadra neopromossa che acquista il secondo giocatore più iconico del Sudamerica. Sono arrivati lui, Fonseca ed Herrera e il Cagliari è finito in Europa. Ma ci sono stati una dozzina di uruguaiani importanti: Nandez, anche se il suo senso di appartenenza è piuttosto discutibile, Godin, Lopez, O’Neill. È un lungo filo rosso che passa attraverso il calcio e ha a che fare con la qualità della vita. La Sardegna è come un Uruguay scagliato in mezzo al mare, sta all’Italia come l’Uruguay sta all’Argentina.
Il Gordo è un elemento imprevedibile, una scheggia impazzita, in un calcio iper controllato come quello di oggi. Secondo te c’è ancora spazio per giocatori di questo tipo?
Chissà, forse se hai vissuto quello che ha vissuto il Gordo non è così assurdo, il denaro diventa importante solo nella misura in cui devi assicurare un futuro a tuo figlio. È sempre il tempo delle schegge impazzite, anche se questo lo è sempre di meno. Poi se hai un direttore sportivo come Firicano, che è andato a pescare il Gordo alla fine del mondo, allora tutto è possibile. La prima scheggia impazzita del libro è proprio Firicano.
La tua è stata una scelta molto coraggiosa: inserire personaggi veri all’interno di un libro di fantasia. Come hai fatto a dosare questi due elementi?
Fossimo stati al cinema sarebbe stato tutto più complicato, invece la letteratura ti consente di spingerti oltre. Quando tutto si muove su un piano satirico non ti costa nulla ingaggiare Buffon, perché non sei costretto a pagargli un cachet. Ho seguito la mia verosimiglianza. C’è una scena in cui il Gordo e Buffon fanno quasi a pugni. Non è così irreale che due uomini di 35 anni vengano alle mani per una donna.
Il talento viene sempre visto come un dono. Ma in realtà assomiglia più a una condanna?
Questo libro è anche una riflessione sul talento. Inteso come dono, ma anche come fardello. Il Gordo vuole solo una cosa: essere libero. E ha solo un modo per liberarsi da questa catena: sperperare il proprio talento. Si fa fatica ad avere vent’anni con tanta pressione e tanti occhi addosso. Mi interessava scavare su questo tema, perché da Maradoniano sono sempre stato convinto di una cosa: il dolore degli atleti viene derubricato a capriccio. E non c’è niente di più falso.
Quali sono stati i tuoi riferimenti letterari nella scrittura di Isla Bonita?
Spesso mi domandano degli autori sudamericani, quelli che sono riusciti a parlare di calcio il maniera sublime. In realtà durante questi anni di letture il mio nume tutelare è stato uno scrittore scozzese contemporaneo, John Niven. Lui è formidabile nel creare dei personaggi cinici, delle canaglie senza appello con cui è difficile empatizzare. Solo che poi hanno delle scintille di umanità che le rendono meravigliose.
Un po’ come il tuo personaggio di Firicano.
Sì, devo dire che su di lui ho lasciato una parte del mio cuore. Un po’ perché l’ho fatto napoletano e io sono napoletano da parte di madre. Poi mi ha portato alla scoperta di un universo inesplorato, di continenti lontani che ritrovi nel libro.
A volte sembra quasi un personaggio di Ellroy, un po’ gangster, un po’ estortore, un po’ imprenditore.
Lui incarna il potere, anzi una visione satirica della vacuità del potere. Se pensi quello che ha fatto la Juventus per tesserare Luis Suarez qualche tempo fa. Gli esimi professori dell’Università di Perugia non hanno guadagnato un solo euro per truccare l’esame. Questo perché il calcio ti seduce con le copertine, con la sua area patinata. Però poi ti chiede in cambio in favore e ti senti in dovere di accettare. Firicano è un personaggio un po’ sorrentiniano, un po’ iperbolico. E ha sorpreso anche me.
Muscas Nicola, Isla Bonita, 66thand2nd, 2021, 327 pagine, 17 euro.
Piacerà a: chi vuole leggere un romanzo piacevole e coinvolgente, ma non per questo frivolo.
——————————————————————————-
VIAGGIO AL CENTRO DELL’OSSESSIONE
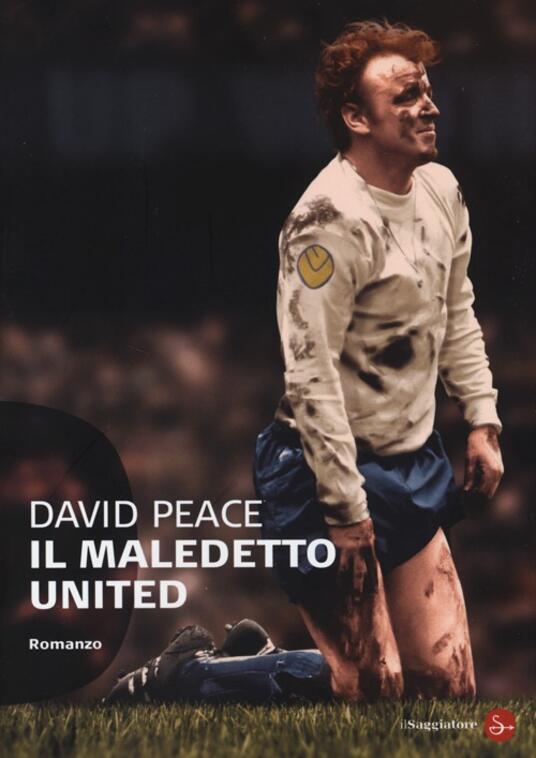 Vertiginosa, soffocante, ossessiva. La scrittura di David Peace è estremamente polarizzante. O la si ama o la si detesta. Senza mezze misure, senza sfumature. Eppure quello stile sincopato e incalzante era l’unico modo per raccontare il tormento che un personaggio come Brian Clough si è portato dietro nei suoi quarantaquattro giorni da allenatore del Leeds United. Un romanzo che è un viaggio emozionale verso il centro della fissazione di un mister diventato santone: trasformare il Leeds del suo predecessore Don Revie nel suo Leeds United. Un piano troppo ambizioso che trasformerà Clough in un moderno Icaro.
Vertiginosa, soffocante, ossessiva. La scrittura di David Peace è estremamente polarizzante. O la si ama o la si detesta. Senza mezze misure, senza sfumature. Eppure quello stile sincopato e incalzante era l’unico modo per raccontare il tormento che un personaggio come Brian Clough si è portato dietro nei suoi quarantaquattro giorni da allenatore del Leeds United. Un romanzo che è un viaggio emozionale verso il centro della fissazione di un mister diventato santone: trasformare il Leeds del suo predecessore Don Revie nel suo Leeds United. Un piano troppo ambizioso che trasformerà Clough in un moderno Icaro.
Peace David, Il Maledetto United, Saggiatore, 2009, 408 pagine, 18 euro
Piacerà a: chi ha voglia di leggere un libro diventato ormai un classico grazie a uno stile di scrittura unico.
——————————————————————————-
LA COMMEDIA DEL CALCIO
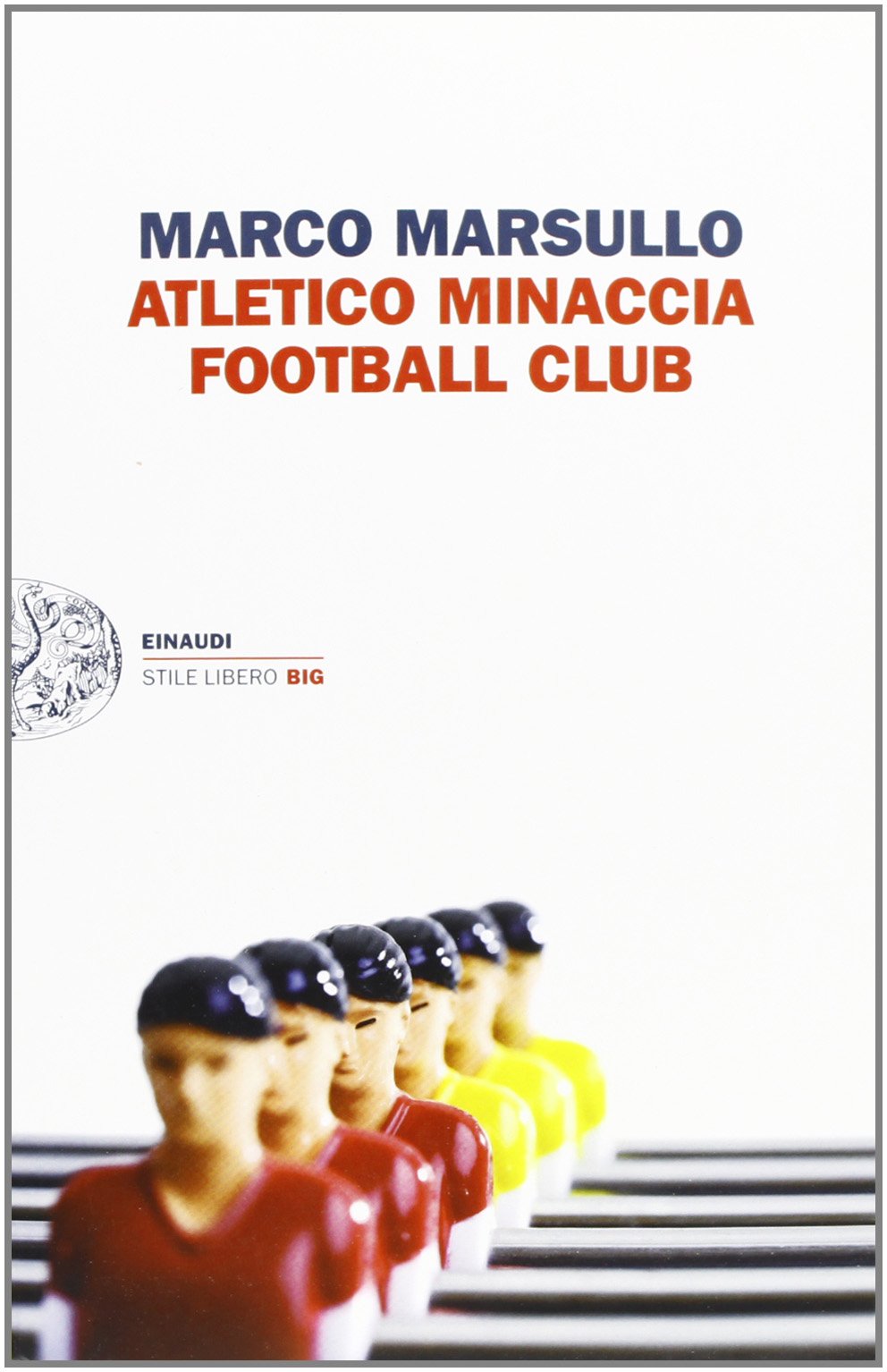 Un libro che si porta dietro un merito importante. Perché Atletico Minaccia Football Club è stato uno dei primissimi romanzi a nobilitare la vena letteraria del calcio. E lo ha fatto in modo molto particolare, andando a raccontare il mondo polveroso delle periferie del pallone, destinate ad allontanarsi sempre di più dal centro. È su quel palcoscenico sgangherato che si muove Vanni Cascione, un allenatore col mito di José Mourinho e una carriera da esonerato seriale nelle categorie più basse del calcio campano. Fino a quando non gli viene offerta la panchina dell’Atletico Minaccia Football Club, con la promessa di acquisti di spessore che si trasformerà in una realtà molto diversa. “Ho sempre pensato che non c’era un romanzo che raccontasse il calcio – ci ha detto Marco Marsullo – era un paradosso. Perché un Paese che viveva di calcio lo considerava non romanzabile? Io volevo raccontare le periferie, le categorie inferiori, le storie di questi calciatori del sud Italia, dell’umanità che c’è dentro una squadra, soprattutto quando non ci sono superstar. E poi volevo raccontare un allenatore di provincia, con le su fissazioni e le sue manie. Sono quelli i mister che ti rimangono dentro”. E ha ragione.
Un libro che si porta dietro un merito importante. Perché Atletico Minaccia Football Club è stato uno dei primissimi romanzi a nobilitare la vena letteraria del calcio. E lo ha fatto in modo molto particolare, andando a raccontare il mondo polveroso delle periferie del pallone, destinate ad allontanarsi sempre di più dal centro. È su quel palcoscenico sgangherato che si muove Vanni Cascione, un allenatore col mito di José Mourinho e una carriera da esonerato seriale nelle categorie più basse del calcio campano. Fino a quando non gli viene offerta la panchina dell’Atletico Minaccia Football Club, con la promessa di acquisti di spessore che si trasformerà in una realtà molto diversa. “Ho sempre pensato che non c’era un romanzo che raccontasse il calcio – ci ha detto Marco Marsullo – era un paradosso. Perché un Paese che viveva di calcio lo considerava non romanzabile? Io volevo raccontare le periferie, le categorie inferiori, le storie di questi calciatori del sud Italia, dell’umanità che c’è dentro una squadra, soprattutto quando non ci sono superstar. E poi volevo raccontare un allenatore di provincia, con le su fissazioni e le sue manie. Sono quelli i mister che ti rimangono dentro”. E ha ragione.
Marsullo Marco, Atletico Minaccia Football Club, Einaudi, 2013, 224 pagine, 17 euro.
Piacerà a: chi cerca il calcio raccontato come grande commedia.
Articolo Precedente
Ti ricordi… Il sindaco Marco Osio, primo (e unico) italiano ad aver giocato in Brasile dopo i fasti col Parma di Scala

Articolo Successivo
Cassano contro Immobile: “Non sa giocare, ha paura. Non vuole la palla, gli scotta”







