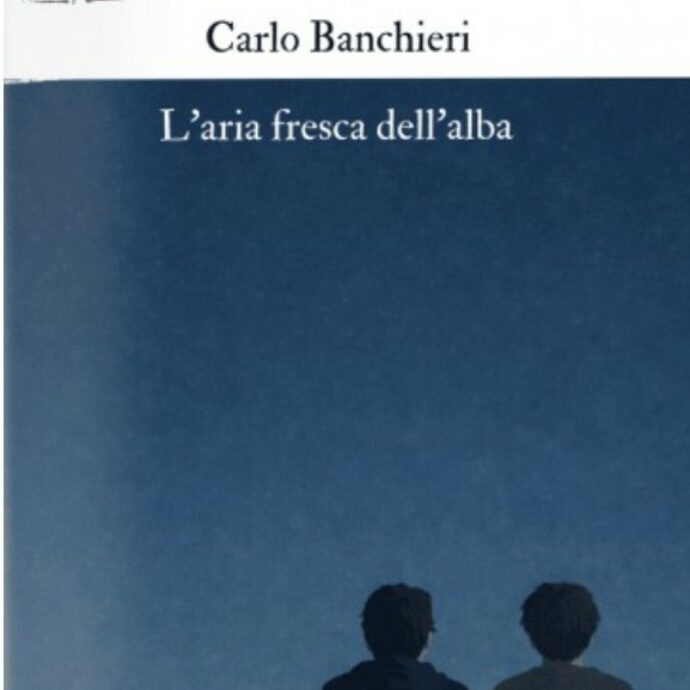C’è qualcosa di spudoratamente immorale nella vana necessità di ascesa sportiva di Conor Niland. Il tennista irlandese autore di Quasi farcela (Mondadori), definito dai più il libro contraltare di Open di André Agassi, è l’esempio classico di chi vive in conscia mancanza di principio di realtà. Niland come un criceto in gabbia corre per oltre vent’anni nella sua bella ruotina dei tornei minori – Futures e quando va bene Challenger – e grazie alle sue sconfitte sui campi di mezzo mondo, al suo non esplodere mai, al non scalare mai realmente il ranking del tennis, alimenta quel sistema ipercompetitivo e disumanizzante che per sopravvivere nell’iperuranio dell’evento divora gli atleti mediocri, scarsi, subalterni, scagliandoli ogni volta sul fondo, esanimi, moribondi come una prova di Squid Game.
Niland affronta la sua biografia umana e sportiva così come ha giocato a tennis: mai memorabili volée o ace, ma nemmeno mai riflessioni apodittiche o dogmatiche. Quasi farcela è la quintessenza di una possibile fluidità professionale. Chi nasce tondo non muore quadrato. E se non fosse per il papà che pianta il campetto di tennis nel giardino di casa, che pretenderebbe un’eccellenza sportiva familiare, il piccolo Conor chissà cosa avrebbe fatto nella vita. Oggi, ad esempio, smessi i panni del tennista professionista mai sbocciato, è capitano della squadra di tennis irlandese di Coppa Davis che è un po’ come la comitiva giamaicana alle Olimpiadi invernali. Lo schema di Niland, narrativo e sportivo, perché evidentemente non ha scritto questo libro per raccontare balle, è sempre più o meno lo stesso: primo turno passato, secondo schiantato. Con una variante: schiantato al primo turno. Per chi non sapesse quanto è elitario il tennis, ricordiamo che diventare “professionisti” è mera questione di etichetta, e di risparmi familiari, mentre per entrare concretamente nei primi 100 nomi del ranking dell’APT tour (quelli con l’accesso diretto ai vari Wimbledon, Roland Garros, Us Open, ecc..) bisogna macinare una quantità infinita di vittorie negli incontri Challenger (tra il 100 e il 300esimo posto nel ranking, alloggi confortevoli e premietti in denaro) e ancora prima nei Futures, un girone infernale che raccoglie a strascico anche autentici bidoni, ovviamente senza rimborsi di viaggio, alloggi disumani, vitto inesistente e accordatori di racchette a pagamento (spesso gli stessi tennisti).
Ebbene tra la fine degli anni novanta e il primo decennio dei duemila, dopo una puntatina alla scuola prestigiosa e milionaria di Nick Bollettieri in Florida (dove scambia dritto e rovescio con le sorelle Williams ancora in fasce), la laurea in California e relativi tornei universitari (quello cruciale l’ha perso), Conor si sbatte come un matto tra campi e campetti della Thailandia, Australia, Stati Uniti, paesi arabi, stati dell’est Europa per raggranellare punti e salire nel ranking. Una specie di inesausto lambiccarsi attorno a un’ambizione, un tentativo dilatato di stare a galla, un limbo prolungato dove si va molto giù e poco su. Una situazione pratica in cui se ti va bene (leggi denari) hai un allenatore privato (che ti segue qualche volta) e/o un munifico finanziatore (Conor riesce pure a trovarlo, ma viene da lui lasciato dopo essere stato squalificato per aver lanciato con rabbia una pallina e abbattuto un giudice di linea); dove non c’è tempo nemmeno di allenarsi perché il tempo si usa per prendere aerei (ci pensa sempre mamma a pagare), spostarsi improvvisamente in auto (il tour fantozziano in Ubzekistan è una cartolina umana di ironico pregio) e guadagnare al netto di viaggi, alloggio e multe in campo talvolta anche solo una manciata di dollari. Lo spiega in modo chiaro l’autore: “una carriera tennistica professionale si basa su una scommessa definitiva terrificante: ogni giocatore di successo pregiudica la propria infanzia per raggiungerlo, ma lo stesso vale anche per chi non ce la fa”. Se pensate che a 12 anni Niland aveva battuto Roger Federer 7-5, 6-2. “Picchiava forte e sbagliava di tanto”.
Poi Roger mise la freccia e Conor rimase a piedi. C’è nella carriera perduta del protagonista un momento di rara disperane ed euforica bellezza. Quando per riuscire a trovarsi pronto ad entrare nelle partite di qualificazioni degli Australian Open giunge a Melbourne attendendo che qualcuno si ritiri. Così, senza nemmeno sapere se giocherà, se riuscirà, Niland viene chiamato cinque minuti prima del match dall’altoparlante per poi perdere clamorosamente il match. Al diavolo la ripetitività dell’allenamento nei singoli dettagli (Bollettieri gli aveva anche dato un ottimo suggerimento sulla battuta), il tennis è si uno “sport fatto di errori”, ma la realtà di chi sta sotto è quella di correre in solitaria per non marcar visita il giorno dopo su un campo di Dubai o vattelapesca. Usura fisica e mentale che porta Niland nel 2007 ad un infortunio all’anca che sembra il punto partita. Ma nel 2010 ecco la rinascita. Sale fino al 129esimo posto nel ranking e si qualifica finalmente per Wimbledon 2011. Il 21 giugno “alle 14.17 nel minuscolo campo 17, dopo quasi ventinove anni di tennis, ho effettuato il mio premio servizio a Wimbledon”. È il “giorno più lungo”, quello del match con Adrian Mannarino: Niland parte avanti 1 a 0, poi si fa superare dal francese sul 2 a 1, pareggia di nuovo i conti 2 a 2, ma alla fine capitola a rete sbagliando una volée di rovescio (“il peggior colpo del mio arsenale”) dopo quattro ore di match infuocato. “Consiglierei ai miei figli di diventare tennisti professionisti?”, chiosa Niland nel libro. “Penso di no, ma poi vedo Emma (una delle sue figlie ndr) correre verso di me trascinandosi la sua racchetta bianca e arancione e non resisto”.