Richiamato per aver detto ‘Free Palestine’: la libertà di espressione ai tempi del genocidio
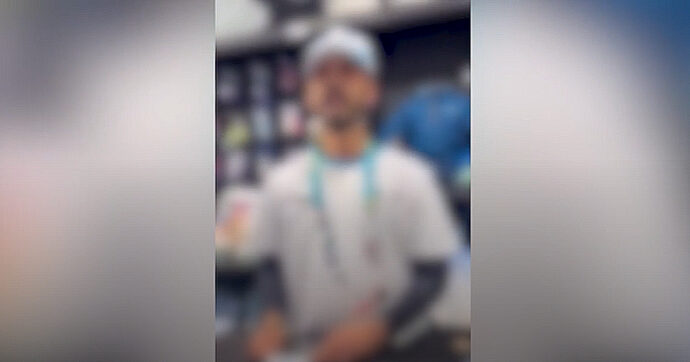
Febbraio 2026. Vanno in scena le Olimpiadi invernali Milano-Cortina. Un gruppo di tifosi israeliani entra in uno degli store ufficiali del grande evento sportivo. Sventola la bandiera di Israele. Di fronte a questa scena, Ali Mohamed Hassan, uno dei dipendenti, risponde con un semplice “Free Palestine”. Per qualcuno, però, un messaggio di sostegno all’autodeterminazione di un popolo sottoposto da due anni al dramma di un genocidio non deve poter esistere.
Malgrado l’articolo 1 della legge 30/1970, vale a dire dello Statuto dei Lavoratori, statuisca che “i lavoratori […] hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero”, si scatena una campagna contro il lavoratore. Viene immediatamente accusato di antisemitismo (per dire “Free Palestine”: ma davvero facciamo?), identificato e, secondo alcune fonti, licenziato. Per fortuna, fuori dai media ufficiali e dalla politica istituzionale, l’onda di solidarietà con Ali Mohamed Hassan sta crescendo rapidamente.
Facciamo ora un passo indietro nel tempo.
Torniamo al 4 maggio 2025: siamo al Teatro alla Scala di Milano. A non troppa distanza dalle Olimpiadi in corso. C’è una riunione della Asian Development Bank. In programma un concerto privato, alla presenza della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Prima che l’evento abbia inizio, il silenzio viene rotto da un grido: “Palestina Libera”. A urlarlo è una lavoratrice a tempo determinato, una maschera del Teatro.
Diventa subito un “caso”. Il Teatro, senza pensarci su due volte, la licenzia. Per “giusta causa”, sostiene, perché si sarebbe rotto il vincolo di fiducia e perché quel “Palestina Libera” costituirebbe un “danno d’immagine”. La lavoratrice non ci sta. Sostenuta dal sindacato Cub, impugna il licenziamento.
Saltiamo alla fine di novembre 2025. Sono trascorsi sei mesi dall’episodio. Il Tribunale del Lavoro di Milano emette la sentenza: condanna il Teatro alla Scala per licenziamento illegittimo e gli intima di risarcire la lavoratrice di tutte le mensilità arretrate, dal giorno del licenziamento fino alla scadenza del contratto a termine.
Se con questa sentenza si chiude – almeno per il momento – la vicenda individuale della lavoratrice della Scala, prosegue invece quella collettiva. Perché questi due episodi ci dimostrano che quello che succede a Gaza non ha a che fare “solo” con la Palestina. Riguarda tutti noi. È qui, a casa nostra, che stanno provando a restringere la nostra libertà di espressione. Sui posti di lavoro, come succede ad Ali Mohamed Hassan. Com’è accaduto meno di un anno fa alla lavoratrice alla Scala.
Come succede a Francesca Albanese, sottoposta a sanzioni Usa per aver osato fare i nomi e cognomi di chi dal genocidio israeliano ci guadagna e oggi vittima di una campagna di manipolazione e killeraggio professionale da parte di diversi Paesi europei, tra cui quello di cui è cittadina, l’Italia. La sua “nazione”.
Nel corpo della società tutta, con i progetti di legge della Lega per permettere di vietare le manifestazioni per la Palestina. Con i disegni di legge sull’antisemitismo, presentati tanto dalle destre quanto da pezzi del centrosinistra (vedi ddl Delrio), con cui vogliono mettere il bavaglio a ogni critica mossa a Israele.
Ad Ali Mohamed Hassan andrebbe consegnata una medaglia. Perché con il coraggio che ha mostrato, con la determinazione a ripetere quel “Free Palestine” di fronte all’arroganza di chi, provocatoriamente, gli intimava “say it again” (“dillo di nuovo”), tiene alto l’onore del nostro Paese, della nostra Patria (come preferirebbe dire qualcuno), che, invece, le istituzioni politiche, economiche e mediatiche hanno posto dal lato del genocidio di Tel Aviv.
Oggi, più di ieri, gridiamo anche noi Free Palestine. E ribadiamo che urlarlo, come aveva già stabilito il Tribunale del Lavoro di Milano, non è reato. Anzi: è un grido di dignità e libertà. Quella del popolo palestinese, ma anche la nostra.



