Trovare dati precisi, aggiornati e completi sul funzionamento dei servizi per interruzione volontaria di gravidanza in Italia è un’impresa ardua. Chiunque l’abbia tentata – incluso ilfattoquotidiano.it – ha sperimentato qualcosa di molto simile all’avventura di Asterix e Obelix nel palazzo della burocrazia, la dodicesima delle loro celeberrime fatiche. Anche Chiara Lalli e Luisa Montegiove ci hanno provato, con pazienza e ostinazione. Ed anche loro hanno fallito nel tentativo di completare il puzzle: troppi i pezzi mancanti. Ma questa volta il racconto dell’impresa è diventato un libro che testimonia in modo puntuale i motivi per cui, allo stato attuale dell’arte, l’impresa non sarebbe potuta andare diversamente: il sistema stesso è fatto in modo che questi dati si perdano nella selva dei circuiti amministrativi: sono, appunto, mai dati.
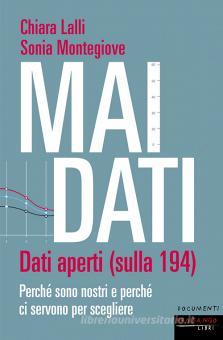 L’indagine Mai Dati, Dati aperti (sulla 194) – Perché sono nostri e perché ci servono per scegliere è stata pubblicata da Fandango Libri lo scorso 1 giugno. Le autrici testimoniano di più di trecento invii tramite posta elettronica certificata, secondo la procedura di “accesso civico generalizzato” per la quale ogni cittadin* ha diritto all’accesso ai dati della pubblica amministrazione (decreto legislativo 33/2013). Qual è il numero totale e il numero degli obiettori per ginecologi, anestesisti, professioni sanitarie non mediche? Le autrici lo hanno chiesto a centottanta tra aziende sanitarie e ospedaliere tutte quelle in cui si dovrebbe poter praticare l’interruzione volontaria della gravidanza. Il condizionale è d’obbligo, perché di queste strutture non esiste una banca dati completa, aggiornata, geolocalizzata e in formato aperto. Tra le risposte pervenute in tempi brevi (ma spesso incomplete), quelle pervenute dopo solleciti, quelle mai pervenute, il processo di raccolta è andato avanti mesi, da agosto 2021 a marzo 2022… «Bisogna avere molto tempo libero e parecchia ostinazione, oppure lasciar perdere e riprodursi» commentano Lalli e Montegiove. Alla fine, scrivono le autrici, le risposte ricevute, anche quelle più complete e corrette rispetto alle domande poste, sono vecchie e oggi potrebbero essere diverse.
L’indagine Mai Dati, Dati aperti (sulla 194) – Perché sono nostri e perché ci servono per scegliere è stata pubblicata da Fandango Libri lo scorso 1 giugno. Le autrici testimoniano di più di trecento invii tramite posta elettronica certificata, secondo la procedura di “accesso civico generalizzato” per la quale ogni cittadin* ha diritto all’accesso ai dati della pubblica amministrazione (decreto legislativo 33/2013). Qual è il numero totale e il numero degli obiettori per ginecologi, anestesisti, professioni sanitarie non mediche? Le autrici lo hanno chiesto a centottanta tra aziende sanitarie e ospedaliere tutte quelle in cui si dovrebbe poter praticare l’interruzione volontaria della gravidanza. Il condizionale è d’obbligo, perché di queste strutture non esiste una banca dati completa, aggiornata, geolocalizzata e in formato aperto. Tra le risposte pervenute in tempi brevi (ma spesso incomplete), quelle pervenute dopo solleciti, quelle mai pervenute, il processo di raccolta è andato avanti mesi, da agosto 2021 a marzo 2022… «Bisogna avere molto tempo libero e parecchia ostinazione, oppure lasciar perdere e riprodursi» commentano Lalli e Montegiove. Alla fine, scrivono le autrici, le risposte ricevute, anche quelle più complete e corrette rispetto alle domande poste, sono vecchie e oggi potrebbero essere diverse.
Qual è il senso di imbarcarsi in un’impresa simile? Intanto perché i numeri forniti dalla Relazione ministeriale sull’applicazione della legge 194/78, se da un lato descrivono nel dettaglio il profilo delle pazienti, dall’altro non dicono nulla di quello che accade nei servizi cioè non consentono di valutare la congruità della prestazione sanitaria, che va misurata in relazione al territorio dove è erogata e non sulla base di calcoli statistici come fa attualmente il Ministero della salute. Misurare la qualità dei servizi offerti dalle aziende sanitarie dovrebbe essere un loro obbligo istituzionale. Si chiamano o no aziende? Se sono considerate tali, allora le loro utenti sono stakeholder, interlocutrici portatrici di interessi verso cui tali aziende hanno dei doveri. Inoltre, sulla base di dati aperti e aggiornati si potrebbero costruire mappe che consentirebbero alle donne di sapere in quali strutture si può abortire. E si potrebbero facilmente segnalare le strutture inadempienti, considerando che la legge 194 (art. 9) obbliga gli ospedali e le strutture accreditate a fornire il servizio.
I dati delle pubbliche amministrazioni sono un bene comune. Lo mette nero su bianco la nostra legislazione, che con una serie di provvedimenti (del 2003, 2013, 2019) recepisce la direttiva europea sugli open data: i dati della pubblica amministrazione devono essere aggiornati, accessibili e aperti, cioè disponibili in formato tale da essere riutilizzabile per il calcolo. Dovrebbero anche essere contenuti linkabili, spiegano le autrici, cioè collegati tra loro in modo tale che una macchina che possiede dati e regole ben definite ne possa dedurre nuova conoscenza. In Italia, però, la «cultura del dato» – così la definisce Giorgia Lodi, tra le maggiori esperte di open data nazionali, intervistata da Lalli e Montegiove – non è diffusa e l’ambito di cui stiamo parlando non è l’unico ad esserne afflitto. Visto lo stigma che avvolge l’aborto, tuttavia, l’impatto di questo deficit è particolarmente significativo. Gli esempi virtuosi a cui ispirarci esistono, scrivono le autrici, facendo riferimento alla Spagna, che pubblica i suoi dati sul sito, o all’Inghilterra, che li pubblica sul proprio.
La necessità di aggiornare i metodi di raccolta e di diffusione dei dati sulla interruzione volontaria di gravidanza è stata oggetto anche della campagna #datibenecomune, che raccoglie 57.991 firmatari e 286 organizzazioni promotrici per chiedere a Governo e Parlamento dati aperti e machine-readable sui principali temi di interesse dei cittadini e delle cittadine. Nel merito dell’IVG, le organizzazioni hanno posto al Ministero della salute una serie di richieste puntuali che consentirebbero di smantellare quel palazzo della burocrazia che porta sull’orlo dell’esasperazione non solo chi fa indagini per mestiere ma anche chi si trova ad affrontare una interruzione volontaria di gravidanza. L’accesso all’informazione non è un vezzo o un capriccio ma parte integrante del diritto alla salute, come specificato anche dalle più recenti linee guida sull’aborto della Organizzazione mondiale della sanità.
Articolo Precedente
Violenza sulle donne, l’Onu contro l’Italia: “Nel sistema giudiziario del Paese stereotipi sessisti”.

Articolo Successivo
L’unione civile della carabiniera con la sua compagna: è la prima cerimonia in uniforme con picchetto d’onore







