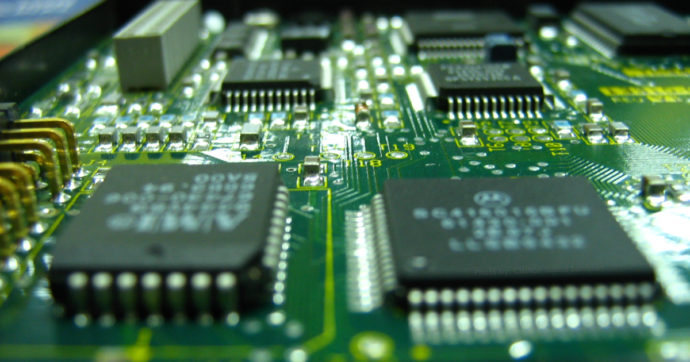Cina, Stati Uniti, Giappone, Unione europea hanno lo stesso sogno che non realizzeranno: l’autosufficienza nella produzione di semiconduttori. Per avvicinarsi all’obiettivo sono però pronti a spendere centinaia di miliardi di dollari, sperando almeno di ridurre la loro dipendenza da Taiwan e Corea del Sud, fucine globali dei preziosi quadratini di silicio. Sempre più richiesti, a fronte di un’offerta che fatica a recuperare i ritardi accumulati in periodo di pandemia. Ormai indispensabili per una lunga di produzioni, dall’auto alle telecomunicazioni fino alle le nuovi fonti energetiche e le reti infrastrutturali di nuova generazione.
Nei mesi di lockdown gli impianti hanno funzionato a ritmi ridotti mentre cresceva la richiesta di apparecchi elettronici per lavorare da casa. I magazzini si sono svuotati. Ora che la ripresa economica è innescata e gli ordini piovono da tutte le parti, i (pochi) big faticano a tenere il passo. La penuria diventa campo di gioco per schermaglie geopolitiche e così si cerca di correre ai ripari per recuperare il tempo perduto. Viene alla mente il paragone con il gas o il petrolio ma c’è una differenza fondamentale che smonta l’accostamento. I fossili sono dove sono e lì restano, i “giacimenti” di semiconduttori si possono, con il tempo, creare o ricostituire. Nel frattempo giganti come Apple, Google ed Amazon, ormai economicamente paragonabili a delle nazioni, provano a riposizionarsi da soli, i miliardi non mancano.
Quello dei chip è uno dei settori più globalizzati al mondo. I microprocessori vengono disegnati in un paese, prodotti in un altro, testati e montati in un altro ancora. Una filiera che ottimizza costi e capacità ma che rende vulnerabili i singoli paesi. Negli ultimi vent’anni si è assistito ad una migrazione delle fabbriche da Ovest verso Est. La quota europea della produzione globale si è dimezzata, scendendo al 10%. Una discesa frutto di delocalizzazioni, esternalizzazioni e ripensamenti della filiera. Non troppo diverso quello che è accaduto negli Stati Uniti, un tempo leader globali, oggi con una fetta di mercato del 12% (dal 37% di 25 anni fa).
L’Europa parte di rincorsa ma non sconfitta. “Non si tratta di inventare qualcosa di nuovo ma di recuperare quello che si è perso. Le competenze ci sono e in questo l’Italia è messa meglio di molti altri paesi europei, anche grazie alla presenza nel paese di St (gruppo italo francese che produce semiconduttori, partecipata anche dal Tesoro, ndr)”, spiega a Ilfattoquotidiano.it Giuseppe Iannaccone che insegna elettronica all’università di Pisa. “Negli anni ’80 la società privata taiwanese Tsmc (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) si è proposta al mercato con un nuovo modello di business che ha cambiato radicalmente le cose. Produrre chip per soggetti terzi, senza commerciarli né progettarli. Una strategia che ha pagato e che ha portato alla società taiwanese volumi produttivi sempre più elevati”, ricorda Iannaccone.
Oggi Tsmc vale quasi il 5% di tutta l’economia taiwanese e produce chip per mezzo mondo, inclusi gruppi americani come Intel, Tesla, Apple e Qualcomm. Da qui escono anche i chip montati sui jet F35 in dotazione alle forze armate di molti paesi Nato, Italia inclusa. “Per l’Europa non si tratta di inseguire un irraggiungibile modello Taiwan, costruito nel tempo e con un ecosistema tecnologico di contorno molto difficilmente replicabile, quanto piuttosto di far crescere quello che già abbiamo”, sottolinea il professore. “Tentare di accorciare la catena produttiva è un obiettivo importante che tuttavia va perseguito con realismo, ponendosi una scadenza decennale e focalizzandosi sulle produzioni dei semiconduttori più necessarie per la manifattura europea, ossia quelle per l’auto, le energie rinnovabili e la meccanica avanzata. Una maggiore collaborazione tra paesi Ue potrebbe aiutare a fare massa critica sui volumi produttivi e quindi rendere più conveniente la creazione di nuovi stabilimenti”.
Come dimostrano i continui stop delle catene di montaggio che stanno affliggendo praticamente tutti i marchi, uno dei settori più dipendenti dall’approvvigionamento di semiconduttori è l’auto. Oggi i chip rappresentano circa il 4% del costo di una vettura. Nel 2030, man mano che le macchine si evolvono tecnologicamente, incideranno cinque volte tanto. Secondo le previsioni del produttore tedesco Infineon il valore medio dei microprocessori montati su un’ auto dovrebbe infatti passare dagli attuali 170 dollari (143 euro) ad oltre 1.200. Discorso simile per gli smartphones che con la diffusione della più potente rete 5G, necessiteranno di più microprocessori, rispetto ai 20 che già montano i telefonini. E previsioni non troppo diverse si possono replicare in molti settori, meccanica compresa ossia la spina dorsale dell’industria italiana. Così i big delle quattro ruote stanno cercando di rinsaldare e stringere i legami con i produttori dei preziosissimi quadratini di silicio. E arrivano le prime risposte, Nvidia pensa di destinare 8 miliardi di dollari per potenziare la divisione che si occupa di chip destinati alle quattro ruote, Intel di rafforzare le sue produzioni irlandesi dedicate.
La Commissione europea si è posta il fine di raddoppiare la produzione entro il 2030. Parte degli 800 miliardi di euro del programma Next Generation Eu dovrebbero supportare questo intento. Il colosso statunitense Intel ha fiutato l’affare e si è detto disponibile ad investire in Europa circa 80 miliardi di euro in dieci anni per costruire nuovi stabilimenti che, in sostanza, pagherebbero in buona i governi europei. In lizza tra i possibili sito di insediamento c’è anche Mirafiori sebbene al momento Francia, Olanda e Belgio appaiano avvantaggiate come potenziali destinazioni. Il presidente francese Emmanuel Macron ha tentato di “sedurre” il numero uno di Intel Pat Gelsinger ricevendolo nella reggia di Versailles. Intel è, peraltro. un caso paradigmatico dell’evoluzione di molte società del settore, sempre meno concentrate sulla produzione e sempre di più su operazioni finanziarie finalizzate ad aumentare il valore delle azioni a beneficio di soci e manager. Di soldi per rimettere in piedi l’industria ne servono tanti. Una nuova fabbrica costa circa 10 miliardi di dollari (8,5 miliardi di euro) richiede circa due anni per diventare operativa e soprattutto ha bisogno di volumi sufficienti per ripagare l’investimento. La voce “semiconduttori” compare anche nel nostro Piano nazionale di ripresa e resistenza. La prima versione del Pnrr era, almeno sulla carta, un po’ più energica nel sostegno al settore. La seconda versione vidimata dal governo Draghi indica un possibile stanziamento di 750 milioni di euro, poca cosa.
Giovedì scorso, intervenendo all’assemblea annuale di Confindustria, Mario Draghi ha annunciato uno stanziamento supplementare di 700 milioni di euro la cifra affermando che “L’aumento delle vendite di elettronica e la crescente incidenza di queste componenti nell’industria automobilistica hanno provocato gravi carenze che non sono destinate a attenuarsi. L’importanza dei semiconduttori aumenterà infatti con la digitalizzazione e la mobilità elettrica. Il governo ha in programma importanti investimenti nella filiera microelettronica. Siamo impegnati a sostenere la ricerca e ad attrarre investimenti sul settore, perché le innovazioni sui semiconduttori possano provenire anche dall’Italia e dall’Europa”.
All’estero non stanno certo a guardare. Solo nel 2020 la Cina ha speso 35 miliardi di dollari per sovvenzionare la sua industria di semiconduttori che rimane peraltro ancorata alla produzioni di chip meno avanzati di quelli taiwanesi. Pechino vorrebbe arrivare al 2025 con la capacità di realizzare il 70% dei semiconduttori che utilizza. Quasi certamente non ci riuscirà ma lo sforzo continua. La Corea del Sud pianifica investimenti per 450 miliardi di dollari con lo scopo di rafforzare ulteriormente la sua posizione nel settore. Nella penisola asiatica ha sede ed opera il colosso Samsung che, a sua volta, ha messo a bilancio 116 miliardi di dollari da spendere entro il 2030 per allargare la gamma produttiva di semiconduttori.
Più timide, per ora, le mosse di Washington che pure ha inserito l’autosufficienza tra le priorità strategiche del paese. La Casa Bianca ha messo sul piatto 50 miliardi di dollari e la precedente amministrazione Trump si era assicurata un investimento di 12 miliardi da parte di Tsmc per creare un nuovo stabilimento in Arizona. Attenta a non alterare i delicati equilibri su cui prospera il gruppo di Taiwan ha annunciato nuovi impegni anche in Cina. Sempre in Arizona Intel pianifica di investire 20 miliardi di dollari. Cifre importanti ma l’autosufficienza è su un altro pianeta. Secondo una stima della Semiconductor Industry Association, tagliare qualsiasi legame con l’estero avrebbe per gli Usa un costo di 1.400 miliardi di dollari. Un bel grattacapo per Washington, mentre gli attriti con Pechino, che da sempre guarda con bramosia alla vicinissima Taiwan, si fanno più aspri e saranno il grande tema geopolitico dei prossimi decenni.
Intanto, i pochi che possono permettersi di farlo, iniziano a muoversi da soli. Tutti i big del web, che vantano capitalizzazioni pari al Pil di paesi come Italia o Francia, stanno studiando delle mosse di riposizionamento. Nessuno tra Google, Amazon, Apple o Facebook ha in mente di fare tutto da sé ma tutti hanno intenzione di portare “in casa” alcuni passaggi della filiera dei chip. Google vorrebbe produrre la Cpu dei suoi pc Chromebook, Apple internalizzare il design dei microprocessori emancipandosi da Intel, Amazon (che insieme a Microsoft è anche uno dei primi fornitori si spazi e servizi cloud al mondo) ridurre la dipendenza da Broadcom. Nella stessa direzione si muovono anche Facebook e Tesla.
Articolo Precedente
Riciclaggio, in Europa un’azienda su 100 collegata a Paesi in blacklist. Ecco i nostri “paradisi” dove la trasparenza è un optional

Articolo Successivo
Crimine di impresa, la legge lo punisce ma attuare la normativa è tutt’altro che semplice