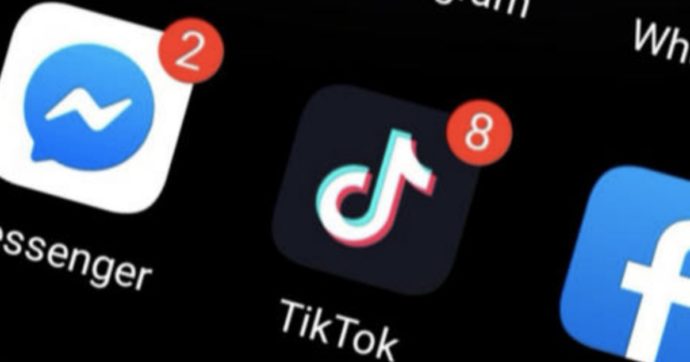La morte di una ragazzina di dieci anni, soffocata da una cintura, non può lasciare indifferente nessun maestro, soprattutto se a causare questa tragedia potrebbe essere stato un gioco, una sfida raccolta in Rete su uno dei tanti social network che i bambini e i ragazzi usano nonostante il divieto d’iscrizione a chi ha un’età inferiore ai 13 anni.
Come sempre in questi casi, ho atteso qualche giorno prima di dire la mia. Ho letto su diversi quotidiani gli autorevoli pareri di psicoterapeuti, psicologi, scrittori e colleghi giornalisti: uomini e donne che “studiano” la società, che esaminano dati, che osservano gli eventi e sanno leggerli con gli strumenti della psicologia ma che, forse, non vedono un bambino e una classe di bambini da un po’ di tempo.
Chi sta, come noi insegnanti, in aula ogni giorno fa un’altra lettura. Non dico che sia migliore o peggiore ma è differente. Il medico e psicoterapeuta Alberto Pellai, intervistato su La Stampa dall’amico Federico Taddia, in maniera imperativa dice: “Bisogna avere il coraggio di vietare il web ai bambini”. Nella mia classe, su 22 ragazzini di quinta, quasi la metà ha TikTok, gli altri usano Instagram, alcuni hanno Facebook.
Vietare l’uso dei social è anacronistico. I social non sono il diavolo. In questa nostra epoca pensare di buttare fuori dalla Rete i nostri ragazzi è un’illusione, una fantasticheria. E’ impossibile pensare che i nostri bambini tornino solo a giocare a nascondino per le strade o a calcio al campetto dell’oratorio. E’ un’altra epoca, che ci piaccia o no. Tra l’altro non può essere una tragedia come quella avvenuta a Palermo a etichettare i social network. Bisogna, invece, educare i nostri ragazzi a usare in maniera responsabile e civile la Rete. E ancor prima: abbiamo l’urgenza di tornare ad educare alle regole, alla comprensione di esse, affinché possano essere rispettate e amate.
Nella mia classe nelle scorse settimane abbiamo ospitato Raffaele Capperi, un ragazzo di 26 anni nato con la sindrome di Treacher Collins, una malattia congenita dello sviluppo craniofacciale, che grazie a TikTok è riuscito a raccontarsi, a creare una comunità, a denunciare il cyberbullismo. I miei alunni in quell’occasione hanno avuto modo di parlare con lui sull’uso dei social network e hanno compreso che può essere altro che una passerella di balletti.
In un’altra classe nei giorni scorsi ho spiegato Michelangelo e come fare una scultura attraverso una saponetta: la settimana successiva, senza che io lo suggerissi, Giulia mi ha mostrato come avesse tradotto la mia lezione facendone una lei su YouTube.
Vietare i social a questa generazione creerebbe solo una sorta di gusto del proibito. Una delle soluzioni possibili è invece quella di chiedere la creazione di social network dedicati ai ragazzi, ai bambini, dove le aziende controllino i contenuti e eliminino i pericoli che si possono insidiare in essi.
Sono d’accordo, in parte, con Gian Luca Nicoletti quando dice che “il problema non è TikTok”. Nicoletti, sempre su La Stampa, richiama invece i genitori al loro dovere di sorvegliare. In teoria il collega giornalista ha ragione, ma la pratica di maestro mi racconta di mamme e papà che non sanno accendere un personal computer, oppure di genitori che sono attivissimi su Facebook ma non sanno attivare un filtro per la privacy, oppure ancora di genitori che manco si occupano dei compiti dei loro figli. Figuriamoci di un social. Nicoletti dimentica la povertà culturale del nostro Paese che noi maestri ben conosciamo.
C’è poi chi come lo scrittore Ferdinando Camon dalle pagine dell’Avvenire ci racconta che “i ragazzi non sanno cosa vuol dire morire”. Ora anche in questo caso bisogna conoscere bene i bambini. Certo a sei, sette anni non hanno la percezione dell’abbandono totale, eterno; ma a otto, nove, dieci anni hanno ben chiaro cos’è la morte. Per tutto il mese di gennaio nella mia classe abbiamo ospitato due psicologhe del Niguarda proprio per parlare di morte con i ragazzi e le loro risposte non hanno lasciato dubbi e interpretazioni.
Infine un ultimo passaggio. Antonella, la bambina di dieci anni di Palermo morta soffocata dalla cintura, abitava in via Schiavuzzo, nel cuore del quartiere “La Kalsa” di Palermo. Conosco come le mie mani quelle strade e tante altre di una città che amo profondamente e dove andrei a vivere domattina. Ciò che è avvenuto è accaduto in un contesto sociale e culturale poverissimo. Non possiamo celare questo dato di contesto che, invece, ci richiama ancora una volta alla mancata attenzione che c’è per questi luoghi, abbandonati da Dio (se esiste) e dagli uomini.
La teoria di Nicoletti (genitori che sorvegliano) in questo caso è un fallimento: il papà di Antonella è un muratore e la mamma una casalinga con tre figli e uno in arrivo. Pensiamo davvero che questa mamma e questo papà avessero gli strumenti per intervenire sull’uso del social da parte della loro piccola?
Ciò non significa che una simile tragedia non possa accadere ad un bambino ricco, ma noi abbiamo bisogno di un’attenzione maggiore a questa fascia di popolazione e ai bambini di quelle strade.
Articolo Precedente
‘Basta politically correct’ e poi fanno discorsi reazionari. Da che parte stare?