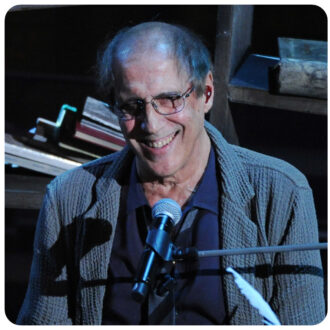È un romanzo epistolare, potete leggerlo qui, ogni sabato. L’ho intitolato “Vodka siberiana”. Sono lettere. Lei scrive al suo alter ego. E racconta. Racconta anni irripetibili, epici, paurosi. Siamo alla fine degli anni 90. In un piccolo centro del Sud. C’è un parco. Ci sono bevitori dell’est. Avventurieri, vagabondi, ex qualcosa, cekisti, stalinisti, criminali, malati di una ferocia chiamata: nostalgia. C’è il primo grande passaggio, quasi biblico, di carovane umane, dall’Est all’Ovest. L’Occidente pingue è impreparato. È il caos. Il parco è un teatro mirabolante di tragicità e vita sprezzante e foriera dell’archetipo umano, la vita, la morte. E poi è la storia di un amore. Non sto qui a dire che tutto si paga, che mai racconterò ciò che non si conosce.
Vodka Siberiana (Lettere) – Ho fatto quel che ho potuto
Quando attraversi il grande parcheggio, ti concedi alcune riflessioni, sono sempre le stesse. Ti scrivo io, stavolta. Non ti prometto: ti amerò di più. Io non ti so amare, ho provato. Ho fatto quel che ho potuto. Guardi la casa dei morti. Un tempo era un rudere. Oggi appartiene alla collettività. E la trasformazione ti induce a pensarla prossima alla noiosa nomenklatura di un insieme civile. Ti invito a osservarla. Tu la conosci. Ne hai scritto. Ora sei stufa marcia, vero? Ogni tanto guardi su al piano della creaturina. È morta. Ricordi il professore? In maniche di camicia, scrivevi. Parlavate delle cose del cielo, ma anche del mondo eccome. E c’erano i rom, Sofia, Anita, Altana, Oscar. Fumavate, nuvole di fumo sparse per la casa. Un vero caos.
Avevi 25 anni.
Il professore era malato. La schizofrenia era controllata e in lui era intelligenza, bizzarria colta, folgorazione. Indossavi un vestito giallo, che comprendeva una gonna più ampia e lunga a righine chiare. Ti piaceva più di tutti. Fumavi orribili sigarette, economiche, maschili potrei aggiungere. Servivi la sera, ai clienti di un club dall’aria decadente, con il grammofono sui dischi della Piaf, tende pesanti alle porte finestre. Il venerdì c’erano i marinai russi e un capitano di mezza età ti invitava a ballare e tu accettavi.
Hai fatto quel che hai potuto. Una vocazione allo slavismo, letture disordinate, la tendenza ad isolarti, la vanità acerba, confusa. Eri così. Oggi attraversi il grande parcheggio, da lontano sorprendi la donna seduta in attesa del suo compagno. Giovane polacco. Ha i capelli bianchi, gli occhiali spessi e rigati in corrispondenza dell’occhio sinistro, ma ha una voce da ragazza. Anche tu hai una voce da ragazza. La desolazione ha avuto ragione sulla vostra stessa esistenza. Non dovete riassumerla tutte le volte. Non c’è per questo una mostrina da guadagnarci o un premio da intitolarvi. Tu hai deciso di incoraggiare Lucia nella follia di quell’amore, è un po’ perdonarti. Giusto? Se lui beve, non è detto che non la ami.
Le siedi accanto. Non le parli di nulla. Solo il tuo desiderio rimane sospeso. Il tuo desiderio non succede mai. Se provi a raccontarle, lei come ogni donna adulta che conosci, capisce subito la fregatura del mondo, e la fregatura del mondo di solito riguarda ogni tua faccenda.
Da ragazza leggevi i russi, tanto da esserne contagiata nell’indole tragica che avrebbe debordato in laconiche avventure, dall’esito amarissimo. Patetico e amarissimo. Non i russi del tedio civile e dissidente di un under celebrato come un ex zek, zek o gli internati dei gulag. Hai letto Solczenicyn soltanto per realizzare il mortifero fallimento di una balla. Il realismo sociale russo, una balla. Non garantiva un proscenio nemmeno ai poeti più ardimentosi o ispirati. L’elegia atea. Lo scriveva Kundera. Ma oggi apprendi – nelle nuove letture – l’interessante epopea metafisica, la celebrazione universale del fallimento alticcio e comunista, nella persona di Venedikt Erofeev, “La mosca nella vodka”, tripudio solitario e orgiastico della zapoj, la lunga ubriacatura russa. È un sonno infinito, crudelissimo. Usi gli assoluti. Ti sei affezionata ai superlativi.
Tendi a non star ferma con i pensieri. Che oscillano. È la nuova fase. Da ragazza non immaginavi di superare una soglia. Ma sei diventata una madre. La soglia non l’hai ancora superata, tuttavia non disperi. A tratti, disperi.
Il professore ti esortava a rifarti una vita. Si dice così, ma sono suoni tutto sommato. Il professore stava chiuso tutto il giorno nella sua stanza, leggeva i naturalisti francesi, la radiolina accesa. La creaturina pregava, anche per te. Preghiamo. Pregherò per te. E tu eri lieta, meno oppressa dal destino pesante quasi quanto un castigo. Eppure di quel castigo per anni hai considerato la grandezza di un amore, l’unico, pensavi. Oggi sai che non lo era, non nella reciprocità. Cosa sia la reciprocità, non fu mai un problema, fino a oggi. Oggi che pretendi di ottenerla, un dazio, il giusto, il dovuto. È mio. Pretendi. Ad ogni pallido esemplare di qualcosa, pretendi: è mio.
Preghi tu oggi per gli altri. Non tanti, quelli che ricordi. A qualcuno lo prometti: pregherò. Come la creaturina, certe volte, prometti una preghiera.
(continua)
Copyright © Veronica Tomassini
Articolo Precedente
Caine, come nasce una canzone in carcere: le detenute di Salerno e Pozzuoli lo raccontano, su RaiTre

Articolo Successivo
Poesia, la risposta intelligente alla quarantena è un’opera collettiva