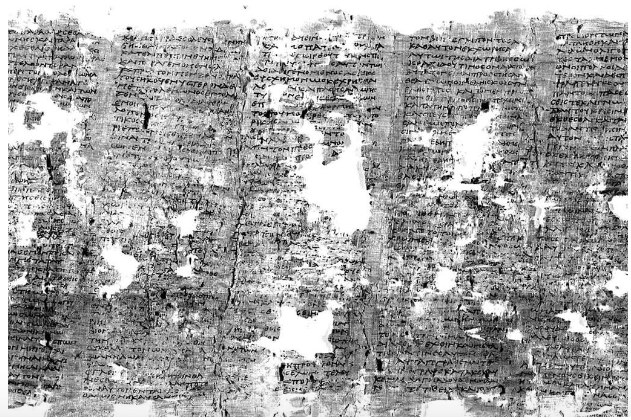Il Dolce della Liberazione aveva gli aromi del tabacco e del whisky per evocare l’arrivo degli americani mentre l’Antipasto in marcia era la tipica merenda dei combattenti, quel pane e salame da mangiare mentre si cammina. Per chi voleva stare più leggero c’era l’Insalata delle bande liguri mentre i più rivoluzionari non potevano esimersi dai Cappelletti Bastonati, chiamati così perché durante il Ventennio gli squadristi facevano irruzione nelle case per bastonare chi celebrava il  Primo Maggio gustando i cappelletti antifascisti. Restituire un corpo alle donne e agli uomini della Resistenza, calandoli in una dimensione quotidiana di sopravvivenza: è l’obiettivo di Partigiani a tavola: storie di cibo, resistenze e ricette di libertà di Lorena Carrara e Elisabetta Salvini (Fausto Lupetti Editore). Le due ricercatrici indipendenti – la prima studiosa di cultura dell’alimentazione, la seconda storica di genere e politiche per le pari opportunità – hanno raccolto 70 ricette, dai piatti di cucina povera alle pietanze liberamente ispirate alle memorie della Resistenza. Ogni dettaglio è inquadrato in una cornice storica dove condividere il cibo – o meglio, ingredienti ripetitivi che, come in un girone dantesco, erano sempre uguali a se stessi tra polenta, castagne, legumi e minestre – diventava un gesto politico, visto che lo si poteva mangiare con i fascisti, i combattenti partigiani o vendere al mercato nero.
Primo Maggio gustando i cappelletti antifascisti. Restituire un corpo alle donne e agli uomini della Resistenza, calandoli in una dimensione quotidiana di sopravvivenza: è l’obiettivo di Partigiani a tavola: storie di cibo, resistenze e ricette di libertà di Lorena Carrara e Elisabetta Salvini (Fausto Lupetti Editore). Le due ricercatrici indipendenti – la prima studiosa di cultura dell’alimentazione, la seconda storica di genere e politiche per le pari opportunità – hanno raccolto 70 ricette, dai piatti di cucina povera alle pietanze liberamente ispirate alle memorie della Resistenza. Ogni dettaglio è inquadrato in una cornice storica dove condividere il cibo – o meglio, ingredienti ripetitivi che, come in un girone dantesco, erano sempre uguali a se stessi tra polenta, castagne, legumi e minestre – diventava un gesto politico, visto che lo si poteva mangiare con i fascisti, i combattenti partigiani o vendere al mercato nero.
Fatte le valigie per cercare i testimoni della Resistenza, nell’Italia dei piccoli centri gli aneddoti arrivavano alle orecchie delle due autrici con la stessa rapidità con cui alle tavole partigiane si versavano bicchieri di vino rosso. Come “la storia di quei 35mila bambini nutriti dalle donne emiliane nell’inverno del ’45 – racconta Lorena Carrara – La partigiana Teresa Noce, reduce dai campi di concentramento, aveva fatto nascere questo progetto proprio partendo da quelle lasagne che aveva tanto spesso sognato nel lager”. Ed è un primo piatto a diventare un festeggiamento anche a Gattatico, in provincia di Reggio Emilia, dove nel 1943 la famiglia Cervi – per festeggiare la caduta del regime – portò in piazza 380 chili di maccheroni al burro. “Era un momento di fame e miseria e la pasta era diventata un lusso – continua l’autrice di Parma – Un’enorme ‘pastasciuttata’ collettiva che, da allora, si ripete ogni 25 luglio”. Un registro inusuale per parlare della Resistenza. “Volevamo un taglio immediato e diretto – raccontano le autrici – Tanto che il nostro ‘lettore zero’ è stata un’amica di 15 anni, per accertarci di poter portare questo racconto anche nelle scuole, dove ormai il 25 aprile si è ridotto a essere un giorno di vacanza”.
Come mangiavano i partigiani? Male e in fretta. “Un tratto caratteristico era l’uniformità – continua la ricercatrice – Quando si riusciva a requisire camion destinati ai fascisti erano costretti a consumare quel prodotto per mesi. Il cibo non si poteva certo sprecare e allora si ingegnavano a cucinare lo stesso ingrediente in infiniti modi. Abbiamo testimonianze, per esempio, del consumo ossessivo di pecora, prosciutto e castagne”. C’era poi il desiderio, tra i combattenti del fascismo, di tornare a mangiare “lentamente” o di potere cucinare il proprio cibo, visto che spesso lo si mangiava crudo perché si dovevano evitare fuochi e fumi. Quando poi le derrate iniziavano a scarseggiare, cresceva l’attesa degli aviolanci degli alleati che, come una manna moderna, “facevano cadere dal cielo alimenti, medicinale e armi”, precisa Carrara. Una volta prese le derrate queste venivano consegnate ai cuochi, uomini o donne che fossero. Perché le partigiane, una volta salite in montagna, rifiutavano di cucinare per i compagni, per non aderire allo stereotipo della donna in cucina. “Queste donne sono state delle autentiche rivoluzionarie – commentano le autrici – Lì, per la prima volta, hanno mangiato accanto agli uomini, alla pari. Hanno assaporato una società radicalmente diversa, su cui poi hanno basato le rivendicazioni del Dopoguerra”.
“Prima viene lo stomaco, poi la morale”, per citare Bertolt Brecht. Eppure quella dei partigiani sembrava una “fame allegra, un vuoto di stomaco lancinante che veniva riempito da ideali di uguaglianza e di riscatto – continua Carrara – Dividendo il poco cibo a disposizione con gli altri antifascisti, si andava lentamente costruendo una società nuova, fatta da uomini e donne, intellettuali e operai che mangiavano insieme, senza distinzioni di ceto e di genere. Una cosa mai vista prima”.
Una storia, quella del nostro passato di Resistenza, che sembra indicare la direzione verso cui muoverci anche oggi, “quando le immagini dei migranti nell’isola di Lesbo o a Idomeni” ci dovrebbero far riflettere su come “dare il cibo a chi lo chiede sia un gesto di pregnanza etica fondamentale”. Ripercorrere il rapporto dei partigiani con il cibo, infatti, “ci ha fatto pensare come l’unica risposta che ci possa accomunare, nella complessità dell’oggi, è il ritorno ai gesti semplici e umani. Magari intorno a una tavola”. Perché in fondo, la parola compagno, deriva dal più genuino dei gesti: condividere il pane.