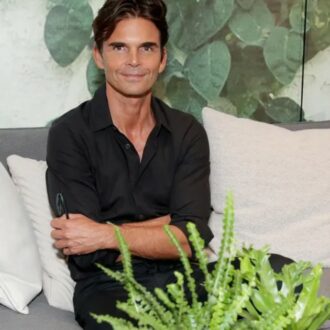Dell’ultimo atto della terribile vicenda di Denise Pipitone – sul quale, nella sostanza, non c’è nulla da aggiungere alle considerazioni composte e corrette della famiglia – c’è un aspetto che mi colpisce nel modo in cui si è prodotto. Al cento di questa vicenda, per come è nata e come finora si è sviluppata, c’è un protagonista: la televisione, un certo tipo di televisione.
C’è in Russia un programma televisivo, dal titolo molto esplicito, Lasciamoli parlare, in cui una giovane senza famiglia, uscita dall’orfanotrofio e da una serie di vicissitudini, confessa il suo desiderio di ritrovare la madre. C’è una telespettatrice che scorge nella giovane una somiglianza con la madre di Denise Pipitone e, facendo un rapido conto con la biografia di Denise, pensa che la giovane protagonista del disperato appello in Russia possa essere la bimba scomparsa misteriosamente 17 anni fa a Mazara del Vallo. E, a chiudere il cerchio televisivo aperto su una rete televisiva russa, si rivolge al programma televisivo italiano che è l’antonomasia di queste situazioni: Chi l’ha visto? A nessun’altra istituzione, a nessun’ altra organizzazione, solo alla televisione.
In un momento così delicato e senza dare affatto per scontata una risoluzione del caso, mi sono tornate in mente le polemiche che accompagnarono la nascita e i primi successi del programma ora condotto da Federica Sciarelli. Si dibatteva all’epoca sull’importanza e sui limiti di quella che si chiamava “tv verità”, sulla legittimità di sostituirsi ad altre istituzioni, di risolvere col telefono “gialli” rimasti senza colpevole, di trovare persone che erano scomparse e forse non volevano farsi trovare. Un conflitto tra i diritti a volte opposti a cui aveva dato il suo contributo di originale saggezza un esperto di televisione come Beniamino Placido.
Ora, a distanza di tanti anni, quel tipo di televisione è normalmente considerato un residuo del passato, una routine per un pubblico di anziani affezionati, mentre la tv del presente e del futuro ha assunto ben altre forme di produzione e di consumo legate alle piattaforme, allo svincolamento della fruizione dalla logica dell’appuntamento con il palinsesto di una rete generalista. Poi accade che uno di questi vecchi, vecchissimi appuntamenti torni al centro dell’attenzione e, scoprendo esperienze affini che si trovano in un’altra parte del mondo, diventi risolutivo per decifrare un enigma che potrebbe aver assunto una dimensione internazionale. E allora ci obbliga a ripensare all’idea stessa di televisione, alla sua essenza, che non si identifica solo con Netflix.
Articolo Precedente
Leonardo, ecco cosa c’è di vero e cosa no nella fiction di Rai 1: l’immotivata e disgraziata invenzione storica

Articolo Successivo
Porta a Porta, Bruno Vespa va su tutte le furie e sbotta contro l’ospite: “C’è un limite a tutto, lei deve essere radiato”