EPiC, il film di Baz Luhrmann che riporta Elvis sul palco come mai visto prima
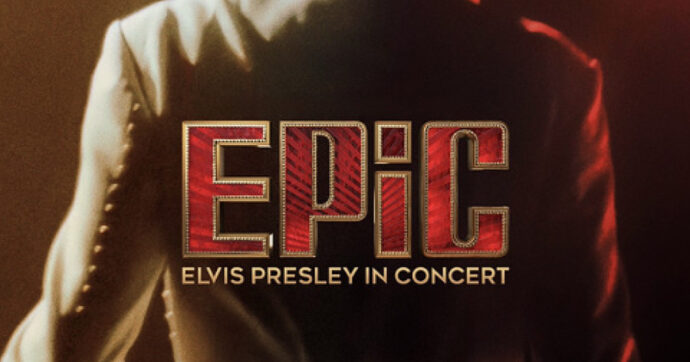
 Nel 2026 fare un altro film su Elvis Presley è un atto che oscilla tra l’incoscienza e l’arroganza. È come voler incidere per l’ennesima volta Hound Dog sperando che qualcuno abbia ancora bisogno di sentirla. Di Elvis si è detto tutto: il ragazzo bianco che canta come un nero, il soldato, l’attore intrappolato nei filmetti balneari, il re in tuta bianca che si consuma sotto i riflettori di Las Vegas. Ogni epoca si è presa il suo Elvis, lo ha masticato e risputato sotto forma di icona pop, reliquia kitsch o martire dello show business. E allora la domanda era semplice: che senso ha? Cosa resta da scoprire?
Nel 2026 fare un altro film su Elvis Presley è un atto che oscilla tra l’incoscienza e l’arroganza. È come voler incidere per l’ennesima volta Hound Dog sperando che qualcuno abbia ancora bisogno di sentirla. Di Elvis si è detto tutto: il ragazzo bianco che canta come un nero, il soldato, l’attore intrappolato nei filmetti balneari, il re in tuta bianca che si consuma sotto i riflettori di Las Vegas. Ogni epoca si è presa il suo Elvis, lo ha masticato e risputato sotto forma di icona pop, reliquia kitsch o martire dello show business. E allora la domanda era semplice: che senso ha? Cosa resta da scoprire?
Baz Luhrmann non è uno che si presenta in punta di piedi, non lo ha mai fatto e infatti fin dagli esordi ha trasformato il cinema in una pista da ballo: macchina da presa che gira come una trottola impazzita, montaggio che non concede tregua, costumi e scenografie che sembrano urlare “guardami”… il suo è un cinema che prende il melodramma e il musical, li scuote e poi li rimette in scena sotto una luce nuova. Post-moderno, si dirà, ma l’etichetta serve a poco: Luhrmann è uno che ama il travestimento e la collisione tra epoche.
Con EPiC: Elvis Presley in Concert, in uscita il prossimo 5 marzo, fa qualcosa di ancora più rischioso. Non racconta Elvis da fuori, non lo osserva come fenomeno sociologico, ma prova a mettersi dietro i suoi occhi(ali), a farlo parlare. A farlo cantare e raccontare la propria storia con la propria voce, pescando tra materiali rimasti per anni nei caveau: negativi dimenticati, pellicole 8mm, audio inediti. Non è una semplice operazione di restauro, ma il tentativo di spostare il punto di vista. E qui il film trova la sua forza perché quando esci dalla sala hai la sensazione fisica di aver assistito a un concerto. Non a un biopic, a un concerto. Elvis non è raccontato, è presente. Suda, si muove, scherza, domina il palco con quella combinazione di controllo e abbandono che lo ha reso unico.
Luhrmann insiste su un aspetto preciso: la frustrazione. Il bisogno di essere riconosciuto per la propria grandezza, anche al cinema. Elvis voleva essere preso sul serio, non solo come fenomeno da classifica e in questo c’è qualcosa di profondamente umano: il desiderio di non essere ridotti alla caricatura di se stessi. Il film lo mostra mentre combatte contro l’immagine che lo ha reso celebre. C’è però un’assenza che pesa: l’autodistruzione resta sullo sfondo. Il lato oscuro, l’eccesso che diventa dipendenza, la fragilità che si trasforma in abisso, vengono appena sfiorati. Elvis qui è quasi sempre il ragazzo perfetto: look sgargiante, capelli impomatati, sorriso che scioglie le platee. Il mito è intatto, forse troppo. Come sempre, la leggenda prevale sull’uomo quando l’uomo diventa scomodo.
Eppure, nonostante questa scelta, l’operazione funziona anche grazie alla colonna sonora di Jeremiah Fraites. I mix rinnovati, i medley che assemblano frammenti noti per generare qualcosa di diverso, non tradiscono il materiale originario ma lo rilanciano. EPiC rimette Elvis sotto una luce abbagliante, coerente con l’estetica del suo regista. Si può discutere sulle omissioni, sulle scelte narrative, sulla tendenza a proteggere l’icona. Ma nel 2026, contro ogni previsione, un nuovo film su Elvis riesce ancora a farti sentire il peso di una voce che riempie lo spazio. E quando le luci si accendono, per un attimo, hai l’impressione che il Re non sia un fantasma ma una presenza viva, ancora capace di occupare il centro del palco.



