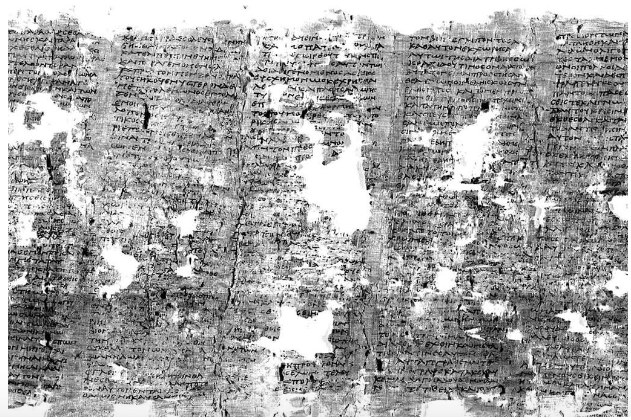“Ove olezzano tepide e molli / L’aure dolci del suolo natal” canta il coro dolente sul palco. “Del Giordano le rive saluta” scandisce dietro le quinte, appassionato, l’attrezzista mentre gira una manovella che avvolge un telo. “Di Sionne le torri atterr…” non si trattiene la sarta trasognata mentre è lì che cuce e intravede un angolino della ribalta. La interrompe un povero uomo di fatica del teatro che cerca di riportare l’ordine: “Ma qui cantano tutti!”. Subito dopo la sarta, scatenata, riattacca trascinata da un richiamo irresistibile e a pieni polmoni: “Oh mia patria sì bella e perduta!”. Canta il coro, cantano le maestranze, cantano violinisti e violoncellisti mentre suonano. Questo spezzone di Verdi – ultimo lavoro di Renato Castellani per la Rai, che quarant’anni fa si chiamava sceneggiato e oggi si chiamerebbe serie tv – a prima vista può sembrare un po’ una scenetta struggente da presepino e buona novella. Eppure ci si trova dentro un segmento del misterioso codice genetico che lega il teatro (nel senso della forma d’arte) e i teatri (nel senso proprio dei luoghi in cui si recita) all’Italia e agli italiani: è la chiave per capirne storia, geografia, psicologia di massa, antropologia culturale, mode, caratteri, tendenze, gusti di ieri, di oggi e chissà se di domani.
 E questo assume senso assoluto quando si tratta di recitare cantando, poiché l’opera lirica è come il telefono, la pila, la radio, la nutella, il microchip e l’idromassaggio: un’invenzione made in Italy, come da proposizione logora e quasi lisa e infatti accuratamente selezionata per battezzare un ministero del governo in carica. “Il teatro d’opera è uno dei pochi interessi condivisi, comuni, davvero ‘nazionali’ e anzi nazionalpopolari, ma in ogni luogo in maniera un po’ diversa. Il teatro accomuna l’Italia lasciandola divisa” scrive Alberto Mattioli nell’apertura di gioco di Gran Teatro Italia, il suo ultimo libro pubblicato con Garzanti (16 euro, 192 pp.), alla seconda ristampa dopo meno di un mese. Mattioli, pazzo per l’opera confesso, ormai alla soglia veneranda delle 2mila recite da spettatore, scrive di lirica su vari giornali (La Stampa, Il Foglio, Amadeus) e in parecchi libri, tutti di successo a dispetto del fatto che non ci sono dei morti ammazzati dentro se non per finta (quelli delle opere). L’unico giallo da risolvere, semmai, è come riesca, ancora una volta in Gran Teatro Italia così come negli altri libri dedicati all’opera (Anche stasera e Meno grigi, più verdi due titoli tra gli altri) a unire il rigore nell’illustrazione delle informazioni e la freschezza dell’esposizione, il peso di una tradizione che affonda in qualche secolo e la leggerezza del racconto. Insomma: il sacro graal della divulgazione.
E questo assume senso assoluto quando si tratta di recitare cantando, poiché l’opera lirica è come il telefono, la pila, la radio, la nutella, il microchip e l’idromassaggio: un’invenzione made in Italy, come da proposizione logora e quasi lisa e infatti accuratamente selezionata per battezzare un ministero del governo in carica. “Il teatro d’opera è uno dei pochi interessi condivisi, comuni, davvero ‘nazionali’ e anzi nazionalpopolari, ma in ogni luogo in maniera un po’ diversa. Il teatro accomuna l’Italia lasciandola divisa” scrive Alberto Mattioli nell’apertura di gioco di Gran Teatro Italia, il suo ultimo libro pubblicato con Garzanti (16 euro, 192 pp.), alla seconda ristampa dopo meno di un mese. Mattioli, pazzo per l’opera confesso, ormai alla soglia veneranda delle 2mila recite da spettatore, scrive di lirica su vari giornali (La Stampa, Il Foglio, Amadeus) e in parecchi libri, tutti di successo a dispetto del fatto che non ci sono dei morti ammazzati dentro se non per finta (quelli delle opere). L’unico giallo da risolvere, semmai, è come riesca, ancora una volta in Gran Teatro Italia così come negli altri libri dedicati all’opera (Anche stasera e Meno grigi, più verdi due titoli tra gli altri) a unire il rigore nell’illustrazione delle informazioni e la freschezza dell’esposizione, il peso di una tradizione che affonda in qualche secolo e la leggerezza del racconto. Insomma: il sacro graal della divulgazione.
In questo caso il pretesto per parlare di opera per Mattioli è la storia – grande e piccola, collettiva e sua personale, basate entrambe su una sterminata aneddotica – dei teatri italiani, dalla Fenice al San Carlo, dal Regio di Torino all’omonimo di Parma, dalla Scala al Massimo, passando per l’impressionante affollamento di palchi e sipari delle Marche. “I teatri in generale, e quelli d’opera in particolare, esistono in tutto il mondo – scrive – Però soltanto in Italia sono diventati qualcosa di più di un luogo di spettacolo. Sono il fulcro della vita non soltanto musicale, ma anche mondana sociale, civile: il centro del centro cittadino. Come la piazza o la cattedrale. Fra la città e il suo teatro d’opera c’è una simbiosi, un’attrazione, una corrispondenza d’amorosi sensi che hanno forgiato l’identità di entrambi: la città è così perché così è il suo teatro e viceversa”.
Il primo colpo d’occhio che resta del viaggio compiuto di teatro in teatro è che un mondo che nell’immaginario collettivo viene descritto pigramente come un po’ bollito, sorpassato dal presente, destinato all’estinzione, prodotto da dinosauri a beneficio di dinosauri è di una vivacità che altri presunti totem tricolore (ogni riferimento al moribondo campionato di calcio è azzeccato, per dirne una) se le sognano la notte. Basta fermarsi a un solo esempio dei tanti possibili: poiché il teatro è soprattutto chi ci si siede dentro peraltro a pagamento, è l’eterna e deliziosa guerra armata e senza esclusione di colpi sulle regie, portata avanti in particolare da chi pretende che il Rigoletto rimanga in calzamaglia nei secoli dei secoli e la Violetta traviata strippata nel corpetto, con gonnellone e fiore tra i capelli (ormai celebre la jihad dell’indomito Mattioli contro il nutrito partito del “povero Verdi“) a dispetto del fatto che le storie della lirica sono spesso enormi specchi che raccontano storie e caratteri di oggi, cioè di sempre (amore e potere, avidità e tradimenti, sopraffazioni e ingiustizie, piccolezze e bassezze morali e eccezioni eroiche). E’ il miracolo dell’opera: “Un teatro – la definizione è di Mattioli – così difficile, elitario, basato sull’assurda convenzione di gente che discorre cantando, in un italiano letterario che non esiste se non sulla carta, che nessuno parlava e molti non capivano, in forme musicali spesso complesse, diventa però patrimonio e passione e coscienza comune per colti e ignoranti, ricchi e poveri, patrizi dei palchi e plebei del loggione”. Attrezzisti, sarte, violinisti. “Ci sono soltanto due paragoni possibili, nella storia del teatro he è poi quella della civiltà: l’Atene di Pericle e la Londra di Shakespeare. E’ l’utopia realizzata, la grande arte per tutti e di tutti, il teatro come identità, comunità, partecipazione“.
Certo, dal libro di Mattioli si capisce bene che poi tra il dire e il fare ci sono di mezzo le fondazioni lirico-sinfoniche con sovrintendenti e relativi tic, fissazioni e magari padrini politici. Del coma del Maggio Fiorentino questo giornale ha scritto in un lungo e in largo: è “come se nel teatro si riflettesse – riflette Mattioli – la contraddizione di una comunità su cui grava un passato infinitamente più importante del suo presente, e non sa o non vuole ripensarsi o reinventarsi”. Ci sono esempi di segno opposto, come la rinascita da studiare al Cnr del Teatro dell’Opera di Roma e la gestione geniale, forse semplicemente perché sinonimo di siciliana, del Massimo di Palermo (“Una città e un teatro che sono sempre o più avanti o più indietro rispetto a quel che è ‘normale’ fuori, quindi affascinantissimi”).
Chi teme di finire in un trattatello storico-accademico con date, stili architettonici, dibattiti sulla progettazione può deporre subito gli ansiolitici. Gran Teatro Italia è anche un libro sulla storia dei teatri perché, sì, certo tratteggia nascite, crescite, spesso incendi, quindi rinascite, fallimenti, belles époques. Ma ha soprattutto la levità di un piccolo drone che girella nelle sale dei teatri e in quel tragitto riesce ad attraversare i secoli e le biografie, si affaccia ai palchetti, si mette a curiosare nei retropalco e nei ridotti, che diventano macchine del tempo. Racconta episodi memorabili che certo avranno come protagonisti Rossini, Verdi, Toscanini e Gronchi con la sua celeberrima gropponata presidenziale nel palco reale della Scala poi giustamente uccellata da Ugo Tognazzi e Raimondo Vianello (i quali come noto furono cacciati dalla Rai: e no, a quel tempo non potevano nemmeno offrirsi a Discovery). Ma c’è anche Pippo Baudo che prende a pedate due malcapitati imputati di aver contestato Katia Ricciarelli durante una Luisa Miller nel 1989, proprio nel teatro milanese e tra l’altro non c’era neanche bisogno dell’intervento del piedone di SuperPippo perché Ricciarelli si è sempre saputa difendere da sola: durante una scena – racconta Mattioli – si era inginocchiata sul palco, si era segnata e aveva dedicato al loggione fischiante un sonoro “Dio vi maledica!“.
La storia dei teatri svela molto anche di com’è cambiato il rito della fruizione degli spettacoli negli ultimi duecento anni. Oggi all’ora X diventa tutto buio pesto, sì è sequestrati in sala, sì può essere liberati solo dal Gis dei carabinieri, si pretende il silenzio di un camposanto, l’applauso è regolato da un manuale alto così di leggi non scritte, si maledice l’intero albero genealogico di chi fa cigolare troppo una poltrona perché ha cambiato l’accavallamento della gamba. Nel Settecento e nell’Ottocento, invece, a dispetto di qualsiasi immaginario, a teatro si faceva un casino dell’ottanta, cioè si faceva di tutto e ascoltare la musica era il penultimo o terzultimo dei pensieri. Una specie di JustCavalli solo più sguaiato: si mangiava, si beveva, si passeggiava al posto della platea che allora non c’era, ci si nascondeva dietro le tendine dei palchi per fare l’amore e per giocare d’azzardo (alla Scala le bische erano pure un ramo d’azienda e Alessandro Manzoni frequentava volentieri). Insomma il centro della vita sociale. Si trova online una cronaca di Francesco Milizia, un intellettuale pugliese del Settecento, su una serata all’opera al San Carlo: “Chi discorre, chi gira il capo in qua e in là, chi legge, chi sbadiglia, e v’è anche chi dorme. Il contorno è in gran parte da fondo a cima tutto bucato di cellette e in ciascuna è annicchiata almeno una donna circondata da un ronzio d’uomini armati tutti di telescopi che servono loro come di bussola per saltare da cella in cella, cicalando, mangiando sorbendo, giuocando”. E le situazioni potevano presto prendere una piega anche peggiore, come racconta Mattioli in Gran Teatro Italia nel capitolo dedicato a Venezia: “Dai palchi i patrizi gettano tranquillamente sulla plebe della platea avanzi di cibo, moccoli di candela e sputi“. Arthur Young, economista inglese di passaggio in Italia per la solita moda del gran tour, annota nel 1787 che “da un palco di lato della sala un nobile in piedi ad un tratto abbassò la brachetta per orinare sulla testa di un orchestrale”. “Nessuno all’infuori di me se ne meravigliò” verbalizzò mister Young.
Tra i 104 teatri citati nel libro una mezza dozzina appartiene a una categoria poco conosciuta: quella dei mini-teatri, ai quali Mattioli dedica un intermezzo peraltro godurioso. Su quale sia il “teatro più piccolo del mondo”, per esempio, è in corso un dibattito infuocato. Si è autoproclamato il teatro della Concordia di Monte Castello di Vibio, in provincia di Perugia (99 posti, 68 mq), ma in provincia di Lucca – a Vetriano – ce n’è uno che di posti ne ha solo un’ottantina in 71 mq. E poi a Noicattaro, Penna San Giovanni, Monteleone di Orvieto, Ragusa Ilba. In Brianza un mobiliere ne ha costruito uno da 102 posti pochi anni fa, con tanto di stagioni e accademia. “Il teatro è la cattedrale, il municipio, la biblioteca, la piazza, il ristorante dell’anima e il bar del cervello. E’ la casa – scrive Mattioli – E’ il posto dove tutto è finto ma niente è falso, dove l’invenzione diventa verità, dove ci svelano per quel che siamo davvero e dove un guitto può davvero essere un sacerdote. E’ un gigantesco specchio, ustorio quando è fatto bene, davanti al quale ci siamo tutti, nudi e crudi, dolenti e ridenti, commossi e pietosi, soprattutto per noi stessi”.
E, insomma, alla fine qual è il primo teatro del mondo? Mattioli fa rispondere Giuseppe Verdi: “Io ne conosco cinque o sei di questi primi teatri ed è proprio in quelli dove più di frequente si fa cattiva musica!” in una delle sue lettere. E’ il San Carlo, il più antico teatro d’opera in attività? E’ la Scala che guida nello spirito ogni nuova stagione con il suo Sant’Ambroeus? E’ la Fenice nella Venezia che ha lanciato Rossini e coccolato verso il tramonto Wagner? Mattioli non risponde e non per furbizia. Preferisce tracciare una via, una specie di possibile “teologia della lirica”, e chi deve capire si metta in ascolto: “Dal punto di vista artistico i momenti migliori della storia del teatro sono quelli in cui si innova, si rischia e si vince” (frecciatina alla Scala). Di più: “Il pubblico non va solo assecondato, va anche educato, traghettandolo con prudente fermezza nel futuro, prima che scopra che quel che vede è irrimediabilmente ancorato al passato. Il tempo fugge, e quello perduto non si recupera più”. Regola d’oro che per un centinaio di arti, mestieri e professioni (fino alla politica, alla tv, al giornalismo) dovrebbe essere scolpita nel marmo. E al contrario al momento – come dimostra in maniera lampante il titolo di questo articolo – è trafitta a morte dalla tirannia dell’algoritmo.