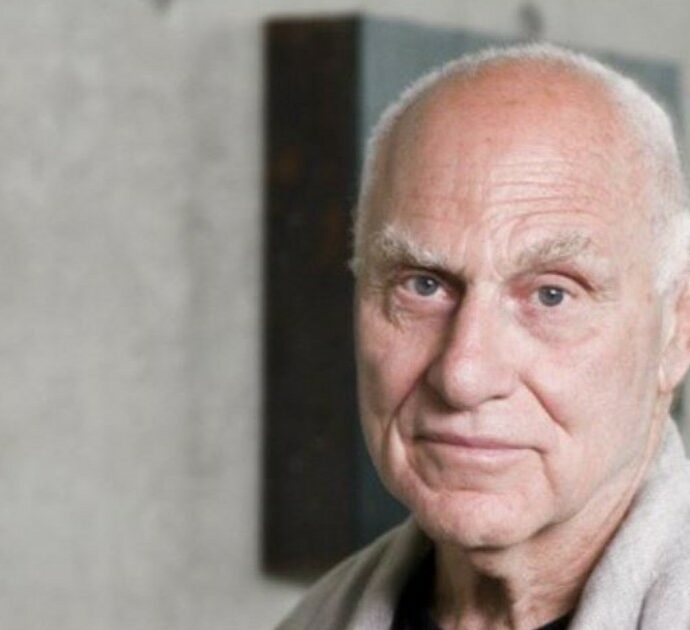Se l’Italia ha un’ambasciatrice dell’arte contemporanea nel mondo, è senza dubbio Patrizia Sandretto Re Rebaudengo. Collezionista, mecenate, filantropa: trent’anni fa era guardata con il sospetto e la curiosità che suscitano i visionari, oggi è considerata una delle voci più influenti nel suo settore a livello internazionale e siede nel board dei musei più importanti (dal MoMa di New York alla Tate di Londra, dal Macba di Barcellona al Ram di Shanghai). Aveva una strada già scritta nell’azienda di famiglia – quei Sandretto industriali e pionieri che nel dopo guerra iniziarono a produrre le prime presse a iniezione per materie plastiche – ma capisce che il destino ha in serbo per lei una curva inaspettata. Inizia a collezionare, comprende che quello è il suo habitat e si pone da subito una missione: “Far uscire l’arte dai musei per entrare nella vita delle comunità”, spiega a FQMagazine. Nel 1995 il grande salto: costituisce a Torino la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo (oggi indirizzo cult per artisti e appassionati, le cui mostre hanno un pubblico cosmopolita e attento), tutto il mondo dell’arte capisce che le scelte di quella donna dalla tempra e dal rigore sabaudo – mescolata ad una vena di inaspettata follia – sono destinate a lasciare un segno profondo in Italia. E nel mondo.
Patrizia, lei è considerata una donna di potere nel mondo dell’arte. È un’etichetta in cui si riconosce?
Avere una visione e una capacità di anticipare le scelte sono fondamentali per un collezionista. Io non scopro, ma riesco ad anticipare e leggere un’opera un momento prima che entri sul mercato. Se questa visione e questa capacità ti vengono riconosciute, allora sai influenzare. E questo ti permettere di avere credibilità e di essere ascoltata. Ma il potere è un’altra cosa.
Quando ha capito che la direzione che aveva intrapreso era quella giusta?
Nel 2011, quando visitai la personale di Maurizio Cattelan al Guggenheim di New York. C’era questa mostra incredibile, con tutte le cento opere di Maurizio, e di quelle ce n’erano setto o otto mie. Ho comprato la sua prima opera nel ’93, quando ancora non era famoso. È stato un momento molto forte, in cui ho provato un moto di grande orgoglio.
Quali sono le doti necessarie ad un bravo collezionista?
Curiosità, studio, passione, capacità esercitare l’occhio, essere umili davanti all’opera. E avere un po’ di fortuna.
La prima volta che si è emozionata guardando un’opera d’arte?
Faccio una premessa: ho sempre collezionato. Da ragazzina collezionavo i portapillole – tutti catalogati su un quadernetto -, poi ho iniziato con le spille (uno dei tratti distintivi dei suoi look, ndr). Negli anni ’90 a Londra, un’amica, una grande collezionista d’arte di Torino, mi portò alla Lisson Gallery di Nicholas Logsdail e con lui andiamo a visitare gli studi degli artisti.
Cosa accadde?
Ricordo tutto: la pioggerellina, il cielo scuro e l’ora di auto per arrivare in un enorme loft. Entrammo e sul pavimento vi erano delle piccole sculture con delle forme meravigliose, ricoperte di pigmenti rossi, gialli, e blu. Ricordo l’emozione forte e intensa, aumentata dal racconto dell’artista, lo scultore Anish Kapoor. In quel momento ho realizzato che potevo iniziare a collezionare, a vivere d’arte.
Perché ha iniziato a collezionare proprio arte contemporanea?
Per l’attrazione verso le opere e perché ho conosciuto le persone che le realizzavano: ho parlato con gli artisti, sono andata nei loro studi, ho cercato di capire cosa ci fosse dietro il loro lavoro. La differenza l’ha fatta proprio la possibilità di entrare in relazione con persone creative, con cui ho cominciato un percorso: è anche grazie a loro se è nata la Fondazione.
La cosa più importante che ha imparato dagli artisti?
A parlare meno e ad ascoltare di più. Stare in ascolto è fondamentale.
L’ascolto influenza la scelta delle opere?
È importante cosa l’artista sta cercando di trasmettermi, di raccontarmi. Per me sono fondamentali l’incontro e il dialogo.
Chi sono i suoi principali interlocutori in questa fitta rete di scambio?
I collezionisti, che per primi mi hanno aperto le loro gallerie e raccontato gli artisti che seguivano. Tutto nasce dallo scambio: ti raccontato le ultime scoperte, l’ultimo artista che hanno conosciuto, ti fanno una proposta. Tutto innesca nuova curiosità. E poi è fondamentale il dialogo coi direttori dei musei, con i critici, con i curatori. Lo scambio è necessario per crescere, conoscere e imparare.
Lei dove acquista?
Mai dagli artisti. Il ruolo del gallerista è centrale: segue l’artista da giovane, lo aiuta, gli organizza le mostre.
Smontiamo un cliché. Si dice spesso: “Io quest’opera d’arte contemporanea non la capisco”.
L’unica possibilità per smontarlo è dare alle persone gli strumenti per portela capire. Il lavoro che facciamo è quello: non semplificare ma raccontare un’opera. E quando tu la capisci – ti poni delle domande, ti sforzi – magari ti piace. O forse non ti piacerà: a me non tutte le opere piacciono, alcune mi disturbano, altre le sento più affini e vicine a me.
Quando un’opera è riuscita, secondo lei?
Quando ti racconta il mondo in cui viviamo, quando prova a spiegarlo: non ti dà delle soluzioni ma ti offre delle domande. Quando un’opera mi fa pensare, ha raggiunto il suo risultato. L’arte contemporanea è uno strumento per parlare ai giovani, e non solo, a chiunque abbia voglia di ascoltare. Nell’arte, se ci pensa, c’è tutto: passato, presente e futuro.
Capire il presente ci aiuta ad anticipare il futuro. A proposito le capacità di visione, lei con i suoi progetti ha anticipato due temi chiave: la questione ambientale e l’empowerment femminile.
È dal ’92 che colleziono opere di donne, dal 2004 invece affrontiamo il discorso della sostenibilità. Continuiamo ad avere attenzione per questi argomenti e ne approfondiamo di nuovi. Da tempo, ad esempio, approfondiamo temi come il disagio digitale: sempre attraverso le opere e gli artisti, abbiamo parlato alle nuove generazioni con un progetto di un anno e mezzo che si chiamava Verso, dedicato ai giovani tra i 15 ai 29 anni.
Altri temi che considera centrali per capire il presente e il futuro?
L’inclusione, in tutta la sua grandezza. Il post colonialismo e il cancellamento della cultura. Tutti temi che stanno esplodendo e che non possiamo esimerci da considerali: l’arte ci aiuta a porci delle domande e capire quali direzioni prendere. E poi ancora lo sfruttamento delle tecnologie, l’intelligenza artificiale, altri temi che gli artisti sviluppano da tempo: l’arte contemporanea è sempre stata avanti, non si è fermata al quadro e alla scultura.
Nel suo percorso da collezionista, le artiste donne sono state da subito presenti. Ma nel mondo dell’arte, da sempre, sono poche. A che punto è il gender gap?
Ho letto dei dati interessanti: la collezione del Moma nel 2004 aveva il 5% di donne, nel 2019 erano salite al 11%. L’evoluzione è lenta. Lo vedi nelle collezioni dei musei, nei prezzi delle opere – nella stessa galleria, artisti della stessa generazione che usano lo stesso media, hanno quotazioni diverse -, in asta idem. Le cose stanno evolvendo in fretta, per le donne è più faticoso imporsi.
Lo è stato anche per lei all’inizio?
Quando entri in una galleria, se sei accompagnata da un marito pongono più l’attenzione su di lui che su di te. Ma se mostri interessi, conosci, frequenti, la situazione cambia totalmente. Diciamo che io ho saputo impormi. Poi da me, in Fondazione, è stato facile: anche nell’organigramma ci sono quasi tutte donne e non per un fatto di quote rosa: scelgo in base alla competenza, non al genere.
Nel 2025 la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo festeggerà i suoi trent’anni di attività. Se si volta indietro, qual è la prima cosa che le viene in mente?
Che sono stata fortunata (dice ridendo). Ho potuto studiare, aprire la mente, guardare il mondo da un punto di vista diverso. E sentito il desiderio di restituire: il concetto di restituzione, molto usato dagli americani, è poco italiano. Ma secondo me ci dovremmo investire di più. La Fondazione è diventato anche un modo per restituire tutto ciò che ho avuto dagli artisti, dalle mie esperienze, e si è trasformata in qualcosa di molto grande.
Oggi la Fondazione è uno dei punti nevralgici dell’arte contemporanea a livello globale. Organizzate grandi mostre, fate incontri e presentazioni coi grandi nomi della cultura internazionale. Ma al tempo stesso dialogate con il territorio attraverso una fitta rete di attività educative e didattiche.
Sono convinta che l’arte contemporanea sia uno straordinario motore culturale, educativo e sociale oltre che un efficace vettore economico. Per questo, da una parte realizziamo attività di committenza e produzione di opere nuove, abbiamo creato una scuola per curatori. Dall’altra abbiamo 30mila studenti che fanno laboratori e visitano le mostre, e realizziamo attività legate all’accessibilità e alla disabilità. La Fondazione si è trasformata in un luogo vivo, il posto dove realizzare ciò in cui credo: far uscire l’arte dai musei per entrare nella vita delle comunità. Le dico anche che cosa non è: non è la casa della mia collezione, non la mostro qui se non per qualche piccolo progetto. Non ho preso uno spazio per metterci dentro le mie opere. La mia collezione viaggia, qui facciamo un’attività formativa e educativa.
E pensare che il suo destino era lavorare nell’azienda di famiglia…
Ho studiato economia, poi ho lavorato in un’azienda di famiglia. Tutto mi ha aiutato a crescere, ad andare in una direzione diversa da quella che mio padre aveva immaginato per me. Da sempre mi sono mossa con grande serietà e senza mai immaginarlo come un gioco. Così ho trasformato la passione per l’arte e il collezionismo in un’attività organizzata: la Fondazione è un’istituzione culturale che va gestita, in cui lavorano ina ventina di persone, e il fatto di aver lavorato con un padre imprenditore e di aver studiato, mi permette di portare avanti questa attività.
Social network e mondo dell’arte. Hanno un peso, sono uno strumento utile?
Mi confronto spesso con i collezionisti sul tema dei social, chiedo a tutti quanto li usino per conoscere gli artisti. Molti guardano le opere d’arte soprattutto attraverso Instagram, c’è grande attenzione a ciò che viene instagrammato, è un media attraverso cui si può persino scoprire un artista.
Attraverso i social con la sua Fondazione avete impresso una svolta ultra-pop alla comunicazione che poi è stata copiata da molti musei e istituzioni culturali nel mondo ed è diventata un caso di studio.
C’era più rigore, oggi è cambiato molto. Ho dialogato per molte ore su questo tema con Silvio Salvo (Responsabile Ufficio stampa e Social Media Manager della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, ndr). Mi sono molto fidata di lui perché ho capito che il mondo stava andando in una direzione e che lui era avanti. All’inizio avevo qualche timore, oggi penso che abbiamo fatto una scelta giusta.
Il suo timore qual era?
Dicevo: “Chissà come verremo letti da un certo mondo museale, quello più rigido e istituzionale”. Ora in molti ci copiano e questo è il riconoscimento di un lavoro efficace e fatto bene. E io credo che un’istituzione come la nostra debba svolgere questo lavoro: non rendere facile l’arte ma comprensibile. Con il nostro modo di comunicare, ci siamo riusciti.
Torino è la sua città. Quanto per essere cosmopoliti c’è bisogno di essere ancorati alle radici?
È importante avere il tuo luogo, la tua storia, le tue radici. Sono convinta di essere arrivata all’arte contemporanea perché sono cresciuta a Torino. Qui nel ‘59 ha aperto la Gam, la prima galleria civica con opere di collezioni private, nello stesso anno in cui apriva il Guggenheim. A Torino nascono movimenti come l’Arte povera, nasce il Deposito d’arte negli anni ’60 dove dei collezionisti illuminati come Marcello Levi iniziano a mettere le loro collezioni e ad invitare intellettuali come Pasolini. Ho imparato molto quando con mia madre andavamo a visitare la Gam e le mostre, ho imparato da un’istituzione come il Castello di Rivoli, con una direttrice come Ida Gianelli mi ha fatto un corso accelerato di storia dell’arte. A Torino ho trovato terreno fertile per una crescita culturale importante e ricca.
Il cliché della Torino grigia e provinciale è definitivamente tramontato.
Per fortuna sì. Qui si fa lavoro di nicchia e di ricerca e dico che senza la ricerca non si cresce. Viaggio molto, visito, mi confronto con il mondo e posso dire che Torino culturalmente è viva e cosmopolita. Italo Calvino per descriverla usava tre parole: rigore, linearità, stile. Diceva che è una città che “invita alla logica” ma con una vena di follia. Ecco, quella vena di follia ci vuole e io la sento mia.
Il lato inedito di Patrizia Sandretto: la follia.
(ride) Sì, una follia buona che mi aiuta ad essere un po’ meno razionale.
Ha viaggiato e incontrato le grandi personalità. Chi ha lasciato il segno?
L’elenco sarebbe sterminato. Nicholas Serota, storico direttore della Tate Gallery di Londra, e Richard Armstrong, direttore del Guggenheim. Jack Lang, ministro della cultura francese che mi insignì del titolo di Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres, nel 2009. Ma voglio citare anche un nome forse meno noto al grande pubblico, il collezionista greco Dakis Joannou, che già negli anni ’90 invitava ad Atene collezionisti, critici, giovani artisti – tra cui un giovane Jeff Koons – con cui trascorrevamo intere giornate. Quando venne a casa mia, mi disse una cosa che mi impressionò molto: “Grazie a questa passione comune, abbiamo amici in tutto il mondo”. Ed è vero. Creare relazioni, dialogare, crescere ti fa avere amici in tutto il mondo.
Altri nomi?
Harald Szeemann, che ha inventato la figura del curatore. Gli dissi: “Il mio museo è piccolo”. Lui mi rispose: “Small but efficient”. È diventato il mio motto. E poi ancora Shirin Ebadi, l’avvocatessa iraniana premio Nobel per la pace.
Da tempo lei vive nella casa che fu di Virginio Tedeschi, il nonno di Carla Bruni
L’abbiamo acquistato più di trent’anni fa. Conosco bene sua mamma, Marisa Borini, tanto che quando ha pubblicato la sua biografia mi ha chiesto di presentarla in Fondazione. È venuta con tutta la famiglia, compreso Sarzoky. Poi vennero a cena da me e Carla e sua sorella Valeria si infilarono in tutte le stanze, correndo per i corridoi di quella casa che amavano molto.
Lei è stata grande amica di Franca Sozzani.
È stata una di quelle “donne illuminate” che hanno segnato la mia vita. Abbiamo sempre avuto un rapporto stretto: ha accettato di essere nel consiglio del Premio Stellare – disegnato da Cattelan – che assegniamo alle donne che hanno saputo distinguersi. Abbiamo coltivato un’amicizia lunga e sincera. Era presidente della fondazione Ieo-Monzino e quando si è ammalata – non parlava mai della malattia, l’ha voluta vivere con grande discrezione – attraverso persone a lei molto vicine mi ha chiesto di portare avanti il suo lavoro. Ci teneva che portassi avanti l’attività ed è stato un passaggio di testimone molto naturale. Ho fatto mio questo aspetto filantropico che mi dà molta soddisfazione: uso l’arte per raccogliere fondi per la ricerca.
È mai stata corteggiata dalla politica?
Sì, mi hanno chiesto di candidarmi. È un riconoscimento che mi ha inorgoglito ma io mi occupo di cultura e tutte le mie energie devono andare tutte in quella direzione. Il mio mestiere è commissionare, educare, formare, lavorare con gli artisti.
Nell’immaginario collettivo l’arte evoca subito il concetto di lusso.
In asta abbiamo visto prezzi di opere molto alti ma stiamo parlando di una piccolissima parte del mondo dell’arte. Ci sono una quantità di giovani artisti le cui opere si possono acquistare a prezzi bassi. Certo, se vuoi l’artista di gran moda… è come se volessi l’orologio di marca. Ma, in generale, l’arte contemporanea non è elitista: non puoi comprare il quadro ma con un biglietto di pochi euro entri al museo.
Per lei cos’è il lusso?
È poter fare ogni giorno ciò che faccio. Svegliarmi al mattino e venire in Fondazione. È poter vivere la mia vita ponendomi sempre nuovi obiettivi. Continuo a sognare, a portare avanti nuovi progetti, provo ad arrivare alla stella.
Robur ad astris, “la forza dalle stelle”, è il motto della famiglia nobiliare dei Re Rebaudengo. La stella blu, che è il logo della Fondazione, dove l’ha portata?
Mi ha portata nel mondo, mi ha spinto a crescere interiormente, mi ha aiutato a leggere le cose, ad essere aperta e più tollerante. Mi avvicino al cielo ma sempre coi piedi sulla terra.