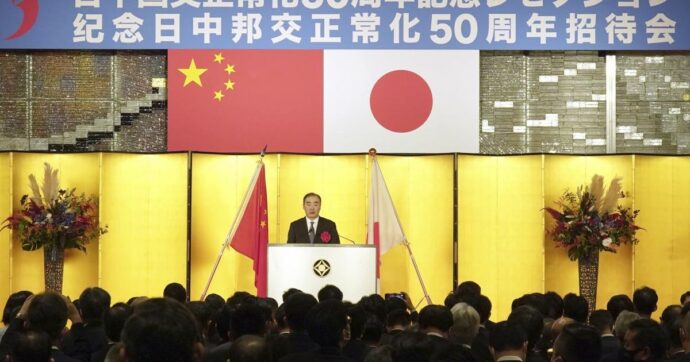La frenata della Cina non è un fenomeno ciclico o temporaneo ma segna la fine di un’epoca per la seconda economia mondiale che viene definita – impropriamente – “giapponesizzazione” in analogia alla frenata ancora più brusca, iniziata 30 anni fa, nell’economia che allora era la medaglia d’argento tra le economie del pianeta.
Ma mentre quando è iniziata la stagnazione il Giappone era un paese ricco in termini di Pil pro-capite, fortemente urbanizzato, con servizi sociali di ottimo livello e un debito pubblico in linea con i parametri di Maastricht, la Cina rimane un paese tendenzialmente povero, con una popolazione rurale arretrata, senza sistemi sanitari, educativi e pensionistici decenti e un debito pubblico che fra qualche anno (secondo le stime del FMI) supererà il livello italiano.
Ed è proprio il debito accumulato dal governo centrale, dalle amministrazioni locali e dagli enti pubblici di varia natura e scopo, l’anemometro che misura la furia dei poderosi venti contrari che stanno portando l’economia cinese verso gli scogli o quantomeno verso estesi banchi di secche.
Il successo impetuoso della Cina si è basato per decenni sulle esportazioni, sui consumi interni contenuti, sulla repressione finanziaria, sui controlli di capitale, sugli investimenti e sul basso costo del lavoro. Ma quel modello è arrivato al capolinea per cause in parte strutturali, in parte indotte da malagestione politica. In primo luogo, l’invecchiamento della popolazione cinese e la contrazione della forza lavoro stanno colpendo le industrie ad alta intensità di lavoro. In secondo luogo, l’aumento dei salari e dei costi di produzione hanno reso la Cina meno competitiva. In terzo luogo, il degrado ambientale causato dall’industrializzazione non è più sopportabile. Infine, le direttive dei pianificatori comunisti hanno creato ampie paludi di inefficienza che si tenta di bonificare a colpi di sussidi pubblici, ma che diventano sempre più mefitiche.
Più aumentano i sussidi più si diffonde l’inefficienza per cui le fabbriche cinesi hanno capacità in eccesso e produzioni ipertrofiche che cercano di smaltire a prezzi di realizzo anche sui mercati esteri, nella speranza di poter giustificare ai padrini politici le richieste di sostegno pubblico. In sostanza in Cina è in corso una gigantesca operazione di dumping a livello planetario che rischia di finire male per i paesi occidentali esposti alla concorrenza sleale e per le casse del regime cinese dove le cambiali si accumulano inesorabilmente. Per evitare la “giapponesizzazione”, la Cina dovrebbe ribaltare il suo modello di crescita orientandolo verso i consumi interni e lasciando fallire le imprese decotte. Ma l’ideologia che impera a Pechino incita a remare nella direzione opposta, anzi da quando Xi Jinping è assurto al potere ha accelerato il ritmo delle vogate e i colpi di frusta.
L’indebitamento della Cina si è impennato già in seguito alle misure di stimolo adottate freneticamente dal governo dopo la crisi finanziaria globale del 2008 e imperniate soprattutto sull’edilizia e sulla costruzione di infrastrutture molte della quali di scarsa utilità. Resisi conto delle distorsioni, i burocrati che reggono le sorti dell’economia, nel 2017 hanno lanciato una campagna di deleveraging ad ampio raggio, ma concentrata soprattutto nell’immobiliare dove si era creata una bolla di proporzioni bibliche. Le restrizioni al credito hanno avuto l’effetto di una doccia scozzese in massima parte sui palazzinari con ripercussioni negative sul Pil e sull’occupazione. Ma l’impatto del deleveraging si è propagato a tutta l’economia, in particolare al settore manifatturiero, alle vendite al dettaglio e persino alle esportazioni.
In sostanza gli sforzi del governo per frenare il credito bancario (incluso quello erogato da istituzioni finanziarie ombra) hanno ostruito l’accesso al credito, in particolare alle aziende del settore privato senza distinguere quelle sane da quelle senza futuro. Insomma la stretta creditizia in un sistema poco flessibile ha contribuito a buttare il proverbiale neonato nel tentativo di sbarazzarsi dell’acqua sporca. Ad aggravare la situazione, il congelamento dei progetti immobiliari ha colpito anche le amministrazioni locali che dai proventi degli oneri di urbanizzazioni e altre tasse finanziavano i propri bilanci senza gravare sul governo locale. Con la fine della pacchia edilizia si sono prosciugate anche le entrate fiscali.
In questo contesto già poco lusinghiero sono arrivate in rapida sequenza due mazzate epocali, l’una conseguenza dell’altra: il Covid e la deglobalizzazione. Il Covid e il lockdown che ne è seguito hanno bloccato l’economia, ma la conseguenza peggiore è stata la consapevolezza dopo decenni di acquiescenza e miopia in Occidente che della Cina e delle sue catene del valore era meglio non fidarsi. Da allora è iniziato, prima in sordina, poi con un crescendo rossiniano, una fuga dalla Cina delle multinazionali. E il cosiddetto reshoring o friendshoring o de-risking che era iniziato come un rivolo all’epoca della Presidenza Trump e ora è un fiume a primavera.
Il governo cinese di fronte alla gelata economica e alla disoccupazione giovanile, ormai a livelli da favelas sudamericana, sta imbastendo un arzigogolato gioco di equilibri, cercando di mantenere la stabilità economica, mentre affronta gli squilibri strutturali come l’eccesso di capacità, il debito, il degrado ambientale e il crollo degli investimenti dall’estero. Ma la falena comunista attirata dalla fiamma della crescita impetuosa che avrebbe catapultato il regime sulla vetta del mondo, sostituendo gli Usa e tutto l’Occidente capitalista e decadente, probabilmente finirà con le ali dolorosamente bruciate.
Articolo Precedente
L’inverno demografico impatta pure sulla sanità: così al Nord andranno più soldi che al Sud