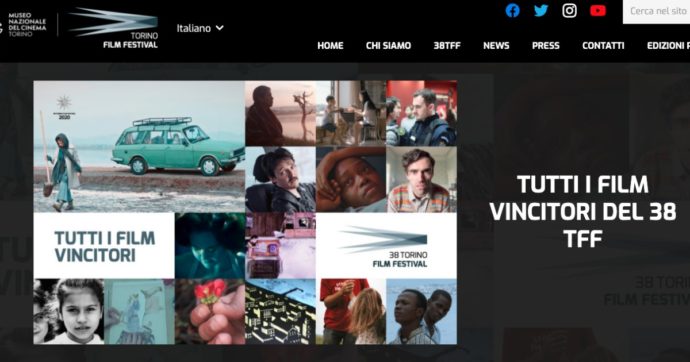Piccoli flash dal Torino Film Festival appena concluso: l’asciuttezza e la scarnificazione dei due film che hanno raccolto i premi maggiori, l’iraniano-canadese Botox, vincitore assoluto, e il messicano Sin señas particulares cui è andato il premio della Giuria; alcune originali idee per i documentari, per esempio Pino di Walter Fasano o Dear Werner di Pablo Maqueda, due gesti d’affetto, assai diversi tra loro, per due grandi esponenti dell’arte visiva come Pino Pascali e Werner Herzog. E poi, ancora, un ritorno indietro agli anni Settanta, che il cinema italiano sembra voler fare per sistemare i conti con la coscienza di un’epoca.
Bisogna ancora elaborare la memoria di quel decennio sanguinoso e martoriato, ma anche carico della rabbia e delle illusioni giovanili che portano spesso fuori strada ma che altrettanto spesso fanno intravedere un’altra luce possibile. Due film del TFF hanno provato a farlo, seguendo rispettivamente la pista del documentario e della finzione (ma ha poi senso questa distinzione?)
1974-1979. Le nostre ferite, di Monica Repetto, prova a far riemergere da quel passato alcuni protagonisti loro malgrado. Non le grandi figure che nel bene o nel male hanno segnato i giorni del furore degli anni Settanta, ma gli eroi minori, vittime di gravi attentati ai quali sono sopravvissuti, che all’epoca finirono per un momento sui giornali e poi ritornarono ad una quotidianità normale. C’è il compagno assaltato dai fascisti, il poliziotto preso in una sparatoria di terroristi contro una sede Dc, la femminista aggredita all’interno di una radio libera, l’impiegato di banca colpito nella sede di un master che frequentava.
Persone di estrazione diversa e di idee diverse, accomunate da un medesimo destino di sangue. Di tutti il film ascolta la testimonianza, punteggiandola con filmati d’epoca, ritagli di giornale, identikit della polizia. Ma non c’è solo la rievocazione di quei fatti nel film, ci sono anche piccoli reperti anonimi, un found footage che restituisce ad esempio le immagini di film di famiglia girati in occasione di una vacanza sulla neve o di una ricorrenza, a dare l’idea di una normalità che malgrado tutto continuava. Tutto ciò restituisce il sapore di un’epoca scatenata, dando l’idea di come la vita di tutti vi fosse in un modo o in un altro implicata.
Anche Il buco in testa di Antonio Capuano torna a quel decennio, ispirandosi a un fatto drammatico come l’uccisione del brigadiere napoletano Antonio Custra il 14 maggio 1977 a Milano durante alcuni scontri con esponenti dell’Autonomia. Quel tragico fatto è legato anche a una delle più celebri immagini di quegli anni, che il film riprende, ovvero la foto che ritrae un terrorista sparare a due mani.
Capuano incentra il film sulla figura della figlia del poliziotto – che qui si chiama Maria Serra ed è interpretata da Teresa Saponangelo – nata dopo la morte del padre, e sul suo desiderio di aprire finalmente una vita che sembrava essere stata blindata fin dalla nascita. Maria infatti vive con una madre ammutolita dal dolore, privata dei baci e dell’affetto del marito che non c’è più. E ha una vita chiusa, resistente alle emozioni, poco incline al sorriso. C’è solo da ritrovare il filo rotto quel tragico giorno. Per questo Maria sale a Milano, per trovare Guido, l’assassino di suo padre, ora libero dopo aver scontato la sua pena. Ma è difficile ritrovare se stessi e anche riconoscere nell’altro l’umanità del dolore e del rimorso. Pasolinianamente, Maria accusa Guido della scelleratezza di un’azione che si voleva rivoluzionaria e che invece prendeva a bersaglio i poliziotti, cioè uomini sfruttati che cercavano di sfuggire a una vita di servitù arruolandosi.
Tra i due non ci può essere un linguaggio comune, ma ci sono gesti, sguardi, azioni che tradiscono la loro distanza, ma anche il loro paradossale comune destino: sono entrambi trafitti dal dolore, per entrambi la vita si è fermata quel giorno. Per Maria sono importanti i simboli: accasciarsi nel punto esatto in cui si accasciò il padre ferito a morte, chiudere il cerchio della memoria pensando di sparare all’assassino. Poi il viaggio di ritorno potrà cominciare. Per Guido non c’è che da chiedere perdono a lei e a tutti per quelle scelte estreme, legate a un momento in cui sembrava di essere in guerra. Il film racconta proprio l’interstizio sottile e ineludibile che unisce e allontana il carnefice e la vittima. E lo fa entrando con delicatezza nelle psicologie devastate dei due.
Resta un po’ da capire l’origine del sentimento di guerra, o più semplicemente c’è da capire il perché si andasse alle manifestazioni con la pistola. Il film di Capuano vi allude: la violenza, dice Guido, fu la perdita dell’innocenza, e noi fummo il prodotto delle contraddizioni di quella società. Capuano imbastisce la storia come un viaggio nel tempo e nello spazio, con un incastro di situazioni a volte anche troppo carico, tra Napoli e Milano. Proprio nella stazione di Milano il film si apre e si chiude. In fondo tutto il cinema è un grande viaggio alla ricerca di se stessi, della propria identità, della propria storia. Non a caso Il buco in testa è dedicato ai fratelli Lumière, primi cineasti ad aver ripreso un treno che entrava in una stazione.
Articolo Precedente
Auto in corsa e sgommate sui sampietrini: Piazza Venezia è Mission Impossible. Il video di Tom Cruise in centro a Roma per le riprese

Articolo Successivo
L’Isola delle Rose, chissà perché questa storia finisce su libri e documentari. Ora è anche un film spassoso