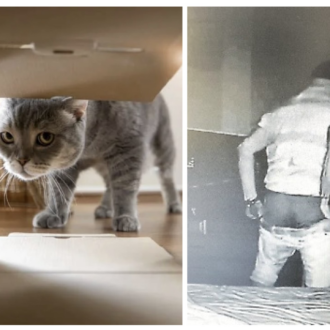di Lorenzo Serra
Restituire uno spaccato (una parte) di una società può costituire uno dei compiti maggiormente fecondi in un artista: scavare nel passato per ritrovare embrioni di futuro, per ricostruire, cioè, nuove costellazioni tra passato e presente. Film storici, apparentemente descrittivi, ma in grado, invero, di innescare potenziali squarci nell’attualità. Descrivere la realtà, rappresentare un tempo antico, significa, infatti, già prenderne parte, ricostituirlo o, ancor meglio, riattualizzarlo: sostare, cioè, nel passato, ma con lo sguardo vigile rivolto in direzione dell’avvenire.
Sono questi i motivi per cui il film diretto da Paola Cortellesi, C’è ancora domani, corre il rischio di una strutturale incompiutezza: la descrizione di una parte si tramuta, rapidamente, in una prescrizione, che proviene, tuttavia, dall’esterno dell’opera. Perché qui, cioè, si forza il passato non partendo, nel tentativo di portare a compimento, dalla datità di quel tempo, bensì accostando, in modalità a-storiche, moderno e antico. Non ci si inabissa, quindi, nel passato alla ricerca di tracce esplosive per il presente; si ricostruisce, piuttosto, anche ciò che è antico secondo le categorie della nostra attualità. Non riattualizzazione, bensì interpretazione forzata di una storia: il che si traduce nel dissolversi simultaneo di passato e presente – ecco il limite profondo del film, un problema sì storico e politico, ma, prima di tutto, formale ed artistico.
Gli anni rappresentati – l’Italia che esce così faticosamente dal secondo conflitto mondiale – non vengono, cioè, osservati con le lenti di chi ricerca nel passato le assenze del contemporaneo, ma di chi scorge un tempo che fu in un continuum progressista con il presente: nessun salto, né rottura, è presente in questa riproposizione. È per questi motivi che quest’opera, sì in bianco e nero, si costituisce, in realtà, come un’opera cardine della modernità: la storia non si spezza mai, non si assume mai, all’interno di essa, uno sguardo differente. Il tempo rappresentato, infatti, è il mondo che fuoriesce dalla seconda guerra mondiale, alle soglie di quello che ancora oggi definiamo grande Novecento: semplice, oggi, considerare quest’ultimo come un tempo superato, e da superare, più complesso, invece, ma sicuramente più fecondo, tentare di scorgere in quest’ultimo elementi che possano rompere la costruzione della nostra attualità.
Questo è il pericolo a cui si espone dunque l’opera: nella non assunzione, in tutta la sua complessità, di quel tempo storico/politico che vorrebbe abitare. Io mi dichiaro esplicitamente vicino alle istanze emancipatrici di un femminismo che definirei, forse in termini inattuali, di carattere socialista; la questione dirimente riguarda, tuttavia, le modalità in cui questa problematica è state messa in forma. Partiamo dall’ultima scena, forse potenzialmente tra le migliori: le donne che si truccano e si vestono in modo elegante per andare a votare e prendere, così, finalmente anche loro parte alla democrazia – la speranza di una democrazia sostanziale, simbolizzazione del fatto che nella politica ne va dell’esistenza di ogni essere umano (anche, finalmente, delle donne!). Eppure, questo momento collettivo di avvio di una lenta ricostruzione che segue quella che ancora oggi definiamo in termini entusiastici Resistenza, si trasforma in un contrasto generico uomo/donna in cui rischia di dissolversi la datità storica del tempo rappresentato.
Non solamente, cioè, non si mette a tema all’interno del film quella parte decisiva legata al conflitto sociale-politico, così strettamente legata alle possibilità dell’emancipazione femminile, ma, inoltre, il piano comunitario comincia già ad esser risucchiato da un piano individuale (quella libertà americana di cui, non a caso, sembrano tessersi vari elogi nell’opera). Ma questa sembra essere la rappresentazione del nostro decadente mondo occidentale, all’interno del quale le varie lotte di liberazione, quando sono presenti, si costituiscono come sempre più separate e sfilacciate tra loro, non di quel passato in cui un contro-potere (che non si nomina mai) era in grado di pensarle congiuntamente. Si scinde, cioè, anche qui, troppo frettolosamente, la possibilità formale del voto dalla sostanza (dalle possibilità di trasformazione), e dai soggetti che esso incorpora.
È per tutti questi motivi che C’è ancora domani non si può considerare come il nuovo inizio del cinema italiano: perché l’arte, in questo caso, non anticipa alcuna nuova realtà – sposandone, piuttosto (anche raffinatamente, in alcune scelte stilistiche) la Weltanschauung dominante. Gli applausi degli spettatori alla conclusione del film non preludono ad un mondo in trasformazione. Oltre Barbie e C’è ancora domani (che rimane, comunque, di gran lunga superiore al primo) aspettiamo, ancora, con insistenza, opere d’arte eretiche, non-convenzionali, anche apparentemente inattuali, in cui poter dire con speranza: “l’arte sta cogliendo, finalmente, le fratture di una realtà in trasformazione”. Una rivoluzione in campo artistico che preannuncerebbe, costituendone insieme la prima testimonianza, una trasformazione su un piano antropologico e politico, una vera rivoluzione.
In quest’opera, invece, a dispetto del titolo, e di alcuni elementi pur di interesse, è ancora l’oggi, l’ideologia dominante, a costituire, in definitiva, il nerbo centrale – quel potenziale domani (quella nuova aurora) di trasformazione che tutti aspettiamo, estetica e politica, sembra essere ancora un miraggio.
Articolo Precedente
Trenque Lauquen, quattro ore e venti di film ma vorresti ancora continuare

Articolo Successivo
Corpo senza braccia e senza testa ritrovato su una spiaggia, forse è quello del regista Ross McDonnell: “Scomparso dopo esser uscito per un giro in bici”