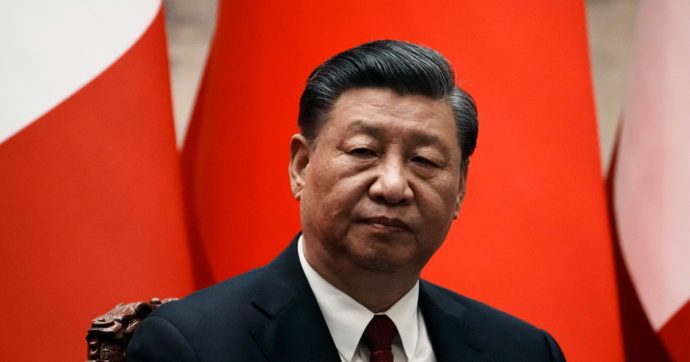“In Cina c’è un detto: ‘Non siamo i primi a istigare, ma non ci tireremo indietro davanti alle provocazioni‘”. A metà giugno il nuovo ambasciatore cinese negli Stati Uniti, Xie Feng, preannunciava così misure ritorsive in risposta alla minaccia di restrizioni sugli investimenti americani nei settori strategici della Repubblica popolare. Ora che le minacce si sono concretizzate come reagirà Pechino? Passare dalle parole ai fatti non è impresa semplice.
Con un ordine esecutivo, mercoledì Joe Biden ha conferito al dipartimento del Tesoro il potere di vietare operazioni di fusione, private equity e l’immissione di capitale di rischio in società cinesi specializzate in alcuni settori sensibili: intelligenza artificiale, informatica quantistica e produzione di semiconduttori avanzati. Le misure (effettive dal prossimo anno) interessano i finanziamenti che comportano “benefici immateriali”, come l’arruolamento di personale altamente qualificato e l’acquisizione di know-how aziendale. Ma non riguardano gli ingenti flussi di denaro pubblico destinato alle società cinesi quotate a New York e in Cina. I provvedimenti non hanno valore retroattivo (ergo gli investimenti già conclusi non dovrebbero subire contraccolpi) e interessano le startup e le aziende che ottengono oltre il 50% delle loro entrate dai settori menzionati.
Come rimarcato dalla Casa Bianca, l’obiettivo ufficiale è evitare che il gigante asiatico sfrutti i capitali a stelle e strisce per migliorare le proprie capacità militari, di intelligence e sorveglianza di massa, seguendo la cosiddetta strategia del “piccolo cortile e alto recinto”: contenere i rischi (de-risking) senza perseguire un vero e proprio disaccoppiamento (decoupling) dalla seconda economia mondiale è quanto si prefigge l’amministrazione Biden. Anche tenendo conto delle preoccupazioni esternate dai colossi tecnologici americani, come Intel e Nvidia, che annoverano la Cina tra i loro principali clienti.
Ma se Washington ragiona in termini di sicurezza nazionale e tutela dei diritti umani, per Pechino gli ultimi provvedimenti in realtà confermano le mire egemoniche dello Zio Sam dopo le restrizioni di ottobre sui semiconduttori e l’inserimento di centinaia di società cinesi nella famigerata Entity List che preclude l’importazione di tecnologia statunitense salvo apposita licenza. Secondo il ministero degli Esteri cinese, le nuove misure costituiscono una “aperta coercizione economica e bullismo tecnologico” perché sono progettate per “privare i diritti di sviluppo della Cina” in nome della sicurezza nazionale. Al fine di “preservare risolutamente il proprio interesse”, il ministero del Commercio si riserva il “diritto di agire”. Come, però, non è chiaro. Il pericolo è infatti che una reazione scomposta di Pechino da una parte comprometta il progressivo disgelo diplomatico con Washington a ridosso dall’attesa visita in Cina della segretaria al Commercio, Gina Raimondo. Dall’altra, che allontani i capitali americani anche dai settori finora graziati dal decreto di Biden.
D’altronde, oltre la Muraglia il clima economico non è dei migliori: nel mese di luglio la Cina è entrata in deflazione smentendo le proiezioni ottimistiche di una rapida ripresa dopo la sospensione delle politiche anti-Covid. Stando a un sondaggio della Camera di commercio americana, per la prima volta in quasi trent’anni la Repubblica popolare non compare più tra le tre principali destinazioni di investimento per la maggior parte delle aziende interpellate. Secondo dati di PitchBook, quest’anno solo 64 investitori statunitensi sono stati coinvolti in accordi di Venture Capital con la Cina, rispetto ai 179 del 2022 e ai 246 del 2021.
Optando per un approccio prudente – più che replicare i divieti contro la multinazionale dell’elettronica Micron – Pechino potrebbe decidere di manifestare il proprio disappunto strumentalizzando ulteriormente l’ampio controllo sui materiali critici. Terre rare in primis. A luglio, replicando alle restrizioni concertate di Stati Uniti, Giappone e Paesi Bassi sui chip, la Cina ha imposto restrizioni sull’esportazione di gallio e germanio, due minerali fondamentali per la produzione di semiconduttori, sistemi missilistici e celle fotovoltaiche. A modo suo, anche il gigante asiatico persegue una politica di “de-risking”.
Peraltro resta da quantificare l’impatto effettivo del decreto americano, ancora piuttosto vago. Perplessità in merito non provengono solo dai soliti falchi del Congresso. Come spiegano diversi esperti al South China Morning Post, l’industria cinese dei semiconduttori è ormai sostanzialmente supportata dal capitale interno. Gli investimenti statunitensi nella tecnologia quantistica e l’intelligenza artificiale sono in ritirata da almeno cinque anni. Sul bilancio futuro pesano piuttosto le future mosse della Casa Bianca: i nuovi provvedimenti sono ancora suscettibili di possibili ritocchi. E, considerato l’andazzo, non è escluso – anzi verosimile – che i lacci e lacciuoli americani vengano estesi ad altri settori strategici. Allora le cose potrebbero complicarsi non poco per il gigante asiatico che, stando a una recente analisi del Center for Strategic and International Studies, importa il 70% di circa 412 articoli da Stati Uniti e alleati: si parla di beni di lusso ma anche di polvere di nickel e altri materiali indispensabili per la transizione energetica e la produzione militare.
Articolo Precedente
Cosa c’è dietro alla guerra di Biden con la Cina sull’hi-tech? L’obiettivo è frenare Pechino, ma senza creare una rottura tra le due economie

Articolo Successivo
L’esperto di cybersecurity: “Attacchi informatici in aumento, colpite soprattutto le Pmi. Dall’IA rischi anche per la nostra identità culturale”