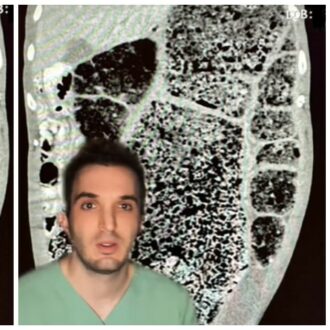Sarà che pubblicato il primo estratto “Dance Of The Clairvoyants” ci eravamo un po’ tutti convinti che Eddie Vedder e compagni volessero, se non darsi alla new wave, sicuramente pubblicare un disco più sperimentale rispetto ai loro ben noti standard. E invece “Gigaton” ascoltato per intero finisce per essere forse l’album più conservativo dei Pearl Jam.
La formula è semplice: tolta l’eccezione di cui sopra e un paio di linee di arrangiamento, il tutto non va oltre il più classico dei chitarra, basso, batteria e voce. Ma facciamola ancora più semplice: chi ascolta questo disco nella speranza di ritrovarvi la rabbia e l’esplosività di “Ten” o “VS” farebbe bene, da subito, a darsi ad altro. L’ispirazione, pure quella, va e viene: con tutti i pregi e i difetti di un gruppo che vanta ormai 30 anni di carriera, e che seppure da tempo non deve dimostrare più niente a nessuno raramente è scivolato così in basso da meritarsi anche solo un’insufficienza.
Altresì pubblicare un disco così smaccatamente “rock” nel 2020 (il più lungo in carriera), composto non da 8, non da 10, bensì da un totale di 12 canzoni, dimostra già di per sé un coraggio non comune: in tempi in cui (ormai anni) la musica la si ascolta ragionando per brani, costruire una credibilità ancor prima che una carriera rappresenta per molti certo l’ultimo dei problemi.
Questione che i Pearl Jam continuano invece a porsi eccome, trascorsi sette anni dal precedente “Lightning Bolt” e ben quattro – raccontava il bassista Jeff Ament, sui social, con tanto di mascherina d’ordinanza – dall’inizio delle registrazioni. E questa loro genuinità la troviamo fin da subito col quasi-garage di “Who Ever Said”: brano grezzo, che abbaia ma non morde, e pure strappa qualche sbadiglio.
Poco male visto che la sequenza immediatamente successiva, quella costituita da “Superblood Wolfmoon” e (rieccola) “Dance Of The Clairvoyants” ha insita la solarità e la semplice complessità – nel secondo caso – tipica dei Pearl Jam quando riescono a coniugare la loro verve più aggressiva con quel fare danzereccio che in principio, concettualmente, suona quasi disturbante salvo poi piacere e tanto.
“Quick Escape” sembra invece ricalcare, con carta carbone, l’incedere di “Kashmir” dei Led Zeppelin – che qui viene anche citata – e a dispetto dell’andamento volutamente reiterato apre nel ritornello sparando in aria tutta l’emotività sofferta di Eddie Vedder che – sempre nel testo – tira in ballo anche i Queen e Freddie Mercury.
“Alright” pare uscita dalle session di “Riot Act”, e suona come poco più di un filler cadendo rovinosamente a cospetto della bellezza struggente di “7 O’ Clock”: il cui falsetto finale ricaverebbe mazzi di rose pure dal più arido dei cuori sulla faccia della terra.
Con “Never Destination” il saluto è stavolta per gli Who di “Quadrophoenia”, e ancora più nello specifico il brano vanta struttura e attitudine molto simili a “The Real Me”: non è un caso che Vedder abbia condiviso con loro il palco l’ultima volta un anno fa, definendoli sempre recentemente “il più grande gruppo live di sempre”.
“Take The Long Way” è invece la prima vera e propria pausa, pure fisiologica, che il gruppo prende dall’ispirazione infilando nel mezzo un brano oltremodo confuso arginato, in parte, dall’intimismo acustico delle successive “Buckle Up” e “Comes Then Goes” che, pure, arrivano come il rovescio della medaglia di brani altrettanto scarni ma decisamente più fortunati tra quelli pubblicati in precedenza dal gruppo.
“Gigaton” giunge quindi a conclusione con la penultima “Retrograde” e l’attesissima “River Cross”: questa citata all’unanimità da coloro che avevano avuto modo di ascoltare in anteprima l’album, inserita in uno degli spot passati durante l’edizione appena trascorsa del Superbowl e più volte oggetto nel recente passato delle performance da solista di Vedder.
La prima è una canzone onesta, che – non per scomodare il poeta – suona per l’appunto quasi più gentile che bella, mentre la seconda è senza troppi fronzoli una delle chiusure più azzeccate di sempre nella carriera dei Pearl Jam: “River Cross” ha quella profondità di pathos praticamente tridimensionale che avvolge e non sfigura se paragonata con le ballad più belle scritte dal gruppo. Che pure di questo, nel corso di tre decadi, ha campato e bene.
Che altro dire quindi? Proviamo a metterla così: se i Pearl Jam non avessero pubblicato tra il 1991 e il 1996 album non belli ma imprescindibili, allora “Gigaton” rappresenterebbe anziché una conferma un passo successivo nella loro invidiabile carriera. A cospetto di questo li ritroviamo invece nel presente, ben contenti di accoglierli nuovamente nelle nostre orecchie, tra importanti conferme, momenti pure altissimi, e altri che oscillano tra l’indifferente e il trascurabile.
Come altre band giunte a noi da un passato vicino ma al contempo lontano, anche i Pearl Jam sembrano connotarsi sempre più come scrittori di belle canzoni che non di grandi album. Umano e giusto che sia così, e allora la certezza di poter contare ancora su di loro finisce – comunque soffi il vento – per essere la cosa più importante.
Articolo Precedente
Andrea Bocelli canterà a Pasqua in Piazza Duomo a Milano, senza pubblico, in streaming. Il sindaco Sala: “Verrà trasmesso in tutto il mondo”

Articolo Successivo
Canzoni d’autore: quindici dischi adatti a tempi più lenti