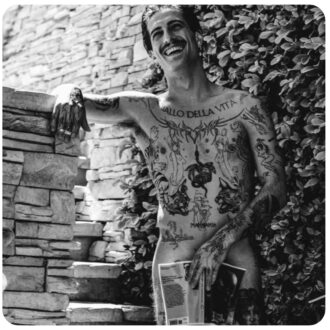Napoli da sempre vive del proprio racconto, una narrazione che risente del trauma storico dell’unità d’Italia in cui la città ha perso un’identità nazionale. Napoli è una capitale orfana del proprio regno, un lutto che non abbiamo ancora metabolizzato, come sottolineato dallo storico Marcello Ravveduto. Da allora tutta la produzione culturale partenopea, sprovvista di strutture adeguate, per farsi sentire ha dovuto spesso alzare i toni, diventare sfacciata, scostumata.
Una cultura capace di offrire contemporaneamente il meglio e il peggio di sé; trasformandosi spesso in folclore becero, inventando e interpretando una napoletanità che potesse andare bene per l’Italia unita, come racconta Raffaele La Capria ne L’armonia perduta, ma anche anticipando tendenze con linguaggi e idee nuove, come giustamente afferma Angelo Petrella, lo scrittore che ha aperto il dibattito qualche giorno fa sulle pagine de Il Fatto Quotidiano.
Ma cosa rende unica Napoli? Una città che nei secoli ha accolto ed è stata dominata da tantissime culture, senza mai perdere la propria identità? Ha ragione lo scrittore Pino Aprile quando dice che l’identità non è data dall’essere qualcosa ma dal fare qualcosa in modo originale e cioè nel rendere unico ciò che già esiste: ovvero non è una fiamma da custodire, ma un fuoco vivo che brucia. E Napoli nei secoli ha fatto proprio il cibo, i suoni e le idee che le sono arrivate nel tempo, prima dal mare e poi con i media, assorbendo come una spugna tutto per poi crearne qualcosa di nuovo.
È l’unica città italiana in cui si producono tutti i generi musicali possibili, dal folk all’elettronica, dal rock al pop, dal rap alla musica d’autore, senza mai perdere le proprie radici. Ma non essendoci case discografiche ed editori adeguati, gli artisti napoletani per raggiungere una platea nazionale hanno bisogno sempre di un quid in più che li leghi alla realtà storica.
In questa città tutto deve fare notizia, anche l’arte. È come se non bastasse scrivere belle canzoni e bei libri. È successo per la Napoli del dopoguerra raccontata da Norman Lewis e Anna Maria Ortese, che ha generato i Napoli Centrale del figlio della guerra James Senese, per poi arrivare a Pino Daniele e a tutto il Neapolitan Power, che è esploso davvero dopo il terremoto dell’80.
Poi è arrivato il papà dei neomelodici, Nino D’Angelo, a dare voce alle giovani fasce popolari di tutto l’hinterland napoletano travolte dal boom economico, un artista sdoganato solo dopo anni da Goffredo Fofi. E ancora la Napoli di Peppe Lanzetta, del rinascimento bassoliniano e dei centri sociali che ha partorito la triade: 24grana, 99Posse, Almamegretta e il fenomeno neomelodico capeggiato da Gigi D’Alessio. Nel nuovo millennio la scena rap ha dato voce a Gomorra, ovvero all’inferno della periferia napoletana dove comanda ‘o sistema, fino ad arrivare a Liberato che per arrivare alla stampa nazionale e ai grossi network si è dovuto “inventare” l’anonimato. Da Napoli ci si aspetta sempre qualcosa in più, il fenomeno, l’eccezionalità. E questo l’artista napoletano l’ha imparato bene: infatti spesso finisce per assecondare questa logica.
Negli anni gli artisti partenopei hanno affinato strategie per supplire alla mancanza di un’industria culturale. Anche per questo un cantautore, uno scrittore napoletano non può prescindere dalla propria città, un’autoreferenzialità spesso controproducente. Al punto che se va a vivere fuori Napoli è considerato un traditore. Un partigiano che ha abdicato a una guerra che ci vede soli contro tutti. Un’idealizzazione sciocca e romantica che tanto noi napoletani amiamo raccontarci. Napoli è un mondo a sé, capace di sopravvivere ai suoi eterni mali senza mai risolverli, raccontandoli.
Credo che il miglior augurio che ci si possa fare sia proprio la normalità e non solo per rilanciare la città – come giustamente scrive il giornalista Fabrizio Esposito, in risposta a Petrella. Ma forse c’è ancora una domanda da porsi: qual è il costo di questa normalità? Qualche giorno fa, parlandone con lo scrittore Maurizio De Giovanni, siamo giunti alla conclusione che se il costo è omologarsi al resto d’Italia diventa difficile capire se sia davvero un bene. Se diventare normali significa rinunciare alla nostra unicità, allora forse c’è da augurarsi che non cambi nulla.
Articolo Precedente
Artefiera, 10 eventi dedicati all’arte moderna e contemporanea da non perdere a Bologna

Articolo Successivo
Riccardo De Gennaro e Dominique de Roux, miraggi agli antipodi della narrativa