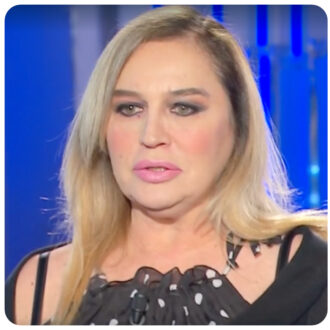Con delicatezza come si esprimeva, così è morto nel sonno a novantacinque anni Elliott Erwitt. Non perdiamo tempo con una biografia: visto ciò che ha fatto come fotografo, sarebbe ancora più lunga di quei novantacinque anni, tanto in questi momenti di biografie è piena la rete e non solo.
Certo, per chi non ne sa nulla può essere interessante per esempio sapere che ha vissuto l’infanzia a Milano, per poi fuggire con tutta la famiglia a New York, essendo i suoi genitori ebrei di origine russa, e infatti il suo vero nome non era Elliott Erwitt, bensì Elio Romano Erwitz. Oppure sapere che, nel ruolo di presidente della Magnum, fu lui a diffondere per primo gli scatti di Josef Koudelka (mantenendone l’anonimato per ovvie ragioni) della “Primavera di Praga” nel 1968.
 Voglio invece raccontare un aneddoto che forse mette in luce un aspetto decisivo sul suo approccio alla fotografia: anni fa, proprio a Milano, Erwitt incontra il pubblico in una nota libreria per presentare un suo volume, parla poco ma tutti sono attratti dalle fotografie che scorrono numerose sullo schermo alle sue spalle. Come di consueto, alla fine, il moderatore concede ai presenti l’opportunità di fare domande all’autore, e le domande arrivano. Ma qui accade qualcosa perfino d’imbarazzante. Erwitt risponde a monosillabi, qualche sì, qualche no, al massimo frasette di poche parole lasciate quasi sospese.
Voglio invece raccontare un aneddoto che forse mette in luce un aspetto decisivo sul suo approccio alla fotografia: anni fa, proprio a Milano, Erwitt incontra il pubblico in una nota libreria per presentare un suo volume, parla poco ma tutti sono attratti dalle fotografie che scorrono numerose sullo schermo alle sue spalle. Come di consueto, alla fine, il moderatore concede ai presenti l’opportunità di fare domande all’autore, e le domande arrivano. Ma qui accade qualcosa perfino d’imbarazzante. Erwitt risponde a monosillabi, qualche sì, qualche no, al massimo frasette di poche parole lasciate quasi sospese.
Apparentemente sembrava distante, disinteressato, e il pubblico appariva piuttosto deluso, magari interpretando tutto ciò come supponenza o arroganza. Non era così, e nel tempo ho trovato i segnali di una sua posizione di contestazione radicale verso una fotografia che si parla addosso, verso il mercato dell’arte che incorpora la fotografia e le impone i suoi dettami, verso la deriva della manipolazione, sia digitale che concettuale. Una sua frase rivelatrice, in questo senso, è la seguente «Quando la fotografia accade, succede senza sforzo, come un dono che non va interrogato né analizzato».
Ma di più: nelle mostre e nelle pubblicazioni si continuano a vedere le sue foto più note – tutte eccezionali, beninteso – che vanno da momenti storici a momenti di vita quotidiana, e dunque Jacqueline Kennedy al funerale del marito presidente, Nixon che “sgrida” Kruscev, Marilyn Monroe sul set, un iconico Che Guevara, ma anche le foto piene d’ironia, il mondo dei cani spesso più umani degli umani, i cortocircuiti surreali che la vita ci sa offrire, e mille e mille altre.
Ma poco vista, poco proposta, poco pubblicata è la serie di un suo progetto che va letto come un manifesto: “The art of André S. Solidor”. Si tratta di un lavoro spassosissimo ma nello stesso tempo tremendamente caustico, in cui il personaggio immaginario creato da Erwitt è un suo alter ego “fotografo artista” che produce supercazzole ammantate e infarcite di concetti astrusi e di parole, quelle dei critici, dei galleristi, e di tutto un sistema che in verità Erwitt detestava.
Elliott Erwitt ci ammonisce a usare la fotografia per quello che, secondo lui, dovrebbe essere: occasione di leggerezza, occasione d’incontri, occasione di testimonianza, occasione di vita. Raccontava Tonino Guerra che suo padre, quando lui era bambino, stava sempre zitto, e il piccolo Tonino ne soffriva, temendo si trattasse d’indifferenza o mancanza d’affetto. Molti anni dopo, Tonino ormai adulto e il padre scomparso, nella casa di famiglia il grande scrittore, poeta e sceneggiatore di Santarcangelo di Romagna trovò fortuitamente un foglietto ingiallito scritto a suo tempo dal padre, e c’era questa frase: «A volte il silenzio è un grande rumore del cuore».
(Seguimi su Facebook)
Articolo Precedente
Prophet song: così il totalitarismo si insinua in un mondo privo di empatia. Perchè Paul Lynch (Booker Prize 2023) non parla solo di Irlanda

Articolo Successivo
Ho incontrato Vec Samoano, il fotografo delle viscere