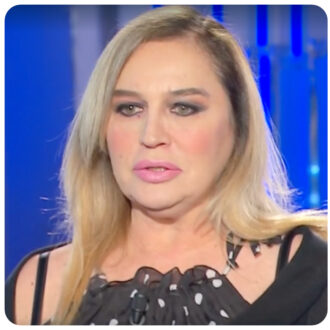Sembra quasi che non possa passare nemmeno una mezza giornata bello tranquillo il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano. Ci mancava solo lo sciopero a oltranza dei dipendenti della fondazioni liriche. La grana di una spettacolare protesta dei 3800 orchestrali e coristi d’Italia, dal Regio di Torino al San Carlo di Napoli, mette a rischio le prime più prestigiose, ne è già saltata una al Massimo di Palermo, con tanto di eterno Muti sul podio.
Questi dipendenti delle 14 fondazioni lirico-sinfoniche d’Italia lamentano che il loro contratto di lavoro non sia stato più rinnovato da venti anni, e certo non deve essere di conforto sentirsi gli unici a guadagnare così poco, rispetto ai compensi da capogiro degli esterni, che siano cantanti, direttori o registi, piuttosto che vedere colossali giri di quattrini per le scenografie, le sponsorizzazioni, le riprese televisive ecc.
Il Sottosegretario per lo Spettacolo dal vivo, Gianmarco Mazzi – uno del mestiere, fino a ieri manager all’Arena di Verona – ha minacciato di ritirare il congruo intervento ad hoc del ministero, ossia gli 8 milioni di euro in più assegnati alle Fondazioni per risolvere il conflitto sindacale. E ha ricordato, senza mezze parole, che sono un baraccone pubblico costato ai contribuenti, nel 2022 “420 milioni di euro, che equivale a 1 milione e 150mila euro al giorno”, minacciando poi di ridurre il numero di Fondazioni, o magari di farne entrare di nuove, più efficienti.
Una bella staffilata, non c’è che dire, peccato che andrebbe rivolta non tanto ai coristi e agli orchestrali ma ai sovrintendenti, alle strutture di controllo e ai poteri vari che si muovono dietro questo colossale giro di soldi e di pseudo-mondanità. Prima di tutto andrebbe ridefinita la funzione pubblica di questi grandi teatri, che non sono e non possono essere soltanto una costosissima leva per attrarre i turisti più abbienti.
Ai nostri coristi e orchestrali, peraltro mediamente bravissimi e storicamente molto più sindacalizzati di oggi, vanno casomai presentate alternative pertinenti, per esempio il valido assetto cooperativo che governa alcune tra le migliori ensemble musicali d’Europa. Più in generale è l’intero sistema del finanziamento pubblico allo spettacolo dal vivo che andrebbe ripensato, studiando magari i modelli più virtuosi, che siano l’Austria per la musica colta, il Belgio per teatro e danza, la Germania o la Spagna per l’una o l’altro, e così via.
L’Italia probabilmente è il Paese in questo senso più sbilanciato verso il ‘modello carrozzone’: il copioso flusso di denaro dei contribuenti va in prevalenza a finire negli enti pubblici, in particolare a un pugno di essi, che siano fondazioni lirico-sinfoniche o istituzioni teatrali. Le compagnie e le imprese costruite intorno ai talenti, che per esempio nelle Fiandre o in Catalogna vengono coltivate con cura, faticano addirittura a sopravvivere. E forse è indispensabile prima di tutto un ribaltamento a questo livello, ma ne riparleremo.
Chi frequenta con passione i teatri sa bene che bellezza e creatività possono sopravvivere appunto solo nelle quattro stanze dove l’artista non si deve misurare altro che con se stesso: se si vanno a a cercare i nomi che hanno segnato la svolta cosiddetta post-drammatica nel teatro contemporaneo europeo, ancora quasi trent’anni dopo il successo, bisogna scovarli in una piccola fabbrica di tabacco dismessa a Molenbeek, con l’insegna Need Company (Jan Lawers), o nel vecchio laboratorio per fabbri e tornitori di Cesena, trasformato in teatro per la Raffaello Sanzio Society (Romeo Castellucci). Anche guardando alle nuove generazioni si possono mettere in fila svariati esempi di belle compagnie di provincia, non solo a Barcellona o a Marsiglia ma anche a Bologna o a Belluno, che si sforzano di fare un teatro contemporaneo artistico e pungente.
Del resto, in Italia e forse dovunque, nei teatri pubblici scorrono tanti soldi e un personaggio di talento viene considerato, quando va bene, un caratteraccio da tenere alla larga: bisogna invece accettare i compromessi del caso per ripararsi al calduccio, nelle note istituzioni che avranno pure un passato glorioso ma è perlomeno remoto. Oggi non può esistere un grande regista inserito nel potere teatrale che pure possa studiare i suoi spettacoli a Casa del Diavolo, Gubbio, come faceva Luca Ronconi: anche il migliore autore che uscisse dal suo podere per accasarsi in questo e quel teatro nazionale, finirebbe consumato per tirar su gli incassi, se va bene, con un classico da rivisitare e una stellina da far brillare. Viceversa, se vuole difendere l’integrità artistica, sta rintanato nel suo piccolo mondo ma deve poi sudare sette camicie per raccattare i soldi qua e là ogni volta che deve montare uno spettacolo.
Ecco, il nodo da sciogliere non è quello di redistribuire i finanziamenti tra le istituzioni, ridurle o introdurne di nuove con la scusa degli scioperi e della malagestione, ma è proprio questo d’interrompere una politica miope che ha penalizzato il teatro di ricerca e le compagnie, per liberare dal giogo della burocrazia e della penuria le vere risorse artistiche, che sono le persone di talento, e far ripartire un settore che così potrebbe riscoprire la sua stessa funzione pubblica.
Articolo Precedente
Il Festival del Lamento torna anche in autunno: una giornata dedicata a Giuseppe Berto, l’autore del “Male oscuro”

Articolo Successivo
Robert Capa vs il suo erede Don McCullin: Roma capitale della fotografia di guerra