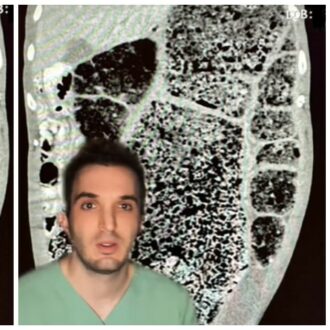Solo pochi mesi fa, il 26 maggio scorso, ci lasciava Anthony James, zozzo gestore di tavola calda (nonché assassino) ne La calda notte dell’Ispettore Tibbs (’67) di Norman Jewison, il film (con due sequel inferiori alla matrice) che ha segnato la popolarità di Sidney Poitier, scomparso ieri a 94 anni.
Sui social – come sempre inattendibili – era uscita una controbufala di una (per loro) presunta bufala: “non è vero che Poitier è morto”, ma, invece, purtroppo, era vero, come confermato da Chester Cooper, vice primo ministro delle Bahamas dove lui, novantaquattrenne, ha concluso la propria esistenza. Pur nato a Miami, dove s’era temporaneamente trasferita la sua povera famiglia di contadini (con sette figli), Poitier alle Bahamas aveva le proprie radici. Trasferitosi poi a New York, fece il lavapiatti e il clochard nelle stazioni dei bus. Queste le origini, umilissime, del futuro attore nero (forse) il più bello e (certamente) il più chic della storia del cinema, uomo dalla classe e dall’eleganza inarrivabile, grande attore, ma anche Cavaliere dell’Impero Britannico, ambasciatore delle Bahamas e dell’Unesco.
Sidney volle fortissimamente essere, durante la guerra, un soldato degli Stati Uniti e così ci volle un po’ prima di poter intraprendere la carriera artistica. Formatosi all’American Negro Theater di Harlem (erano tempi in cui il lessico politicamente corretto, almeno per i successivi trent’anni, non esisteva, basti pensare che persino Martin Luther King utilizzava il termine niger), laddove si faceva ricerca artistica sulla cultura black e dove recitava anche Henry Belafonte. Qui Poitier perfezionò il proprio inglese fino ad allora troppo ‘caraibico’. Dopo una Lisistrata a Broadway tutta ‘in nero’, Sidney abbandonò il teatro per il cinema.
Esordì, non accreditato, con una comparsata (al night club) in un “musicarello” Usa del ’47 di Arthur Leonard, Sepia Cinderella. Il suo primo ruolo importante arriva, però, solo tre anni dopo con il ruolo del chirurgo Luther Brooks in Uomo bianco, tu vivrai! di Mankiewicz, con Richard Widmark di cui diverrà grande amico. Poi accanto a Glenn Ford, insegnante in una scuola di studenti violenti e disfunzionali ne Il seme della violenza (’55) di Richard Brooks e ancora, divenendo egli stesso, anni dopo, un prof di colore inizialmente maltrattato, ma infine stimato dai suoi perniciosi allievi (La scuola della violenza, ’67, di James Clavell). Nel frattempo s’era già guadagnato un Oscar nei panni di un operaio finito per caso in una casa di suore tedesche nel bel mezzo del deserto dell’Arizona. Il film è I gigli del campo di Ralph Nelson (’63).
Con una cinquantina di film al suo attivo, però, Poitier viene ricordato (anche nei coccodrilli di questi giorni) soprattutto per Indovina chi viene a cena (’67) di Stanley Kramer (La7 lo ha mandato in onda ieri sera), accanto ai grandi Spencer Tracy (che morirà poco dopo la fine delle riprese) e Katharine Hepburn. I due attori, si sa, erano legati sentimentalmente anche nella vita. E la figlia cinematografica della coppia, l’attrice Katharine Houghton, è, nella realtà, la nipote della Hepburn. Sidney Poitier è invece un corpo estraneo a tutti gli effetti, il fidanzato nero della borghese democratica Houghton, uno stimato medico, che lei vuol sposare e presenta a mamma e papà. La famiglia, che pure si dichiara liberal, supererà gli iniziali imbarazzi solo nell’happy end.
Personalmente non amo molto questo film che giudico vagamente ipocrita, nonostante la presenza di cotanti giganti di Hollywood, mentre ribadisco il mio irrefrenabile amore per il sopracitato La calda notte dell’ispettore Tibbs (con colonna sonora indimenticabile di Quincy Jones e canzoni di apertura e chiusura di Ray Charles) che racconta il razzismo non dei liberal, quello non dichiarato ma introiettato, bensì quello dei razzisti apertamente tali del profondo sud americano degli anni 60, quello di Mississipi Burning, tanto per intenderci, con uno straordinario Rod Steiger sempre col chewing e i Ray Ban Shooter gialli e un altrettanto straordinario Sidney Poitier, in Italia doppiato da Pino Locchi, nei panni del geniale poliziotto nero costretto a indagare su un omicidio fra mille pregiudizi (e violenze) di ignoranti criminali locali ostili ai negri (il termine usato nel film).
E non si possono non citare, fra molti altri, La parete di fango (’58) di Stanley Kramer e La vita corre sul filo (’65), esordio di Sidney Pollack alla regia.
Certamente Poitier è stato un fondamentale apripista per i diritti degli afroamericani. A modo suo. Senza urla né estremismi. Con la sua innata classe. In smoking. Non è stato certo, mettendo da parte le produzioni indipendenti o le blackesploitation non hollywoodiane, uno Spike Lee e neppure uno Steve McQueen. Ma le sue lotte (buona parte dei suoi film affrontano temi di segregazione razziale) le ha condotte eccome. Ed è stato fra i primi, se non il primo, a portare quei temi sul grande schermo. E fuori. C’era, al fianco di Marlon Brando quando Martin Luther King gridava il suo “I have a dream”. E scrisse, Poitier, nel suo libro La misura di un uomo: «Ho imparato a trasformare la mia rabbia in qualcosa di positivo, altrimenti mi avrebbe distrutto».
La sera del suo Oscar 2002 per Training day, Denzel Washington, un po’ il suo erede, a Poitier dedicò la statuetta: “Seguirò sempre le tue orme, Sidney, e non c’è niente che vorrei di più”.
Articolo Precedente
Sidney Poitier, morto il leggendario attore afroamericano: vinse l’Oscar nel 1964 con I Gigli del Campo

Articolo Successivo
Golden Globe 2022, i vincitori per ogni categoria. Paolo Sorrentino a bocca asciutta