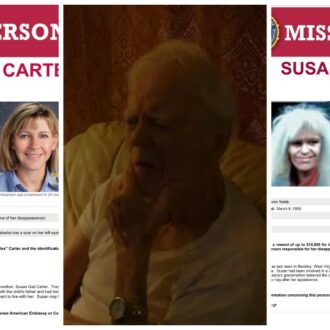Davide Brullo nasce a Milano. Classe 1979. Traduttore. Poeta. Critico. Scrittore. Saggista. Una specie di sciamano della parola. È una convinzione che mi costringe a credere che non ci sia salvezza nemmeno nel definire questo intellettuale il vincitore che sovrasta l’artificio (eppur necessario), in una crepa mostruosa, irraggiungibile a molti, la lacerazione attraverso cui intercetta un mondo sovradimensionale, non direi sovrumano, o forse sì. Forse anche.
Alchimista di locuzioni oscure, stratificate, demiurgo non traducibile in una parola che sia di consolazione all’umano, esteta parossistico di una meta-linguaggio dove il simbolismo diventa inquietudine feroce. La fame dello scrittore con Davide Brullo restituisce alacremente e con una deduzione avvelenata il ghigno di un golem lontanissimo e perduto in un deserto artico, abitato da creature intestine, latrici di implorazioni perenni. Davide Brullo è l’insidia del lettore. Per questo con buona ragione è Imperdonabile.
Di lui ho letto qualcosa, ho in testa alcuni brani dell’epistolario apocrifo “Un alfabeto nella neve” (Castelvecchi, 2018). Ho letto altro, da “Titani”, una trilogia di racconti, definito da Barbara Alberti “un capolavoro di crudeltà”. Ogni testo incontrato di Davide Brullo ti si urta contro come una catapulta. Il verbo è la roncola, nella migliore delle ipotesi l’invitante ghigliottina dove non un neofita coraggioso ammetterebbe mai di tornare indietro, ripensarvi. Linguaggio che una volta ingoiato diventa un terrore, il lettore è il condannato che non si sa sottrarre al castigo, con distinto compiacimento. Confuso dall’inganno sublime. Appunto, un vero capolavoro di crudeltà.
Eppure è l’imperdonabile. La letteratura non salva. Quale stupidità pensarlo. Men che meno scrittori come Brullo. Però il talento sappiamo non è democratico, non consola, non necessariamente indirizza al monastero di purissimo ascetismo finanche letterario auspicato dallo stesso Brullo. Piuttosto il traghettatore alle porte della disperazione svela mostruosità che chiamiamo inciampi elettivi, relazioni, memorie, inghippi dell’infanzia, mausolei della psiche dove coltivare con instancabile devozione espiazioni efferate da lanciare a ignari destinatari, facilmente suggestionabili dalla parola, esatta, precisa, tuonante, non un’altra, la sola.
Brullo: “Si scrive, infatti, per sopprimere il passato. Ma gli uomini, gli amici, gli amanti, ci confinano al presente, a ciò che siamo, gravandoci con le catene della memoria – per questo lo scrittore, alieno tra gli uomini, ha fame di solitudine”. In Brullo si dibatte l’assenza primigenia, la morte del padre, innaturale. Nell’innaturale si stabilirà l’incessante percuotersi dell’uomo, prima che lo scrittore. Nell’innaturale, l’estremo ardimento e la risalita nella china dell’asserzione desolata: si ama nella privazione.
Il vuoto è la riconduzione al seggio mancato, allo spazio dove è tolto l’assedio. Il bianco, il deserto antartico: deduce l’ombra, rifuggita altrove. L’ombra è qualcuno. Ripara nell’assenza. L’assenza è la sola identità possibile. Il totem o: un vero capolavoro di crudeltà.
Invito a leggere Davide Brullo, aggiungerei con molteplici cautele. Tuttavia la letteratura non è dei pavidi. A pagina 27 de “Un alfabeto nella neve”: “Ogni ritorno è un indizio di morte. Si ha voglia di incontrare chi abbiamo amato molti anni prima per capire qualcosa di noi che ora è perduto. Per questo, ogni ritorno è una sconfitta – le origini esistono perché abbiamo la forza, confusa e viziata, di allontanarcene. Quando non si ha più la costanza di penetrare lo sconosciuto per tornare sui propri passi, per abitare nella casa bruciata dalla memoria, si è morti – vivi come una candela che delizia la volontà dei morti”. Ed è abbastanza, io credo.
Articolo Precedente
Coronavirus, dal design di Kartell alle moto Ducati: tutti gli archivi aperti per i tour virtuali