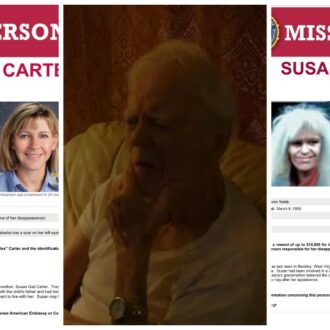“Un sassofonista cosa fa? Fa un bel respiro, poi soffia nel suo strumento fino a costruire una frase unica con il suo fiato. Così io separo le mie frasi come se fossero respiri diversi della mente”: questa frase di Jack Kerouac, tratta da un’intervista su Paris Review del 1968, conferma l’omaggio che il suo amico e sodale Allen Ginsberg aveva rivolto più di dieci anni prima, nel suo celebre poema Howl, alla grande rivoluzione musicale del bebop.
Esploso negli anni 40 nei locali di New York, grazie allo spirito anticonvenzionale di musicisti quali Charlie Parker, Thelonius Monk e Dizzy Gillespie, fondato sull’accelerazione ritmica e il grande spazio lasciato all’improvvisazione, nell’arco dei dieci anni successivi il bebop è passato da bizzarra eresia a linguaggio dominante del jazz.
Il termine, la cui paternità è attribuita a Gillespie, ha un’incerta origine onomatopeica: i musicisti con più spiccata coscienza civile lo ricollegano al suono dei manganelli dei poliziotti bianchi sulle schiene dei manifestanti neri, altri a un segnale convenzionale tra i musicisti per accordarsi durante le improvvisazioni o per evocarne il ritmo.
Come dice il sassofonista Illinois Jacquet nel libro dedicato proprio a Gillespie To be or not to bop (testo imperdibile per gli appassionati del genere, edito in Italia da Minimum fax): “Alla gente piace mettere etichette, si sa. Ma è soltanto musica, musica progressiva, musica che ha compiuto un salto in avanti. Oggi le progressioni armoniche non sono cambiate tanto; sono sempre lì, sono le fondamenta della musica. Ma è cambiato il modo di interpretarle: il modo di comporre, il modo di suonare”.
Come con tutte le correnti artistiche eversive, il rischio del recupero storico del bebop è la musealizzazione della ribellione: ovvero la riproposizione filologica di una musica nata come rivolta dirompente, la fedele trascrizione su spartito di improvvisazioni furenti, rieseguite in maniera impeccabile ma antitetica, in quanto formalmente obbediente allo spirito originario.
A questa trappola pare sfuggire Vittorio Cuculo, giovane sassofonista romano, considerato uno dei più grandi talenti della nuova generazione del jazz italiano. Accompagnato da musicisti di livello quali Danilo Blaiotta al pianoforte, Enrico Mianulli al contrabbasso e con la partecipazione straordinaria di un pilastro del jazz italiano come Gegè Munari alla batteria, Cuculo riesce a interpretare lo spirito del bebop in maniera viva e convincente.
Il suo disco d’esordio Between (Alfamusic) gioca fin dal titolo sui concetti di confine, frontiera, di punto d’incontro fra culture, stili, generi e generazioni. Non a caso, alterna la rilettura, rispettosa ma originale, di standard della storia del jazz a brani originali.
Ecco una breve panoramica del disco: si inizia con il brano Ce la posso fare, composto da Roberto Spadoni, un pezzo molto hard bop, il cui significato in apertura del proprio disco d’esordio è ben chiaro; si prosegue con In Walked Bud del geniale Monk, in piena ortodossia bebop; terzo brano è This I dig of you di Hank Mobley, pietra miliare per ogni amante del sassofono jazz; It don’t need a thing, brano composto per il disco di Enrico Mianulli, che fin dal titolo dichiara l’omaggio alla tradizione jazz; il sempiterno incanto di In a sentimental mood di Duke Ellington, in una versione particolarmente interessante; la frenesia elettrica di Cherokee, classico di Ray Noble legato alla leggenda di Charlie Parker, in cui Cuculo può mostrare tutta la sua abilità tecnica.
Ogni notte, brano composto dal pianista Blaiotta, in cui è evidente, nell’intensità interpretativa, l’omaggio del sassofonista al talento viscerale, troppo presto spezzato, di Massimo Urbani; Mr.Gomez, sempre di Mianulli, richiama il ritmo e la leggerezza, per intenderci, di Sonny Rollins in St.Thomas; You’d be so nice to come home to, gemma melodica di Cole Porter, in una versione ispirata a quella celebre di Art Pepper; Nightbird, un brano che rappresenta un orgoglio nazionale, capolavoro di Enrico Pieranunzi di cui si innamorò il grande Chet Baker e che è entrato tra gli standard mondiali nel The Real Book of Jazz; in conclusione, una versione atipica e commovente di Vedrai vedrai di Luigi Tenco, eseguita accanto al fratello Enrico Cuculo, al violino.
Il prossimo 28 dicembre, nello storico locale romano Alexanderplatz, uno dei templi del jazz in Europa, Vittorio Cuculo presenterà il suo disco dal vivo (con Jacopo Ferrazza al contrabbasso): un invito che rivolgo a tutti quelli che si lamentano delle mancanza di talento nelle nuove generazioni, senza conoscere le miniere di bellezza che possono donarci.
Articolo Precedente
Sinead o’Connor torna in Italia in tour. E a FQMagazine ha detto: “Vivo facendo quello che amo, una gioia in un’epoca in cui è un lusso anche avere un lavoro”

Articolo Successivo
Riflessioni sugli Who