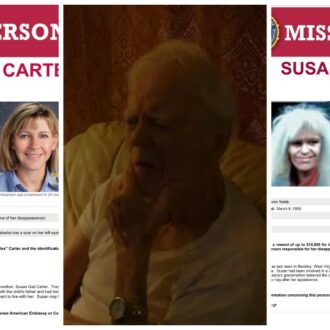Prima di annunciare l’uscita di questo Simulation Theory, i Muse avevano addirittura paventato l’idea di non pubblicare più album bensì esclusivamente singole canzoni: al che qualcuno, un po’ ovunque, aveva pure tirato un bel sospiro di sollievo. Se Matthew Bellamy e compagni hanno sì scritto pagine certo non indelebili della storia del rock recente, va loro riconosciuto di avere comunque dettato legge e proposto nuovi sbocchi al sound classico di un genere che aveva bisogno di muovere verso altri orizzonti. E in quella sottile linea che separa spesso il rock dal pop, i Muse sono maestri nel muoversi comodi. Se non meglio di tutti, comunque meglio di quasi tutti i loro colleghi. Simulation Theory è anzitutto questo, se volete: un infuso i cui ingredienti vengono dosati in maniera certosina canzone dopo canzone, che non porta con sé le palpitazioni della caffeina ma che non stucca come fosse ginseng.

L’apocalisse annunciata dalle ambizioni guerrafondaie della prima Algorithm viene smorzata, a cominciare dalla successiva The Dark Side, in favore di una rivoluzione un po’ rosa un po’ pacchiana che vede una puntura di rock quindi nell’altro singolo Pressure. Sì, perché ormai le chitarre stanno ai Muse come le caramelle e i fritti ai diabetici: non c’è da scherzare, e nemmeno da esagerare. Propaganda e Break It To Me si tengono per mano perché finiranno per essere invece gli unici due episodi veramente “hard” di questo film, che si scopre concedendosi solo se questo non costa prendere freddo: evviva il sesso, sì, ma quello coperto ancor prima che protetto. Su Something Human ci sarebbe, eccome, da stendere un velo pietoso: perché quello che proprio non si può perdonare ai Muse è di fare da colonna sonora al camerino lindo di un centro commerciale, e relegare di conseguenza la musica a sottofondo quando la volontà di muovere verso altri lidi sonori diventa una noiosa villeggiatura.
Fortuna che il nucleo centrale dell’album, collocato forse neanche per caso un po’ più in là, è contenuto nel trittico Thought Contagion, Get Up And Fight e Blockades, che restituisce al gruppo sia il prossimo singolo (spoilerato pure dall’antipaticissimo adesivo che sovrasta l’artwork frontale) che le migliori canzoni dell’intero lotto. Dig Down (rilasciata un anno e mezza fa) e The Void mettono infine il timbro certificando un atterraggio morbido che, come era stato per il decollo, non aveva destato troppe preoccupazioni nei passeggeri.
Simulation Theory è per farla breve un album che non fatica a guadagnare la sufficienza, anche se finisce per non andare nemmeno troppo oltre. È forse il primo disco dichiaratamente pop dei Muse, quello col quale salutano definitivamente le nostalgie e le reminiscenze dei primi lavori, spossati pure dalle continue richieste di chi li vorrebbe ascoltare come loro non garba più ormai da qualche anno. Il vestito che hanno scelto di cucirsi addosso calza comunque più largo che stretto, e nel complesso il tutto suona decisamente più ispirato del precedente Drones. Mi tornano a tal proposito in mente le parole – che più che tali furono quasi confidenze – di Rodrigo D’Erasmo degli Afterhours, che coi Muse ha collaborato nel recente passato e che, interpellato dal sottoscritto all’epoca proprio sulla penultima prova in studio del trio inglese, commentò caustico rivelandomi come ogni volta che si raggiunge un’audience ulteriore, tornare indietro risulta poi – più che difficile – impossibile.
Articolo Precedente
Negramaro – Clio Evans, moglie del chitarrista Lele Spedicato, svela le sue cicatrici: “Quello che non uccide, fortifica”