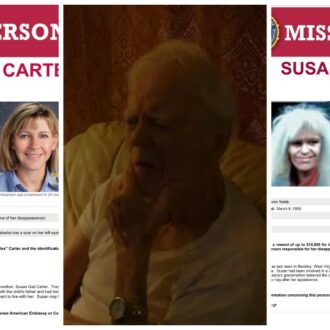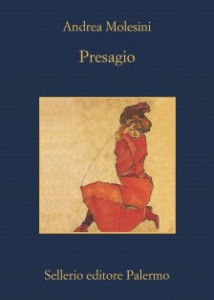 In esergo al suo ultimo romanzo, Andrea Molesini ha posto una citazione dalle Lettere a un giovane poeta di Rilke: “Il futuro entra in noi, e si trasforma in noi, molto prima di accadere”. È già un indizio. La vicenda, infatti, racconta i giorni immediatamente precedenti ‒ e successivi ‒ allo scoppio della Grande Guerra. Siamo a Venezia, dove una lancinante storia d’amore è da un canto la sottile lente d’ingrandimento che ‒ presagendola ‒ mette a fuoco l’imminente catastrofe, dall’altro l’efficace trampolino narrativo che, a ritroso, permette all’autore di ricostruire le tragiche vicissitudini della protagonista femminile, Margarete von Hayek, nobildonna la cui sensualità, dominata in apparenza con incantevole protervia, è però intimamente sfigurata da uno scabroso, indicibile segreto. Ecco allora che, tornando a Rilke, si comprende come, nell’intento di Molesini, quanto aggrava le vite dei personaggi ‒ il male oscuro, ineluttabile che vige sul loro destino ‒, anticipi tragicamente la forma del loro prossimo futuro: la catastrofe già trascorre nei loro polsi ancor prima di rendersi visibile.
In esergo al suo ultimo romanzo, Andrea Molesini ha posto una citazione dalle Lettere a un giovane poeta di Rilke: “Il futuro entra in noi, e si trasforma in noi, molto prima di accadere”. È già un indizio. La vicenda, infatti, racconta i giorni immediatamente precedenti ‒ e successivi ‒ allo scoppio della Grande Guerra. Siamo a Venezia, dove una lancinante storia d’amore è da un canto la sottile lente d’ingrandimento che ‒ presagendola ‒ mette a fuoco l’imminente catastrofe, dall’altro l’efficace trampolino narrativo che, a ritroso, permette all’autore di ricostruire le tragiche vicissitudini della protagonista femminile, Margarete von Hayek, nobildonna la cui sensualità, dominata in apparenza con incantevole protervia, è però intimamente sfigurata da uno scabroso, indicibile segreto. Ecco allora che, tornando a Rilke, si comprende come, nell’intento di Molesini, quanto aggrava le vite dei personaggi ‒ il male oscuro, ineluttabile che vige sul loro destino ‒, anticipi tragicamente la forma del loro prossimo futuro: la catastrofe già trascorre nei loro polsi ancor prima di rendersi visibile.
Fil rouge del racconto è la passione tra Margarete e Niccolò Spada. Lei, “bella come sa essere solo una donna dal piglio pari alla grazia”, è una creatura sgargiante ed affilata, capace cioè d’accendere e ferire. Ricorda certe femmes à la mode boldiniane dallo slancio già implicitamente espressionista, il cui labile contegno, d’ammiccante eleganza, prelude però a un malinconico, inconsolabile disfacimento. ‒ Dove, appunto, ogni sfarzo è già acuminata decadenza ‒. Niccolò, invece, è proprietario e direttore dell’Excelsior, il rinomato albergo emblema della Belle Époque. Nelle prime ‘inquadrature’ del libro appare ancora ligio in tutta la sua magnificenza, gremito da quell’aristocrazia europea che, prima d’essere abolita dalle raffiche delle tempeste d’acciaio, costituiva una sorta di koinè universale dei ‘gentili’, indifferente ‒ poiché orgogliosamente superiore ‒ ai confini degli Stati-nazione. Impossibile, allora, la mente non corra all’Hotel des Bains de La morte a Venezia o, più obliquamente, seguendo lo sciorinarsi dei costumi, delle sale e degli stucchi fatuamente inghirlandati, a una carrellata di Ophüls o di Visconti.
Ma veniamo ai veri caratteri del libro. Il commendatore Niccolò Spada è un uomo vigile, disincantato quanto basta per essere generosamente schivo eppure impeccabile nel non negare ai vanesi del belmondo “l’allegria che <sa> di dover elargire”. Eppure, sotto questa prima scorza, Margarete intuisce “un che di spavaldo e d’infantile, un entusiasmo ferino che la <scuote> dentro” e che la trascinerà nella passione (“i poeti la chiamano fuoco, io invece credo che sia un blocco di ghiaccio appoggiato su quel piano inclinato […], il piano è rovente e il ghiaccio scivola sul proprio sciogliersi”). Ed è infatti, letteralmente, un “entusiasmo” ‒ cioè l’essere divinamente, ritualmente inspirato ‒ “ferino” a inquietare le notti di Niccolò. L’intero romanzo è cadenzato dalla narrazione di un sogno ricorrente (non senza implicazioni simboliche). È notte. Un cacciatore esce dalla sua caverna muovendo incontro al ruggito del leone, la bestia mitica e possente, “che riluce come uno scudo d’oro”; la bestia “immensa” che tracima, imprendibile, oltre il giogo delle forme fisse: un “ammasso di curve, di cunei, di semicerchi che sbranano e sbranano”. Il cacciatore deve cogliere gli occhi del leone che forse, però, “ha le orbite vuote, come i veggenti della montagna”. Deve carpire i suoi occhi per raccontarli al pittore che sta dipingendolo ma senza quel dettaglio non può ultimare la sua opera. Ebbene, l’iride del leone, così come l’enigma di Margarete ‒ i due segreti concomitanti su cui l’intera trama poggia ‒ non si sveleranno se non alla fine, là dove ‒ come prescrive la ‘regola’ tragica ‒ l’intreccio (desis) si scioglie e libera la lýsis. Ma sul racconto non è lecito dire di più.
Mi preme invece rivelare un’altra, duplice pista. Anzitutto come, nei capitoli dedicati al sogno (ma anche nei loro continui riverberi), Molesini abbia pagine di abbandonato lirismo che, pur sotto la sorveglianza del narratore, tradiscono il timbro genuino del poeta (forse ancora un po’ sacrificato nel più ‘secco’ Non tutti i bastardi sono di Vienna). Secondariamente ‒ ed è questa a mio parere una delle più felici traiettorie interne al libro ‒, l’elemento onirico rappresenta, insieme alla vicenda, in parallelo, che si consuma nel Manicomio di San Servolo (proprio innanzi Lido), un esatto contrappunto ctonio allo sfarzo, seppur crepuscolare, dell’Excelsior. Ecco allora la Venezia mitteleuropea di Andrea Molesini, profilata dall’inconscio di San Servolo, rassomigliare ‒ per motivi e intonazione ‒ a Vienna se contemplata dallo Steinhof, l’ospedale psichiatrico progettato da Otto Wagner che, come noto, aleggia sulla città quale autentico epicentro psicoanalitico della Finis Austriae: la superba apocalisse viennese che ha segnato il tracollo di un’intera civiltà. Ed è, in ultima analisi, una medesima agonia quella che in Presagio viene sapientemente evocata. Dopo l’ecatombe della guerra di trincea, dopo il supplizio della generazione perduta, l’avvento dei partiti di massa, la riconversione tecnologica del mondo, il superamento della diplomazia ottocentesca e lo scatenarsi della totale Mobilmachung (la mobilitazione totale descritta da Ernst Jünger) come stato universale permanente dell’Occidente postbellico; con tutto questo e dopo tutto questo, nulla sarà più come prima. Una scena, amara ma indimenticabile, da La grande illusione di Jean Renoir, può forse rendere, spero con buona approssimazione, il sentire ‒ rassegnato benché eroicamente perentorio ‒ che traspare dalle pagine di Molesini.
Due ufficiali ‒ francese e tedesco ‒ scambiano alcune battute sul corso della guerra. Sono nemici, ma s’intrattengono con decorosa cordialità, sconfinando talvolta in un rapporto addirittura intimo anche se comunque compitissimo. Benché opposti sul campo di battaglia, infatti, appartengono ad una stessa aristocrazia dello spirito, della quale però non resterà più nulla.
“Ho paura che né io né voi possiamo arrestare la marcia del tempo”.
“Boëldieu, io non so chi vincerà questa guerra. La sua fine, qualunque essa sia, sarà la fine dei Boëldieu e dei Rauffenstein”.
“Forse non ci sarà più bisogno di noi”.
“E voi non trovate che sia un peccato?”.
“Forse”.
[Recensione a A. Molesini, Presagio, Sellerio, Palermo 2014, pp. 155]
Articolo Precedente
Poesia: per una rivoluzione mondiale

Articolo Successivo
Teatro Valle – giunta Marino: cronistoria di una relazione complicata