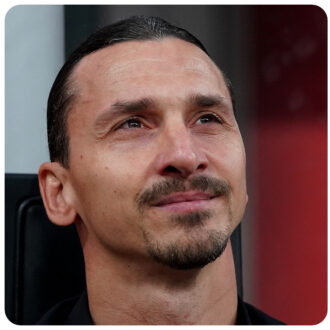Il profilo inconfondibile del carcere di Montorio si staglia ormai alle nostre spalle, nell’inverno veronese. La quindicina di donne e uomini con sentenza definitiva che partecipano al laboratorio teatrale sono chiusi in cella proprio nel momento in cui io e Lara Perbellini, sarta e costumista, stiamo parlando di loro, interrogandoci su com’è andata oggi l’attività.
All’uscita dal carcere nel tardo pomeriggio ci incamminiamo verso Verona, città severa e ordinata, sorvegliata da decine di telecamere, come ce ne sono in prigione, a proteggerne una bellezza annoiata e culturalmente stereotipata.
Al congedo, all’uscita dal carcere, la facilità, per me, e l’impossibilità, per i detenuti, di muoversi e uscire dalla struttura assume di colpo un tratto d’insieme grottesco e lancinante e disorienta nella sua immediatezza in una sensazione che va al di là della logica colpa/espiazione.
Siamo ancora immersi nel materiale emotivo della teatralità dove parole e gesti trascendono la contingenza e dove l’umanità di ciascuno sgorga su altri livelli dell’esistenza, lontano dalla condizione di segregazione di cui la struttura è continua e fisiologica testimone.
Tra le pieghe relazionali di ruoli gerarchici all’interno di strutture rigide talvolta, e grazie a un dono imprevisto e misterioso delle Arti, fa irruzione un desiderio di abbandono e condivisione di umanità pur nella differenza dei destini e nell’asprezza delle concrete realtà.
La teatralità e il suo processo disseminano l’ambiente di piccole azioni di concretezza simbolica fine a se stesse, il cui riverbero però va a traslarsi nella vita quotidiana: diversamente il teatro diventerebbe luogo di oblio laddove dev’essere spazio politico/culturale.
Alcuni approcci della pratica teatrale in carcere, nell’intrinseco valore pedagogico e politico di cui può essere in possesso, non sono comprensibili nell’immediato: la messa in scena, gli aspetti puramente formali risucchiano comprensibilmente l’attenzione, e d’altra parte la struttura carcere tende a implementare processi di reinserimento che risentono di una logica formale e meccanica che caratterizza le istituzioni disciplinari.
E invece nel mondo/teatro si vive anche di situazioni fuori/scena ad alto contenuto informale il cui senso si deposita nel futuro quotidiano delle persone. Al tempo stesso si ha effetto retroattivo perché è anche sulle esperienze fatte e sulle attuali narrazioni personali che la pratica si rifletterà facendosi emissario di nuove evolutive possibilità: “Abbiamo immaginato una vita che non è mai esistita”, mi dice Precious, in uscita dopo tre anni. “Forse”, le rispondo.
Un abbraccio, una spinta, parole inaudite, un urlo e un gemito in scena assumono la forma di una qualche possibilità nel divenire, una germinale presa di contatto non intellettualistica con le molteplici risorse di cui una persona può disporre e scoprirle. Non è una promessa rieducativa, non sta a chiare lettere in una scheda progetto, non è formattabile, ma è una possibilità iscritta nella prassi di un linguaggio (la teatralità) esposta al rischio della non riuscita. Alcuni carceri, tra cui quello di Montorio, hanno iniziato ad accogliere percorsi simili con un senso della sperimentazione che “fuori” è sempre più difficile trovare.
Disseminare luoghi come il carcere, psichiatria, comunità, periferie ecc. di piccoli atti di concretezza simbolica, di senso ulteriore rispetto alle letture della consuetudine è un’attività “minore” nel mare delle plurime, vuote, enfatiche e dominanti rappresentazioni di massa in cui il nostro Paese è immerso.
Tra lo sfarzo del festival di Sanremo e le sue canzoni e Verona, fasciata quattro giorni (dico quattro) in rosso chic per San Valentino, eccomi all’uscita di una delle sovraffollate carceri italiane, uno dei sofferti interstizio del nostro Paese, da dove, a volerlo, si vede meglio come vanno le cose in piazza.
Articolo Precedente
Poesia, Ascoltando il Prete Rosso

Articolo Successivo
Diritto d’autore: arriva il primo evento nazionale ‘esente-Siae’