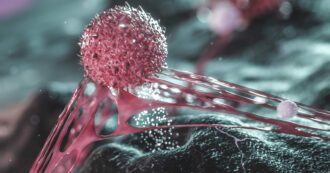Più sani per legge! Parrebbe questo lo slogan con cui il ministro della Sanità e il governo hanno approvato il decreto per ridurre del 20% le prescrizioni mediche. Se fosse così automatico guarire le persone tutto sarebbe molto semplice. Peccato che le malattie se ne freghino della legge.
Il decreto governativo parte dal presupposto che una certa percentuale delle prescrizioni di esami strumentali o visite sia inappropriata, per lo più dettata dalla cosiddetta “medicina difensiva”. In pratica i medici, anche per timore di cause da parte del paziente, di fronte a un dubbio prescrivono esami o visite per sincerarsi che non vi siano patologie al momento non ancora riscontrate.
Faccio un esempio pratico per farmi capire: un paziente si reca dal medico di famiglia perché soffre da alcuni giorni per dolori addominali. All’esame fisico non risultano dati allarmanti. Se esiste un buon rapporto fra medico e paziente forse è opportuno attuare la strategia “aspetta e vedi”, somministrando qualche farmaco che riduca la mobilità intestinale per rivalutare telefonicamente la situazione dopo alcuni giorni. Se i dolori cesseranno spontaneamente, bene; oppure si faranno, dopo alcuni giorni, ulteriori valutazioni. Se il medico, al contrario, non ha una relazione col paziente, prescriverà subito una ecografia addominale, un esame del sangue ed eventualmente una tac addominale.
Su cento pazienti, con un dolore addominale senza obiettività clinica, presumibilmente 99 avranno un’ecografia, esami e tac che non aggiungono nulla alla valutazione del medico e quindi saranno stati inutili o addirittura dannosi (radiazioni della tac). In un caso su cento però emergerà qualcosa che all’esame clinico non era ancora appalesato. Si deve notare che anche nella strategia dell’aspetta e vedi, il caso con un problema più rilevante, nell’arco di alcune settimane, verrà scoperto, perché il dolore persisterà e si mostreranno altri sintomi.
Dall’esempio citato emergono diverse domande che provo a riassumere:
1. Le 100 ecografie, esami e tac sono o non sono appropriate?
2. Visto che intasano il servizio sanitario dovrebbero essere non prescritte, con però il rischio di ritardare la diagnosi dell’unico caso più grave?
3. Il paziente che dopo un mese si ritroverà con una diagnosi per una patologia grave incolperà il medico di sottovalutazione e di cattiva pratica sanitaria, perché questi non gli ha prescritto subito gli esami?
4. Se per caso, in uno su un milione, la situazione si aggraverà velocemente portando a conseguenze ancora più critiche fino alla morte, ci sarà una incriminazione del medico?
Il decreto sull’appropriatezza prescrittiva non si pone questi dubbi. Taglia la testa al toro, mettendo in chiaro che i medici da ora in poi saranno sottoposti a controlli, reprimende e non chiare possibili sanzioni se sforano determinate percentuali nelle prescrizioni. Ridurre del 20% non sarà affatto facile per i medici. Si tratta di una percentuale “monstre” che appare insensata, pensata solo da burocrati che non hanno mai visto un vero paziente. A mio avviso si corre il rischio che la fiducia fra paziente e medico crolli. Quando mi recherò dal medico sarò sicuro che lui mi sta prescrivendo la terapia o gli esami giusti? Oppure sarò dubbioso sul fatto che potrebbe omettere certi accertamenti perché deve stare dentro ai parametri prescrittivi imposti dallo stato?
Come contribuente capisco che un eccesso di prescrizioni mediche possa essere dannosa per le casse dello Stato. Come paziente però, personalmente, me ne frego dei soldi e voglio fare tutti gli esami necessari, anche perché potrei essere io quel caso su cento o su un milione che con quell’esame scoprirebbe prima un malanno.
Il lettore capirà che ci troviamo di fronte a una sorta di dilemma, in quanto in linea generale possiamo essere d’accordo sul ridurre certi esami, mentre non lo siamo affatto nel nostro particolare.
L’unica soluzione sarebbe aumentare e non minare la fiducia che ripongo nel medico. Se mi fido del mio medico, che ho scelto e con cui ho una consuetudine di cura, lui potrà spiegarmi quale sia la strategia corretta, accettando anche qualche piccolo rischio pur di non attuare esami in eccesso che possono, tra l’altro, essere dannosi. La personalizzazione della cura è fondamentale, ma si può raggiungere solo con una conoscenza prolungata fra medico e paziente. Il governo, invece di promulgare “grida di manzoniana memoria” destinate ad essere disattese dai medici più coscienziosi, dovrebbe lasciare la più ampia libertà di cura al medico.
Se esistono, come appare chiaro, problemi di compatibilità economica, il governo si dovrà assumere la propria responsabilità, senza scaricarla su altri (ad esempio riducendo le spese per amministrativi e politicanti nella sanità per aumentare i medici e gli infermieri).
Articolo Precedente
Europee, esasperanti le pagine sulla salute nei programmi elettorali dei primi partiti italiani