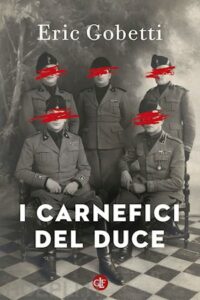Nella notte tra il 24 e il 25 luglio del 1943, dopo una riunione di circa dieci ore a Palazzo Venezia, il Gran Consiglio del Fascismo, l’organo supremo del regime, a carattere consultivo, composto da 28 membri (tra cui veterani della marcia su Roma, ministri, il presidente del Tribunale speciale, il comandante della Milizia Volontaria, i presidenti delle Camere, il segretario del partito) fu convocato di nuovo dopo 4 anni. L’ultima volta si era riunito quattro anni prima, cioè all’inizio della guerra: da allora Benito Mussolini aveva iniziato a prendere in larghissima autonomia molte delle sue decisioni. Durante quella riunione notturna fu messa ai voti la proposta di Dino Grandi, presidente della Camera dei fasci e delle corporazioni, che prevedeva che Mussolini rimettesse i suoi poteri al re Vittorio Emanuele III. Quella notte iniziò la caduta a effetto domino del regime, proseguendo nell’ambigua dinamica di dialogo tra ciò che ancora era lo Stato (monarchico) e ciò che ancora era il Partito Nazionale Fascista. Anche queste ambiguità introducono le future contraddizioni di un superamento formale del regime, senza
avere mai fatto i conti con i suoi crimini e le sue eredità. Gli anni di mediazione tra Stato e Partito, la penetrazione del fascismo nelle strutture dello Stato, il successivo mantenimento del personale burocratico, di molti riferimenti giuridici e istituzionali, le mancate epurazioni: tutto ciò ha comportato cambiamento ma anche mantenimento di canali di continuità e conservazione di culture e pratiche politiche e di potere che hanno percorso le trasformazioni della politica italiana, anche dopo la caduta di Mussolini. Con effetti chiari fino a oggi.
In Italia non si è mai riusciti a fare i conti con il suo passato. Eric Gobetti, storico, è in libreria con I carnefici del duce (Laterza) che ricostruisce la vita e le storie di alcuni degli uomini che hanno ordinato, condotto o partecipato fattivamente alle brutali violenze del regime in Libia, in Etiopia, in Grecia, in Jugoslavia. Fatti spesso rimossi del passato italiano. “In un mondo ideale – scrive Gobetti – nessuno avrebbe sentito l’esigenza di scrivere un libro sui crimini di guerra commessi durante il Ventennio fascista. Perlomeno non a tanti anni di distanza dai fatti. Perché in quel mondo ideale l’Italia avrebbe già ampiamente fatto i conti con il suo passato”. Ma così non è stato e le conseguenze di ciò sono molteplici.
Dopo la fine della guerra in Italia non si è tenuto un procedimento giudiziario volto a condannare i fascisti e i loro crimini – come nei casi di Norimberga o Tokyo. Gobetti sottolinea la centralità della rapidità e lacunosità del processo di epurazione dell’apparato fascista (sostanzialmente fallito), della mancata condanna delle gerarchie fasciste, del predominio politico e culturale dell’opzione anticomunista nel dopoguerra, nel processo di rimozione di responsabilità della classe dirigente italiana del Ventennio. Questi processi, i crimini di guerra fascisti compiuti nei teatri coloniali e nei territori occupati oltre Adriatico, nel cuore dell’Europa e in alcuni casi anche all’interno dei confini italiani dell’epoca sono come un “elefante nella stanza”, “l’elefante dentro la nostra stanza”. È difficile da ignorare, ma ci riusciamo benissimo. Dunque, Gobetti ci racconta delle storie cadute nell’oblio della memoria pubblica, rapidamente fuoriuscite dalla divulgazione, dalla manualistica scolastica, dalla politica memoriale.
Gobetti parte dai fatti e ci fornisce un utile promemoria su tutte le guerre condotte dal fascismo a partire da quelle africane, in Libia (1928-1932) e in Etiopia (1935-1936), e dalle successive repressioni contro i locali movimenti di indipendenza. Ci racconta della sistematicità di queste violenze e dell’oppressione di molte popolazione soggette all’occupazione italiana in epoca fascista non come episodi marginali ma come elementi strutturali, che dovrebbero far parte integrante della storia del Paese, come mostrano gli stessi numeri: 85mila militari italiani impiegati con compiti di occupazione, antiguerriglia, in Francia, nei Balcani e nelle isole del Mediterraneo; centinaia di migliaia di soldati impiegati in Libia, Spagna, Etiopia e nelle altre colonie africane. Gobetti ci racconta di 3mila civili morti nella Slovenia annessa; in Etiopia, solo durante la Resistenza, 75mila patrioti e 110mila civili uccisi; in Libia tra i 60 e i 140mila morti. Secondo calcoli recenti (che sono comunque parziali e limitati, poiché è impossibile contare, ad esempio, i morti per fame a causa delle guerre) l’esercito italiano sarebbe, direttamente o indirettamente, responsabile della morte di 250mila jugoslavi, 100mila greci, 500mila etiopi, 100mila libici. Questi numeri svelano la portata drammatica delle politiche espansioniste fasciste e si contrappongono a quell’idea radicata di un popolo vittima e innocente, di Italiani brava gente, di soldati “troppo buoni” per vincere la guerra.
Gobetti non ci riporta solo questa dimensione quantitativa ma anche il difficile rapporto tra dimensione individuale e collettiva alla base di questi stessi crimini. In sostanza tali violenze sono state commesse da individui, come risultato di un pensiero e di un’azione collettiva, all’interno di un sistema gerarchico basato su ordine e disciplina. Gobetti racconta le storie di molti che furono tristemente famosi per la durezza con cui “interpretarono gli ordini” e causarono molte morti. Emblematico il caso del generale Mario Roatta, che comandò la Seconda armata di stanza in Slovenia, Dalmazia e Croazia e riuscì a riparare nella Spagna di Franco quando la Jugoslavia cercò di processarlo per suoi crimini.
Parla di nomi noti, coinvolti in vicende già conosciute dagli storici ma cerca di porsi una domanda fondamentale, cioè cosa spinse verso quei crimini? Erano tutti sadici assassini o forse la risposta va cercata oltre l’individuo? Per Gobetti è importante conoscere quegli eventi attraverso le testimonianze ed esperienze per ricondurli non a colpe individuali, o lontane ombre del passato, ma a frutto di un sistema di pensiero che ha prodotto quei crimini, che si discosta radicalmente dal mito del bravo italiano e che richiama una sfera di valori che comprendono militarismo, nazionalismo, maschilismo, razzismo, culto della gerarchia e della violenza, disprezzo per la marginalità e per la debolezza. Questa sfera di valori è ancora molto diffusa e talvolta, elevata a modello politico. Dunque assumere la consapevolezza storica di quei crimini e di ciò che ha spinto alla loro esecuzione, assumerne la responsabilità all’interno di una politica memoriale che va radicalmente riscritta è nodale per aprire gli occhi su ciò che un certo tipo di mentalità può comportare e sul rischio del suo ripresentarsi in altre forme poiché prendere coscienza del modello politico che ha prodotto quei crimini significa “contribuire a rendere adulta e consapevole la nostra democrazia, in grado di riconoscere gli errori passati e imparare a non commetterli più nel futuro. Non ammettere invece quei crimini, continuare a negarli o a ignorarli, significa, al contrario, esporre il Paese al ritorno di quel modello politico o, peggio, ritenersi ancora complici o eredi di quell’ideologia”.
***
Nella foto in alto | 31 luglio 1942: soldati dell’esercito italiano fucilano degli ostaggi sloveni di Dane, nella zona di Loška Dolina (fonte: album ufficio stampa del governo della Repubblica Popolare di Slovenia)
Articolo Precedente
Storia del 25 luglio 1943, quando i fedelissimi del Duce lo spinsero verso la fine. “Ma non era il loro obiettivo. Decisivo fu il ruolo del re”