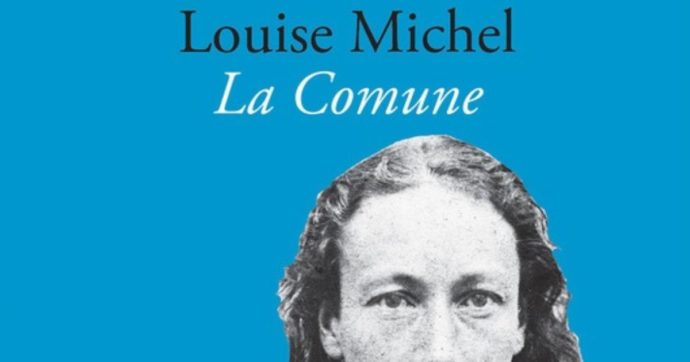In occasione del 150esimo anniversario della Comune di Parigi (18 marzo – 28 maggio 1871), Edizioni Clichy pubblica “La Comune”, il resoconto dalle barricate scritto da Louise Michel. Maestra elementare e rivoluzionaria del primo governo socialista della storia, Michel è la “Vergine Rossa” cantata da Hugo e Verlaine. Nata nel 1830, si rifiuta di giurare fedeltà all’imperatore e fonda una delle prime scuole laiche a Parigi. Anche per questo è considerata tra le pioniere dell’educazione moderna, nonché del femminismo. Nel 1871, dopo essere stata in prima linea sulle barricate della Comune, finisce davanti al Consiglio di guerra del governo di Francia e dice: “Non fatemi grazia, perché se dovessi un giorno recuperare la libertà, sarebbe per vendicare le vittime da voi sacrificate“. Verrà così condannata alla deportazione in Nuova Caledonia. Ilfattoquotidiano.it pubblica l’introduzione integrale di Chiara Di Domenico che ha curato la nuova traduzione dell’opera: “Non fate di Louise Michel un’icona per bambine ribelli. Lei le bambine le istruiva. Piuttosto, statela a sentire come si fa con le maestre, quelle brave”.
Parigi, 2021. Là dove c’erano le barricate, oggi c’è la città.
A Saint-Sulpice, per esempio, al posto di un negozio di saponette e souvenir c’era forse quella bottega di articoli sacri da cui la pallida signora Richoux esortò a prendere le statue dei santi per farne i basamenti di una delle ultime barricate della Comune.
C’è la collina del Sacro Cuore dove la gioventù di tutto il mondo viene a prendere il sole nelle ore calde della giornata. La basilica del Sacro Cuore che, seduta sopra Montmartre, sorveglia la città nell’esatto punto da cui il popolo per la prima volta poté ribellarsi ai padroni. Ci vorrebbe un cartello che, assiemeal pregio dei marmi ridondanti, illustrasse a tutto il mondo che furono quegli stessi padroni a erigerla, come ex voto, dopo aver ammazzato trentamila concittadini.
Non sanno, i giovani di tutto il mondo, mentre bevono una birra al bistrot Aux Folies a pochi metri dalla metropolitana di Belleville, o forse qualcuno sa. Forse lo sa chi da quella stessa strada sale verso Père-Lachaise, al cimitero, non tutti per Oscar Wilde o Jim Morrison. Forse qualcuno sa che lì è stata combattuta una delle ultime battaglie della Comune, quella in cui la Vergine Rossa, Louise Michel, sparava insieme ai suoi compagni in mezzo alle tombe. Fino all’ultimo colpo. Libertà o morte.
Ma andiamo per ordine.
 Parigi, 1870. La città dei boulevard, delle strade grandi fatte per il progresso: basta col pavé, buono al massimo per qualche barricata o sassaiola estemporanea, e viva il moderno bitume adatto allo scorrimento veloce dei mezzi. Basta con l’angustia delle vie strette del Quartiere Latino, o peggio, delle latrine a cielo aperto dei quartieri periferici, specialmente quelli a Est come Belleville, Montmartre o Neuilly. È la Parigi delle luci, questa di Napoleone III, il piccolo imperatore che con malcelato fastidio tollera gli epiteti del popolo che lo chiama Badingue, come un famoso nano dell’epoca. Lo stesso Napoleone che ha tradito e trucidato la Repubblica romana vent’anni prima.
Parigi, 1870. La città dei boulevard, delle strade grandi fatte per il progresso: basta col pavé, buono al massimo per qualche barricata o sassaiola estemporanea, e viva il moderno bitume adatto allo scorrimento veloce dei mezzi. Basta con l’angustia delle vie strette del Quartiere Latino, o peggio, delle latrine a cielo aperto dei quartieri periferici, specialmente quelli a Est come Belleville, Montmartre o Neuilly. È la Parigi delle luci, questa di Napoleone III, il piccolo imperatore che con malcelato fastidio tollera gli epiteti del popolo che lo chiama Badingue, come un famoso nano dell’epoca. Lo stesso Napoleone che ha tradito e trucidato la Repubblica romana vent’anni prima.
È la città di Haussmann, urbanista che guarda avanti, e pensa (in grande) alle capitali d’Europa come centro di grandi scambi, di ottimi affari, del benessere per tutti, a patto che siano disposti a tutto per averlo. I cittadini devono abituarsi a vedere ciò che non possono permettersi, per abituarsi a desiderarlo: vetrine scintillanti, bellissime donne, mezzi sempre più veloci.
La città della Grandeur, la Parigi di quell’ultimo impero che per tenersi giovane prepara la solita guerra ai cugini tedeschi, quella che poi finirà con la disfatta di Sedan, l’assedio prussiano di Parigi, la nascita della Comune il 18 marzo, il crollo dell’impero, la nascita di una Repubblica reazionaria che sgozzerà la Comune nella settimana di sangue.
Ma intanto, nei quartieri popolari dove meno di una casa su dieci è collegata alle fogne e otto su dieci sono illuminate a candela, una signorina minuta dai tratti mascolini, gli occhi grandissimi e l’espressione seria cammina di buon passo come ogni giorno verso la sua scuola. Una scuola per ragazze, per insegnar loro un lavoro, a scrivere due righe, a far di conto. Quanto basta, insomma, per non farsi fregare. La scuola è a Montmartre e la gestisce, insieme a sua madre, Louise Michel, la signorina minuta che in queste righe abbiamo già visto imbracciare una carabina a Père-Lachaise e camminare svelta verso le sue alunne.
Sono venute a Parigi dall’Alta Marna, da un castello diroccato dove la madre era a servizio e dove Louise è cresciuta serena: è figlia di un amore illegittimo, ma anche sincero, così sincero da darle forza per una vita intera. Ora abitano in una piccola casa contigua alla scuola che Louise ha fondato coi soldi della sua dote: ha deciso che, coi tempi che corrono, meglio insegnare come stare al mondo a centinaia di ragazzini del popolo, anziché a due o tre soli tutti suoi. Insegna geografia antica, lettere, disegno, ma è facile che le maestre si scambino le materie tra loro. A proposito, Louise è maestra perché, all’epoca, quello di insegnante è l’unico diploma che la società riconosce alle donne. E se Louise apre una scuola laica e privata è perché ha avuto il capriccio di non giurare fedeltà a Badingue: niente giuramento, niente posto alla scuola statale. Ma per fortuna ha una dote e decide di fondarla da sola, libera e aperta a tutte e a tutti.
Per capire la tempra della donna di cui stiamo parlando basta guardare il suo ritratto più noto, una fotografia a mezzobusto. Seduta, le braccia conserte, si intravede lo schienale di una seggiola, si vede un vestito austero e decoroso, senza fronzoli. Come i suoi capelli tirati indietro e disordinati, la bocca che non cede a un sorriso da fotografia, gli occhi vivi che ci fissano intensamente. Come a dire: «Via, ’sta foto falla bene e falla alla svelta, che c’è un mondo da cambiare e non ho tempo da perdere con queste frivolezze da cocotte e Napoleoni». Soffermandosi a guardarlo, quel ritratto, si ha la sensazione che sia vivo.

Come certi crocifissi in certe vecchie chiese, che ti seguono tra le navate con lo sguardo. Tanto animo non se ne va in quattr’e quattr’otto da questo mondo, e poi lei aspetta ancora, perché il suo lavoro non è finito. «La folla oggi è muta, ma domani ruggirà come l’Oceano. Torneremo, fiumana senza numero, spettri vendicatori, verremo tenendoci per mano». Louise sa che c’è ancora tanto lavoro da fare, forse non finirà mai.
In effetti, per tutta la vita, non si è fermata mai. Dal 1830, anno della sua nascita, al 1873, anno della sua deportazione in Nuova Caledonia, vede appena il piccolo paese natale di Vron-court-la-Côte e Parigi, e poi, nel maremoto degli eventi, la Comune, la prigione e la condanna alla deportazione e in seguito l’amnistia nel 1880: l’Oceania, Sidney, il Capo di Buona Speranza, il Canale di Suez, Londra. Quell’Internazionale a cui aderì già negli anni Sessanta dell’Ottocento la prende in parola scaraventandola nella storia e nel mondo, e lei è davvero la Vergine Rossa, dedita anima e corpo all’Idea.
A vent’anni intraprende una corrispondenza con Victor Hugo, a cui seguirà qualche incontro di persona su cui i più maliziosi non hanno mancato di piazzare l’immancabile pettegolezzo, arrivando ad attribuirle una figlia frutto dell’infallibile caccia dello scrittore. Anche Paul Verlaine le dedicherà una ballata.
Sarà al centro delle cronache della Comune, proprio grazie al suo carattere indomito, alla parlantina sciolta che la porta a mettersi in mostra – suo malgrado – al processo, dove chiede per se stessa la pena di morte visto che, dichiara, appena libera la prima cosa che farà sarà vendicare i suoi compagni e proseguire la lotta per la rivoluzione sociale. Lupa assetata di sangue per i giornali della reazione, «Bonne Louise» per quelli della rivoluzione.
È tra le poche donne, forse l’unica che, dalla prigione, riesce a scrivere lettere di fuoco ai suoi stessi carnefici esigendo e ottenendo ascolto. Lettere come questa:
Alla Commissione di Grazia
Prigione di Auberive, 28 luglio 1872, 7 del mattino
Signori,
Finalmente arrivano le vacanze; andate a far buona villeggiatura nelle vostre proprietà, il grano dovrebbe essere bello quest’anno,
ben concimato com’è stato dal sangue umano.
Fate buona caccia, Signori, la polvere per voi è a buon mercato,
poi la caccia, lo sapete, è un gioco da signori. Selvaggina e figli del
popolo, in ogni caso un bel bottino.
Divertitevi! Ma non dimenticate che noi non dimentichiamo.
Andate, andate! Non lasciateveli scappare!
Louise Michel
Ma che cos’è questa rivoluzione sociale, questa Comune i cui centocinquant’anni cadono in un ventunesimo secolo che ha visto l’Internazionale trasformarsi in globalizzazione e il capitalismo cambiare forma come fosse un mostro imbattibile?
Marx definisce la Comune il primo governo del popolo operaio, Bakunin la prima rivoluzione della città operaia contro lo Stato dei proprietari nobili e dei borghesi.
Di certo, è la prima vera guerra civile operaia, proletaria: a nemmeno cent’anni dalla Rivoluzione francese, Parigi è la capitale di quel «socialismo del sentimento» che non fa strategie, come invece succederà più tardi in Russia, ma assalta il cielo, annega nel sangue, resta nella storia come un mito, una leggenda, e continua ad accendere gli animi come solo chi muore giovane sa fare. Invece di fare uno Stato, la Comune fa letteratura. O il successo, o la gloria: questo è il dilemma.
La Comune è, prima di tutto, una tragedia. Intesa come messa in scena di un dramma umano che ancora oggi ci parla. A differenza della tragedia greca, dura non un giorno, ma nove settimane. Nove settimane in cui una città messa sotto assedio dall’ennesima guerra decide, anziché recitare la parte del solito coro di vittime, di diventare protagonista corale di una rivoluzione.
Tante cose succedono per la prima volta a Parigi tra il 18 marzo e il 28 maggio 1871. Per la prima volta sono gli operai a insorgere, per la prima volta almeno una parte di loro gode dell’istruzione minima che gli permette di scegliere il proprio destino e non vedere il padrone come un semidio a cui obbedire o rubare. Per la prima volta sono le donne ad aprire le danze, impedendo ai soldati governativi di portar via i cannoni di Montmartre che il popolo di Parigi ha comprato con una sottoscrizione cittadina per difendersi dai prussiani. E questa prima battaglia la vinceranno loro, «convertendo» molti soldati alla rivoluzione. Donne, e insieme a loro tanti ragazzini, come i Ragazzi perduti, leggendaria milizia di adolescenti che scelsero di morire combattendo piuttosto che crescere servi. Per la prima volta si vede l’importanza delle grandi città, più importanti degli imperi ormai boccheggianti. L’importanza delle grandi città è nei quartieri dove la gente ha in Comune la vita: la povertà come l’amore, la rabbia come la solidarietà, le miserie e la speranza in un avvenire migliore. Non a caso il racconto di Louise Michel sui giorni della Comune inizia proprio con l’agonia dell’impero di Napoleone III, la farsa di un impero già morto che non vuole morire, una farsa che ricorda la fine di ogni potere, le stesse menzogne. È anche la prima volta di uno sterminio fratricida nel cuore della moderna Europa, in cui i soldati di leva delle province, non tutti convertiti alla causa, anzi ostili, si accaniscono sui parigini vedendoli come parigini e non come francesi; è la prima volta dei rastrellamenti di massa, delle esecuzioni sommarie, degli errori di Stato mai ammessi, delle fosse comuni. È la prima e ultima volta della buona fede: forse la Comune è l’unica rivoluzione di gentiluomini, che hanno riguardo dei culti, che non uccidono quasi mai, che rispettano persino la Banca Nazionale che li sbeffeggia non aprendogli le porte e passando i soldi al governo per schiacciarli.
È anche la prima volta delle immagini che fanno la storia: insieme alla lotta contro il brigantaggio in Italia, la Comune è forse il primo caso europeo in cui giornali e fotografie hanno un ruolo di primo piano. In Italia si fotografano i briganti per propaganda, agghindandoli come criminali da baraccone a uso e consumo del consenso savoiardo; in Francia si fotografano i «briganti comunardi» al muro, o già nelle bare, mentre reazionari e rivoluzionari si contendono l’opinione pubblica a colpi di affissioni pubbliche e, soprattutto, di articoli di giornale.
Tutto il libro di Louise Michel è venato di questi resoconti, di una parte e dell’altra.
Un’avvertenza per chi si appresta a leggere queste pagine. Non aspettatevi una scrittrice. Louise Michel non aveva tempo, e credo nemmeno un’eccessiva simpatia, per gli intellettuali e gli intellettualismi. Per lei le Lettere dovevano essere utili, non necessariamente belle. In più, non aveva una grande opinione degli artisti coevi: tranne Hugo e Courbet, altri come Zola si guardarono bene dallo sporcarsi le ghette nell’affare della Comune e dal lottare al fianco di chi sapeva di andare a morire. Se sui moti del ’48 è un florilegio di contributi, sulla Comune regna un silenzio degli scrittori quasi imbarazzante. Perché per la prima volta non sono loro i protagonisti, e chi gli ha rubato la scena sono operai, piccoli artigiani, carrettieri e vinai semianalfabeti, troppo diversi da loro e che non amano che si venga a far poesia su miserie che di poetico non hanno niente. Loro non amano la bohème, invenzione da borghesi. Un miserabile che si veste bene è progresso, un ricco che si veste da miserabile o è un santo o gioca. Per la prima volta, i miserabili hanno deciso di prendersi insieme al potere anche la parola. Louise Michel non si fida troppo degli artisti. Parlano, parlano, ma che lavoro fanno? È il lavoro che garantisce la libertà a tutti, indipendentemente dal ceto. Dunque, se non lavori, o sei ricco o, peggio, sei cortigiano. E se sei cortigiano, non puoi essere libero.
Anche per questo, La Comune di Louise Michel è un testo quasi dimenticato. Perché non è bello, e a dirla tutta, nemmeno lei lo è. E nemmeno la storia che stiamo per raccontare, così piena di sangue e di dolore, di rabbia e di addii. Questo libro vuole testimoniare. Nella letteratura dell’epoca è considerato un ibrido tra un diario, un racconto corale, un saggio e una cronaca.
I fatti riportati vengono raccolti dalla Michel al ritorno dalla colonia penale in Nuova Caledonia, nel 1898, e dopo un’ulteriore reclusione di qualche anno. Molti dei suoi scritti sono andati persi, come ammette lei stessa. Resta un ricco epistolario, alcune opere poetiche, alcune opere teatrali. Ecco il teatro che torna.
Leggete questo lungo racconto come la mise en éspace di un immenso coro di protagonisti. Non lasciatevi impressionare dalla mole capillare di fatti raccontati, dalla pletora di nomi: lo fa perché è l’unico modo per permettere di vivere in eterno a chi è morto per l’eternità dell’Idea. Tutti devono essere ricordati, tutti sono importanti.
L’edizione che avete tra le mani nasce sulla traccia di quella italiana più popolare, pubblicata da Editori Riuniti e allegata in omaggio agli abbonati di «Rinascita», nel 1969. Alcune parti sono state espunte per non appesantire le cronache con eccessivi appunti militari, politici ed economici e mostrare al lettore, quanto più possibile, l’umanità che respira ancora in queste pagine, con qualche recupero dal testo francese originale.
Quell’umanità, che senza pensarci troppo centocinquant’anni fa ha preferito nove settimane di vita vera a una vita intera di sopravvivenza, è ancora con noi. Ci invita a imparare dai suoi errori, senza dimenticarci mai che vivere non è sopravvivere, e che non bastano un intellettuale e un aperitivo per fare la rivoluzione, né un artista milionario senza volto e senza nome e la sua barca in mezzo al mare, anche se la barca in questione si chiama per ironia del destino «Louise Michel».
La rivoluzione si fa in città, nelle strade e nelle scuole, nelle case e nei giorni anonimi della gente con un nome e un cognome; la gente, appunto, Comune.
Infine, voglio dedicare il ritorno di questo libro, e di Louise Michel in Italia, a quelle donne che, in mezzo al chiasso delle battaglie cosiddette «di genere» e «di orgoglio», ogni giorno in silenzio lavorano armate di grazia e pazienza per recuperare pezzetto per pezzetto una civiltà vecchia e scricchiolante e consegnarla a chi verrà dopo. Civiltà del lavoro, dell’istruzione, dell’amore. La lotta di queste donne non ha niente a che fare col potere, ha a che fare con la pazienza e con l’attenzione, con la fatica e con l’intelligenza. Questo libro è per chi non brandisce la sua femminilità come un’arma per il potere, per chi non usa i mezzi del potere per combattere il potere. È per chi preferisce gli eroi alle vittime, l’azione ai piagnistei, il coraggio all’indignazione. Louise Michel diceva che dove c’è rivoluzione non c’è potere, e dove c’è potere non c’è rivoluzione.
«Le donne non si chiedevano se qualcosa fosse possibile o impossibile: se ce n’era bisogno, riuscivano a farlo. Hanno voluto far delle donne una casta, e sotto la pressa degli eventi che le schiacciava, la divisione si è compiuta. Di certo non ci hanno consultato al riguardo, e noi non dobbiamo consultare nessuno. Non valiamo più degli uomini, ma a differenza loro il potere non ci ha ancora corrotte». Lo scriveva alla fine dell’Ottocento.
Quindi non fate di Louise Michel un’icona per bambine ribelli. Lei le bambine le istruiva. Piuttosto, statela a sentire come si fa con le maestre, quelle brave.
Chiara Di Domenico, Milano, 1° dicembre 2020
Articolo Precedente
Dopo le elezioni del presidente della Repubblica, torniamo alle urne con Letta e Conte

Articolo Successivo
+Europa tra truppe di iscritti fantasma e opacità nei finanziamenti. Così un software ha reso il partito scalabile e senza trasparenza