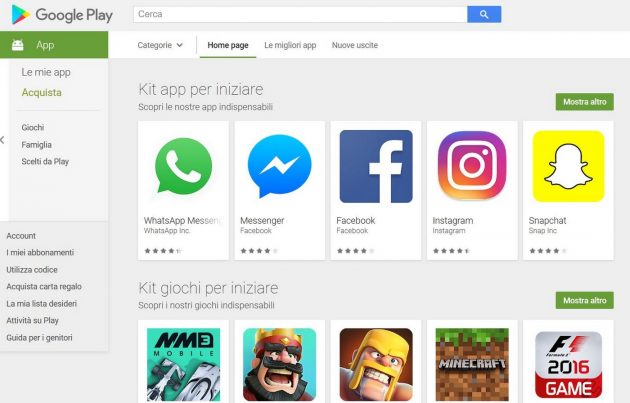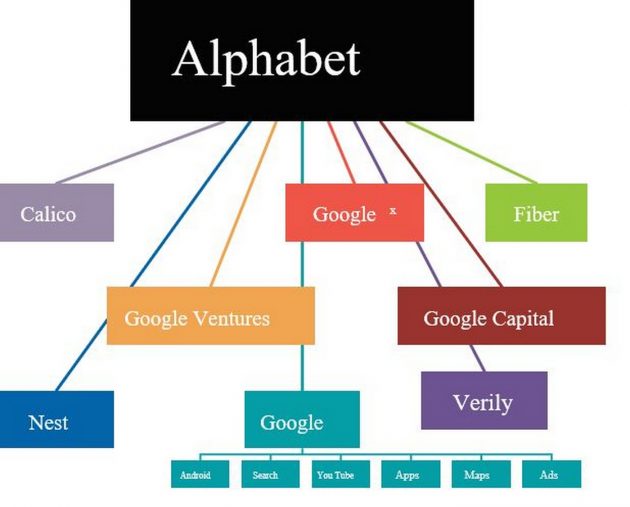Roma, 25 apr. (Adnkronos) - "Senza memoria, non c’è futuro". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 25 aprile, celebrando l'anniversario della Liberazione a Civitella in Val di Chiana, in Toscana, dove nel 1944 i nazisti trucidarono 244 persone. "Aggiungo - utilizzando parole pronunciate da Aldo Moro nel 1975 - che 'intorno all’antifascismo è possibile e doverosa l’unità popolare, senza compromettere d’altra parte la varietà e la ricchezza della comunità nazionale, il pluralismo sociale e politico, la libera e mutevole articolazione delle maggioranze e delle minoranze nel gioco democratico'", ha affermato il capo dello Stato.
"All’infamia della strage di Marzabotto, la più grande compiuta in Italia, seguì un corollario altrettanto indegno: la propaganda fascista, sui giornali sottoposti a controlli e censure, negava l’innegabile, provando a smentire l’accaduto, cercando di definire false le notizie dell’eccidio e irridendo i testimoni. Occorre – oggi e in futuro - far memoria di quelle stragi e di quelle vittime e sono preziose le iniziative nazionali e regionali che la sorreggono. Senza memoria, non c’è futuro".
"Con queste barbare uccisioni, nella loro strategia di morte, i nazifascisti cercavano di fare terra bruciata attorno ai partigiani per proteggere la ritirata tedesca, di instaurare un regime di terrore nei confronti dei civili perché non si unissero ai partigiani, di operare vendette nei confronti di un popolo, considerato inferiore da alleato e, dopo l’armistizio, traditore. Si trattò di gravissimi crimini di guerra, contrari a qualunque regola internazionale e all’onore militare e, ancor di più, ai principi di umanità", ha affermato.
"Nessuna ragione, militare o di qualunque altro genere, può infatti essere invocata per giustificare l’uccisione di ostaggi e di prigionieri inermi. I nazifascisti - ha ricordato il capo dello Stato - ne erano ben consapevoli: i corpi dei partigiani combattenti, catturati, torturati, uccisi, dovevano rimanere esposti per giorni, come sinistro monito per la popolazione. Ma le stragi di civili cercavano di tenerle nascoste e occultate, le vittime sepolte o bruciate. Non si sa se per un senso intimo di vergogna e disonore o per evitare d’incorrere nei rigori di una futura giustizia, o, ancora, per non destare ulteriori sentimenti di rivolta tra gli italiani".
"Una lunga di scia di sangue ha accompagnato il cammino dell’Italia verso la Liberazione - ha sottolineato quindi il capo dello Stato - Il sangue dei martiri che hanno pagato con la loro vita le conseguenze terribili di una guerra ingiusta e sciagurata, combattuta a fianco di Hitler nella convinzione che la grandezza e l’influenza dell’Italia si sarebbero dispiegate in un nuovo ordine mondiale. Un ordine fondato sul dominio della razza, sulla sopraffazione o, addirittura, sullo sterminio di altri popoli. Una aspirazione bruta, ignobile, ma anche vana. Totalmente sottomessa alla Germania imperialista di Hitler, l’Italia fascista, entrata nel conflitto senza alcun rispetto per i soldati mandati a morire cinicamente, non avrebbe comunque avuto scampo. Ebbe a notare, con precisione, Luigi Salvatorelli: 'Con la sconfitta essa avrebbe perduto molto, con la vittoria tutto…'" .
"Generazioni di giovani italiani, educati, fin da bambini, al culto infausto della guerra e dell’obbedienza cieca e assoluta, erano stati mandati, in nome di una pretesa superiorità nazionale, ad aggredire con le armi nazioni vicine: le 'patrie degli altri' come le chiamava don Lorenzo Milani - ha detto ancora Mattarella - Nella disastrosa ritirata di Russia, sui campi di El Alamein, nelle brutali repressioni compiute in Grecia, nei Balcani, in Etiopia, nelle deportazioni degli ebrei verso i campi di sterminio, nel sostegno ai nazisti nella repressione della popolazione civile, si consumò la rottura tra il popolo italiano e il fascismo. Si verificò -scrisse ancora Salvatorelli- 'una crisi morale profonda, una disaffezione completa rispetto al regime, un crollo disastroso dell’idolo Mussolini'. Il fascismo aveva in realtà, da tempo, scoperto il suo volto, svelando i suoi veri tratti brutali e disumani".
In mattinata Mattarella accompagnato dai presidenti del Senato, Ignazio La Russa, della Camera Lorenzo Fontana, del Consiglio Meloni, della Corte costituzionale Augusto Barbera, dal ministro della Difesa Guido Crosetto, e dalle alte cariche militari, ha reso omaggio all'Altare della Patria, deponendo una corona di alloro sulla tomba del Milite ignoto, in occasione della Festa della Liberazione.
"Nel giorno in cui l’Italia celebra la Liberazione, che con la fine del fascismo pose le basi per il ritorno della democrazia, ribadiamo la nostra avversione a tutti i regimi totalitari e autoritari. Quelli di ieri, che hanno oppresso i popoli in Europa e nel mondo, e quelli di oggi, che siamo determinati a contrastare con impegno e coraggio". Lo scrive su Instagram la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "Continueremo a lavorare - aggiunge- per difendere la democrazia e per un’Italia finalmente capace di unirsi sul valore della libertà. Viva la libertà!".
“Io ho sempre onorato Il 25 aprile senza doverlo sbandierare e senza politicizzarlo”. Queste le parole del vice premier e ministro per le Infrastrutture Matteo Salvini arrivando al Sacrario dei Caduti di Milano per la deposizione delle corone di alloro in occasione delle celebrazioni per la giornata della liberazione insieme al sindaco di Milano Giuseppe Sala e al ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.
“Non ho detto che sarei venuto qui fino all'ultimo per evitare che ci fossero quelli che invece di celebrare il passato perché non ritorni, vanno in giro a creare problemi”, ha spiegato. Del resto “vedevo stamattina da Roma delle immagini vergognose, scandalose di aggressione alla Brigata ebraica. Ecco - ha concluso - io spero che in un giorno troppo lontano, il 25 aprile sarà una giornata di unità nazionale”.
“Questo è un governo scelto dai cittadini. Poi l’antifascismo sì, mi sembra evidente”, ha aggiunto sottolineando: “Ma poi qualcuno ha nostalgia del fascismo? Spero di no”.
“Il 25 aprile è la festa della Liberazione e di tutta la Repubblica, la festa in cui si ricorda chi ha dato la vita e con tanto sacrificio ha costruito le basi per la democrazia e per la libertà di questo Paese e per la difesa dei valori della nostra Costituzione”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein arrivando al corteo milanese per le celebrazioni del 25 aprile. “Questa - aggiunge Schlein - è una giornata in cui va rinnovato l’impegno della lotta per la difesa della nostra Costituzione e per la sua piena attuazione. Per questo dobbiamo ricordare la Resistenza che ci ha liberato dai nazifascisti".