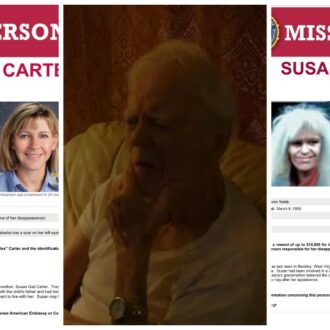Allori e inferi, glorie e patemi, bagliori e abissi di una singolare biografia interrotta da un suicidio. Tinte a dir poco chiaroscurali contraddistinguono l’esistenza del pittore novecentesco Mark Rothko, protagonista della pièce teatrale “Red”, proposta per la prima volta in versione italiana (“Rosso”) sul palcoscenico dell’Elfo Puccini di Milano.
Sullo sfondo della tragedia personale del celebre artista di origine russa (al secolo Marcus Rothkowicz), l’autore John Logan, sceneggiatore, produttore e drammaturgo americano al quale lo spettacolo in questione è valso due anni fa ben sei Tony Awards, tratteggia un vivace e agile affresco della New York dei tardi anni ’50 e delle sue avanguardie artistiche, ivi compresi geni planetari come Picasso e Pollock, ovvero i “concorrenti” che Rothko spesso menziona proponendone sapidi e impertinenti identikit. A dominare la scena scandita dai dialoghi tra il pittore e il suo giovane assistente è il tema della fatale inquietudine dell’artista, ovvero il suo disadattamento e il suo problematico impatto con la realtà.
Burbero, intrattabile e a dir poco caustico, Rothko appare dilaniato da un ansioso e febbrile desiderio di autoaffermazione, contraddittoriamente ostacolato da misantropia, terrore di contaminazione del prestigio della propria arte, e perfino remore pauperiste dinanzi alla commissione più ricca della storia della pittura, prima accettata e poi clamorosamente disdetta dall’interessato, ovvero l’equivalente di 2,5 milioni di dollari attuali per adornare di propri dipinti le pareti del ristorante newyorkese Four Seasons. A conferire charme e forza empatica a cotanto personaggio, è il protagonista Ferdinando Bruni, che delinea con virtuosistica varietà di sfumature attoriali le asprezze, i conflitti e le tortuosità del celebre pittore: fragilità, arroganza, disperazione, strafottenza, prostrazione, terrore, pietà, collera, e una voce irruvidita da robuste dosi di Jack Daniels e disincanto ma anche dai sussulti battaglieri di un vecchio leone non ancora vinto.
“Io esisto per fermarti il cuore, io esisto per farti pensare e non per fare delle immagini carine!”, tuona Rothko rivolgendosi all’assistente Ken (impersonato dal giovane ma già maturo Alejandro Bruni Ocaña), un aspirante pittore dal traumatico passato familiare che passa dall’iniziale goffaggine reverenziale ad un sempre più incalzante e dissacrante spirito critico. Sarà infatti proprio Ken a compiere, nei confronti di colui che fin da subito si impone ai suoi occhi come una sorta di padre-padrone, quel metaforico parricidio edipico che lo stesso Rothko teorizza quale lotta cruenta ma necessaria tra giovani e vecchi artisti ciclicamente spodestati dal loro trono per effetto del nuovo che avanza. E sono proprio l’ossessione della novità, l’angoscia di essere “superato” da chi verrà dopo, il disagio e la soggezione di frequentare gli ambienti altolocati e i ristoranti raffinati, la strisciante depressione di chi stenta perfino a figurarsi un pubblico finalmente degno della propria arte, ad ingigantire progressivamente in Rothko la dichiarata paura “che il nero inghiotta il rosso”, come purtroppo drammaticamente accadrà anni dopo, il 25 febbraio 1970, quando l’artista si suiciderà nel proprio studio newyorkese tagliandosi le vene.
Lo spettacolo, che approderà a Torino il 15 e 16 Giugno per poi fare ritorno alla sala Fassbinder dell’Elfo Puccini dal 10 al 28 Ottobre, si avvale della regia rigorosa ed essenziale di Francesco Frongia, volta a focalizzare l’attenzione sul reciproco incalzare dei ragionamenti e degli scambi dialettici tra i due personaggi. È infatti proprio nell’ambito di tali conversazioni che Rothko sottolinea a più riprese il legame vitale e imprescindibile tra cultura (filosofica, letteraria etc.) e pratica artistica, assumendo come proprio testo di riferimento la nietzscheana “Nascita della tragedia”: dunque non il Nietzsche superomistico e ultravitale dello Zarathustra (Picasso?) ma quello iper-polemico e riformatore degli scritti giovanili. Resta addosso allo spettatore una sorta di doloroso e ricorrente interrogarsi sul mistero tragico dell’artista. Albatro? Colomba pugnalata? Le metafore zoologiche si sprecano, poiché inaggirabile è tentativo di lenire con trasfigurazioni poetiche o pseudospiegazioni l’umana desolazione dinanzi ad esistenze che rifrangono abbaglianti frammenti di assoluto, che schiudono il prodigio dell’immortalità attraverso l’arte, per poi implodere in una fragilità e in un male di vivere che le conduce ad auto-sabotarsi, ad avvitarsi su se stesse, ad accartocciarsi come splendidi fiori recisi. A tal punto da sospettare che in effetti avesse proprio ragione Baudelaire: “Exilé sur le sol, au milieu des huées, ses ailes de géant l’empêchent de marcher“.
Articolo Precedente
Madonna, mi tocca difenderti

Articolo Successivo
Bentornati Soundgarden