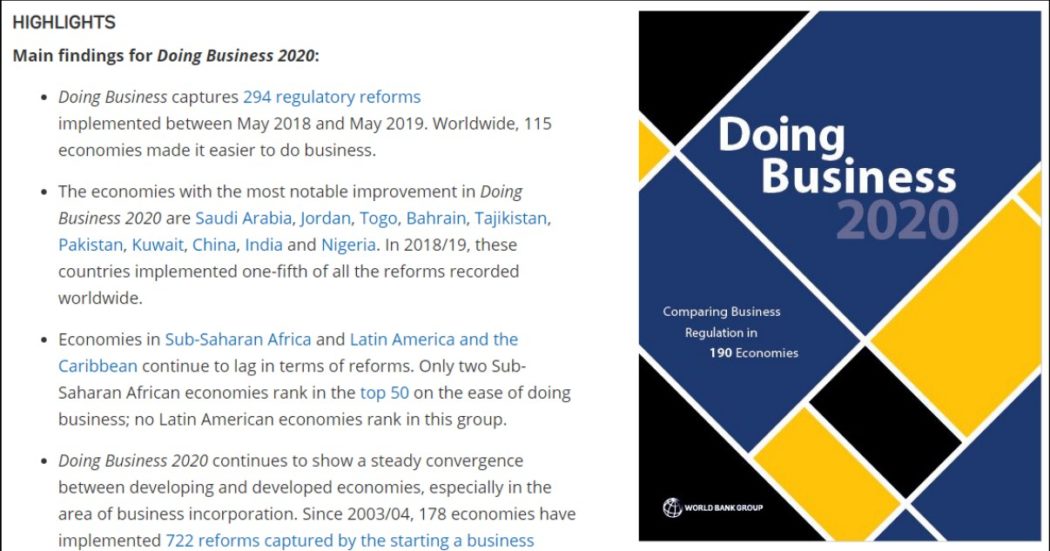Cina, Azerbaijan, Emirati Arabi e Arabia Saudita, secondo le indiscrezioni. Ma negli ultimi anni anche Cile, Armenia, India. È lunga la lista dei Paesi coinvolti dagli errori e dalle irregolarità del popolare report della Banca Mondiale, Doing Business, che oggi classifica 190 Paesi nel mondo (erano 133 nella prima edizione del 2003) rispetto all’ambiente economico e regolatorio. Uno strumento chiave per i governi di tutto il mondo, per attrarre investimenti e supportare le politiche di riforma. E per questo a rischio strumentalizzazioni, sia in virtù della filosofia con cui il rapporto è costruito, sia nella raccolta e nell’analisi dei dati. Non a caso aveva attirato sempre più critiche e polemiche.
“Sono state segnalate numerose irregolarità in merito alle modifiche ai dati nei rapporti Doing Business 2018 e Doing Business 2020, pubblicati nell’ottobre 2017 e 2019. Le modifiche ai dati non erano coerenti con la metodologia Doing Business”, ha spiegato la Banca Mondiale nel comunicato diramato la scorsa settimana, annunciando la revisione e la verifica dei dati delle ultime cinque edizioni del rapporto e la sospensione di nuove pubblicazioni dello studio fino a quando non sarà fatta chiarezza dall’audit interno sui processi di raccolta e revisione dei dati. Nessun dettaglio è stato fornito sulle anomalie riscontrate, né sui Paesi coinvolti. Tuttavia, il Wall Street Journal ha reso noto che i Paesi coinvolti sarebbero Cina, Azerbaijan, Emirati Arabi e Arabia Saudita. Negli ultimi cinque anni Pechino è passata dalla 90esima posizione alla 31esima, l’Azerbaijan dalla 80esima alla 34esima, gli Emirati Arabi dalla 22esima alla 16esima, mentre l’Arabia Saudita dalla 49esima alla 62esima, sebbene nel 2019 Riyadh sia stata celebrata dalla Banca Mondiale come “top reformer”.
Il rapporto Doing Business, nato nel 2003, ha guadagnato negli anni una grande popolarità, diventando il ranking di riferimento per i 190 Paesi analizzati rispetto alla capacità di offrire un ambiente economico e finanziario favorevole agli affari. Per questo motivo, e in particolare per le nazioni in via di sviluppo, è diventato uno strumento utile a motivare l’attivazione delle riforme per delineare un sistema regolatorio più conforme al business, e in alcuni casi a propagandare l’efficacia delle stesse riforme attivate dai governi, con l’obiettivo di favorire l’attrazione di investimenti esteri. Di conseguenza è stato spesso utilizzato anche nella lotta politica interna dei Paesi.. L’Italia nell’edizione 2020 si è attestata in 58esima posizione, dopo aver perso terreno negli ultimi anni. Nel 2019 si segnalava in 51esima posizione, nel 2018 occupava la 46esima. Ma cinque anni fa il Belpaese occupava la 56esima posizione, mentre dieci anni fa era 78esima nel mondo.
La crescita della popolarità di questo rapporto è coincisa con la crescita delle critiche e delle polemiche a tutti i livelli, sia in relazione alla filosofia sottesa alla costruzione degli indicatori, sia rispetto alle metodologie utilizzate. In primis, infatti, viene contestata l’ideologia che questo studio ha portato avanti, soprattutto da sindacati, accademici e attivisti dei diritti umani. “Più le normative vengono ridotte, più il Paese figura meglio nel ranking”, hanno scritto Isabel Ortiz, direttore del Global Social Justice Program presso l’Initiative for Policy Dialogue, e Leo Baunach, direttore dell’International Trade Union Confederation and Global Unions. “Doing Business mina il progresso sociale e promuove la disuguaglianza, incoraggiando i Paesi a prendere parte all’“esperienza di deregolamentazione”, includendo riduzioni della protezione dell’occupazione, minori contributi previdenziali (denominati come “tassa sul lavoro”) e minore tassazione”.
Simili rilievi sono stati avanzati anche dal Center for Global Development, think tank con sedi a Washington e Londra, bollato al riguardo come “marxista” dal creatore di Doing Business, l’economista bulgaro Simeon Djankov, il quale ha specificato che l’indice non misura i costi di guidare una società, ma i costi di fare affari. Nel 2013, un panel indipendente istituito dalla stessa Banca Mondiale, aveva consigliato l’eliminazione degli indicatori relativi alla flessibilità del mercato del lavoro e alla tassazione, perché penalizzanti per i Paesi che attraverso le imposte finanziano il welfare. Il panel, inoltre, espresse preoccupazione sulla scelta dei dati considerati, per larga parte provenienti da sondaggi somministrati a consulenti aziendali e studi legali, e non a imprenditori impegnati direttamente nelle attività produttive, che conoscono l’importanza dei programmi di protezione sociale e degli investimenti nelle infrastrutture finanziati con la raccolta fiscale. Tutte queste raccomandazioni furono rigettate dalla Banca Mondiale.
Da allora in avanti non sono mancate nuove controversie. Prima di oggi, l’ultima aveva coinvolto il presidente della Banca centrale dell’Armenia, Artur Javadyan, che lo scorso anno denunciò alcuni errori nel computo dei dati che avrebbero penalizzato nel ranking il Paese caucasico di dieci posizioni. Ma la più rumorosa aveva riguardato il capo economista della Banca Mondiale, poi premio Nobel, Paul Romer, dimessosi dall’incarico nel gennaio 2018, dopo 15 mesi dal suo insediamento. Romer evidenziò che le revisioni alla metodologia del rapporto Doing Business, per “motivazioni politiche”, avevano artificiosamente spinto il Cile in posizioni più basse della graduatoria sotto la presidenza socialista di Michelle Bachelet, per favorire invece il Paese sotto la guida dei conservatori con la presidenza di Sebastián Piñera, nel periodo compreso tra il 2010 e il 2014. Nel 2006 il Paese figurava al 25esimo posto nel mondo. Nel 2010 era sceso alla posizione 49, risalendo nel 2014 in 34esima posizione. Con la nuova presidenza Bachelet il Paese accusò nuovamente un calo nel ranking, finendo per scendere fino alla 57esima posizione nel mondo. Il Center for global development, pochi giorni dopo le dimissioni di Romer, analizzò il ranking del Cile mantenendo la stessa metodologia per tutto il periodo considerato, e confermò l’intuizione di Romer, mostrando come il Paese avrebbe dovuto oscillare nel decennio considerato tra la 30esima e la 39esima posizione.
“È triste apprendere della possibile manipolazione dei dati del rapporto Doing Business dal 2017. Fino al 2016 (dal 2012, ndr) è stato sotto la mia supervisione, e con il mio team ho lavorato duramente per mantenerlo completamente onesto e trasparente (anche quando non ci piacevano i risultati)”, ha twittato l’economista indiano Kaushik Basu. Eppure, anche le performance di Mumbay negli ultimi anni sono finite sotto attenta osservazione, e la stessa analisi condotta per il Cile da parte del Center for Global Development è stata promossa negli ultimi anni proprio sull’India. Mostrando che la sua scalata del ranking ranking (dalla posizione 142 del 2015 alla 100 del 2018, mentre oggi si attesta in 63esima), è stata dovuta esclusivamente per i cambiamenti apportati nella metodologia dello studio, alimentando i sospetti su azioni di lobbying del governo indiano per meglio figurare nella classifica e su riforme irrilevanti per il progresso economico del Paese e tese invece a rispondere in maniera più adeguata agli indicatori del rapporto.
Dal 2010 la Cina è diventata il terzo azionista della Banca Mondiale, con il 4,42 per cento. E nell’ultimo decennio ha continuato ad accrescere la sua influenza arrivando oggi alle soglie del 5% delle azioni. India e Cina sono i maggiori percettori di credito da parte della Banca Mondiale, la prima con oltre 8 miliardi di dollari, la seconda con oltre 6 miliardi e con un piano approvato lo scorso dicembre per ricevere un’ulteriore somma compresa tra 1 e 1,5 miliardi a basso interesse fino al 2025. Gli Stati Uniti, saldamente in testa tra gli azionisti, ma in leggera flessione rispetto al passato, con il 16,65% delle quote, con la presidenza di Donald Trump hanno avanzato più di un dubbio sull’opportunità di questa politica nei confronti della seconda economia mondiale, che secondo le stime detiene 3 trilioni di dollari in riserve estere e presta denaro per 1,5 trilioni di dollari a 150 Paesi nel mondo. Dubbi condivisi anche dall’attuale presidente della Banca Mondiale, David Malpass, già consigliere economico di Trump e sottosegretario di Stato agli affari internazionali al Dipartimento del tesoro, che a febbraio garantì alla Cina assistenza tecnica per combattere l’emergenza Covid-19, ma escluse nuovi prestiti.
Articolo Precedente
Visco (Bankitalia): “Davanti al progresso tecnologico le imprese italiane hanno chiesto costi del lavoro più bassi invece che investire”

Articolo Successivo
Fitch: “Nel 2020 pil dell’Italia a -10%, l’anno prossimo +5,4%. Dal governo risposta rapida, la cig ha sostenuto i redditi”