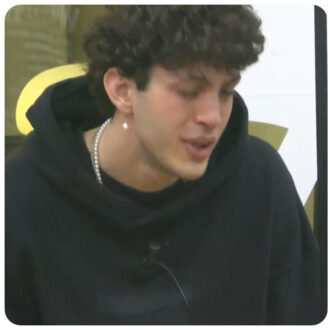Le reazioni alla denuncia della distruzione di un’opera di Antonio Canova (rovinosamente caduta mentre veniva smontata dal muro dell’Accademia di Belle Arti di Perugia per andare ad una mostra di cassetta a Assisi) appaiono assai istruttive.
Giancarlo Galan (già ministro dei Beni culturali politicamente responsabile del saccheggio della Biblioteca dei Girolamini perpetrato dal suo consigliere Marino Massimo De Caro, e ora presidente della Fondazione Antonio Canova che ha promosso e organizzato la mostra di Assisi) non ha alcuna voglia di scusarsi: «Non abbiamo alcuna responsabilità nello spiacevole incidente». E si improvvisa storico dell’arte: «L’opera è una delle dodici riproduzioni dell’Uccisione di Priamo incise in gesso da Canova», filosofo (cinico): «La fortuna vuole che quell’opera del Canova non sia copia unica, ce ne sono altre dieci in Italia», infine occhiuto padrone in casa propria: «I restauratori faranno di tutto per tentare di ricomporre il gesso, ma quell’opera non è nostra». Peccato che l’opera sia a tutti gli effetti un preziosissimo originale nato nel gesso e per il gesso, e non una «riproduzione», né una replica, né una copia (anche se multiplo: accade per esempio con i bronzi); e peccato che il gesso non si incida.
Per non dire che la fortuna forse sarebbe meglio non evocarla in questa storiaccia, che i restauratori non potranno far nulla e che il fatto che l’opera non fosse della fondazione di Galan non consola nessuno tranne Galan. Non che le dichiarazioni dei proprietari siano molto più in tema: il direttore dell’Accademia (in un’intervista in cui riesce a chiamare 5 volte «pala», cioè immagine sacra da altare, un rilievo di tema omerico!) si dice addolorato non del disastro che è stato combinato, ma del fatto che la polemica è partita «da uno studioso perugino»: insomma, un po’ di omertà, che diamine!
E non che l’omertà non ci sia stata: il ministro per i Beni Culturali ha appreso della distruzione dalle pagine del Fatto, perché né il soprintendente dell’Umbria (a metà con la Calabria, poveretto, grazie ai tagli lineari di tutti gli ultimi governi) né i funzionari Mibac presenti nel cosiddetto comitato scientifico della mostra, né l’accademia, né Galan: insomma non un cane aveva pensato di fare una relazione ufficiale, o di denunciare la cosa ai carabinieri!
Non è un problema solo italiano, sia chiaro. Pochi giorni fa, il Parlamento Scozzese ha ascoltato in audizione il direttore della National Gallery di Londra sul tema dei pericoli corsi dalle opere d’arte vorticosamente spostate per alimentare l’industria delle mostre. Nicholas Penny è stato tanto franco e tanto duro (ha parlato della «deplorevole tendenza degli staff dei musei a negare i gravi rischi corsi dalle opere d’arte a causa delle mostre», documentando 10 gravi incidenti di cui è stato testimone durante la sua carriera in Inghilterra e America) che la sua deposizione è stata secretata. Non prima, però, di essere finita per errore sul sito del Parlamento per qualche minuto: e da qui le indiscrezioni (qui corredate da foto allucinanti di opere mutilate nelle mostre).
In Italia, tuttavia, sembra che l’unica cosa che sappiamo fare con le opere d’arte sia spostarle in continuazione. Non ci si chiede più se valga la pena di far correre gli inevitabili rischi a questi straordinari pezzi unici. Mostrifìci come Palazzo Strozzi, le Scuderie del Quirinale, Venaria Reale sono solo alcuni dei principali ‘caselli’ di questo moto perpetuo, e lo stesso MiBAC ha dato un pessimo esempio organizzando direttamente carrettate propagandistiche di opere d’arte, spesso anche delicate, in paesi lontani, al solo scopo di promuovere il ‘brand Italia’. Sulle considerazioni di Penny dovrebbe ben meditare proprio il MiBAC, in queste ore alle prese con il caso di un enorme (2,5 per 5,20 metri) affresco staccato di Botticelli che il Polo museale fiorentino aveva offerto in prestito a Israele (senza alcuna motivazione scientifica o didattica) benché provatissimo dalla sua recente (e se possibile, ancora più inutile) trasferta a Pechino.
Assai più utile (culturalmente ed economicamente) sarebbe indurre gli italiani a viaggiare alla scoperta del loro Paese, indurli a dialogare con le opere nei loro contesti, e non in quelle specie di tristi giardini zoologici a pagamento che sono quasi sempre le mostre. Perché non dirottare la gran parte dei soldi pubblici spesi per far mostre in borse di viaggio attraverso l’Italia per studenti capaci e meritevoli, di ogni ordine e grado?
Facciamo invece proprio il contrario, nascondendo monumenti meravigliosi dietro osceni allestimenti di mostricciole temporanee senza senso. Un turista che in questi giorni volesse vedere Palazzo Te a Mantova non ci riuscirebbe, perché i suoi meravigliosi affreschi sono coperti da innumerevoli paraventi di studio medico che ospitano opere gettate a casaccio (Dalì insieme a statue del V secolo avanti Cristo!) in una penosa mostra su Amore e psiche. E non potrebbe vedere la Cappella dei Principi a Firenze, enorme pantheon dei Medici incrostato di pietre dure, perché occultato per metà da imbarazzanti stand di una mostra che ha nel titolo quello Splendore mediceo che di fatto nasconde.
Insomma, aveva ragione il sulfureo Federico Zeri: «Le mostre sono come la merda, fanno bene a chi le fa, non a chi le guarda».
Articolo Precedente
Poesia: una lettura di ‘Datura’ di Patrizia Cavalli

Articolo Successivo
Droga e discoteche: noi eravamo lì, sui divanetti del privè. Ma io volevo fare la scrittrice