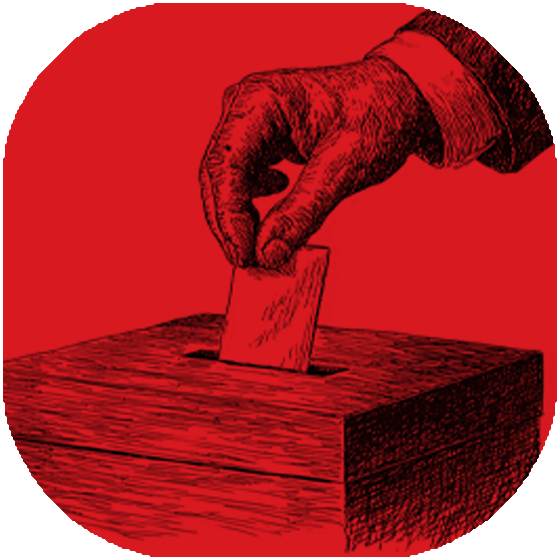Roma, 9 mar. (Adnkronos) - Da oggi a Milano tutte le capsule di caffè in alluminio possono essere conferite direttamente nel sacco giallo destinato agli imballaggi in plastica e metalli, nella propria raccolta domestica o condominiale. Si tratta di una novità significativa resa possibile dalla collaborazione tra il Comune di Milano, Amsa, A2A Ambiente, Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio (Cial), Nespresso.
La possibilità di conferire le capsule nel sacco giallo a Milano nasce dal lavoro congiunto sull’impianto di selezione di A2A Ambiente di Muggiano, alle porte di Milano, dotato delle tecnologie necessarie per intercettare e recuperare anche l’alluminio piccolo e leggero. L’impianto utilizza infatti un separatore a correnti parassite (Ecs - Eddy Current Separator), che grazie ad una nuova fase di selezione permette di separare l’alluminio di piccole dimensioni - come quello delle capsule di caffè, ma anche tappi, blister e altri piccoli componenti metallici - dal resto del flusso di rifiuti per avviare a riciclo l’alluminio anziché scartarlo. Con questa tecnologia, che rappresenta un’eccellenza in Italia, la frazione più fine viene quindi rilevata scongiurandone la perdita e garantendone l’avvio a una nuova filiera che prevede la fusione e la trasformazione in nuovi prodotti. Un processo reso possibile anche grazie alla collaborazione con Nespresso e Cial che hanno affiancato e contribuito attivamente alla fase di verifica ed efficacia del sistema di rilevamento e separazione.
L’alluminio possiede infatti caratteristiche ottimali in quanto può essere riciclato al 100% e riutilizzato all’infinito mantenendo invariate le caratteristiche del metallo. Il progetto, in un Paese come l’Italia povero di bauxite, contribuisce al fabbisogno di alluminio e consente inoltre di risparmiare il 95% di energia altrimenti necessaria alla lavorazione a partire dalla materia prima.
L’attività risponde, inoltre, all’aggiornamento normativo relativo alla gestione degli involucri. A partire dal mese di agosto 2026 diventerà, infatti, effettivo il nuovo regolamento Ppwr - Packaging and Packaging Waste Regulation che riconoscerà le capsule come imballaggi e, quindi, introdurrà il loro conferimento nella raccolta differenziata. Ma perché il riciclo dell’alluminio piccolo e leggero sia effettivo, sarà necessaria la presenza di impianti e processi idonei, come garantito qui a Milano grazie a questa collaborazione.
Oggi, secondo la normativa vigente, le capsule non sono classificate come imballaggi, a causa della loro struttura composta da alluminio e caffè esausto rimasto all’interno dopo l’uso, e per questo sono destinate alla racconta indifferenziata dei rifiuti generici. Il riconoscimento delle capsule come imballaggi, la tecnologia Ecs presente presso l’impianto di A2A Ambiente di Muggiano, e il lavoro congiunto svolto insieme a Amsa, Cial e Nespresso rappresentano quindi un’applicazione concreta di come sia possibile trasformare l’innovazione normativa che porterà il Ppwr in impatto reale. È questa evoluzione tecnologica che permette oggi a Milano di garantire che le capsule conferite dai cittadini nella raccolta del sacco giallo vengano davvero riciclate.
"Poter conferire le capsule di alluminio nel sacco giallo, anche se contengono i residui di caffè, è un passo avanti che semplifica la gestione dei rifiuti domestici da parte dei cittadini e delle cittadine e che ci permetterà di migliorare la raccolta differenziata e di riciclare una grande quantità di alluminio (elemento prezioso e che ben si presta al riciclo) che fino ad oggi andava disperso", spiega l'assessora all'Ambiente e Verde Elena Grandi.
"Iniziative come queste possono contribuire ad aumentare la raccolta differenziata del capoluogo lombardo e a semplificare al contempo la raccolta domestica delle capsule usate da parte dei cittadini - dichiara l’amministratore delegato di Amsa, Marcello Milani - Con oltre il 63% di raccolta differenziata, Milano è al vertice tra le metropoli europee sopra il milione di abitanti, confermandosi come esempio di eccellenza".
"L’impianto milanese di Muggiano rappresenta uno degli esempi più avanzati di innovazione applicata all’economia circolare - aggiunge Giovanni Faedda, responsabile Impianto di Muggiano di A2A Ambiente - Grazie all’impiego della tecnologia Ecs (Eddy Current Separator), il sito oggi consente di recuperare anche l’alluminio più piccolo e leggero, come quello delle capsule di caffè, avviandolo al riciclo".
Per il direttore generale di Cial Stefano Stellini, "questa novità rappresenta un passo decisivo per due motivi fondamentali: per il comparto del mondo alluminio significa accrescere le quantità di materiale recuperato, fondamentale per il fabbisogno del Paese dato che qui in Italia non abbiamo produzione di alluminio primario da bauxite, per i cittadini vuol dire semplificare il gesto quotidiano della raccolta differenziata. L’Italia è oggi tra i leader mondiali nel riciclo dell’alluminio grazie a un modello industriale maturo e tecnologie sempre più avanzate".
"Il progetto - spiega Monica Pellegrini, direttrice operativa di Nespresso Italiana - rende ancora più facile lo smaltimento e concreto il riciclo dell’alluminio, dando un esempio eccellente di applicazione del Ppwr. Lavoriamo da oltre 15 anni nella gestione di sistemi dedicati per riciclo e questo rende naturale il nostro supporto per avviare il sistema, che si affianca ai nostri progetti dedicati, quali 'Da Chicco a Chicco' e il Servizio di Raccolta a Domicilio, con cui abbiamo recuperato oltre 3.500 tonnellate di capsule nel comune di Milano, e 6.000 in Lombardia dal 2011".
L’iniziativa sarà accompagnata da una campagna informativa istituzionale, sviluppata da Amsa e Cial con il supporto di Nespresso, per sensibilizzare i cittadini a conferire correttamente le capsule nella raccolta domestica. La campagna vedrà una pianificazione fisica per le strade delle città, accompagnata dalla presenza sulla stampa e sui canali digitali e social di Amsa, Cial e Nespresso. Il nuovo sistema lanciato su Milano sarà progressivamente esteso ai comuni dell’hinterland serviti da Amsa.