Si dice spesso che per combattere il cambiamento climatico occorre partire dai nostri comportamenti. E se questo significasse modificare il modo in cui pensiamo quello che ci circonda? È la domanda di partenza dell’antropologo Andrea Staid, docente alla Nuova accademia di belle arti di Milano (Naba) e all’Università di Genova, nel suo ultimo libro Essere natura (Utet, pp. 131, euro 15). Se la vita degli esseri umani ha smesso di essere “naturale” quando abbiamo cominciato a guardare la natura solo come una risorsa da sfruttare, in società organizzate sul modello estrattivo (o capitalista), allora la soluzione ai problemi di questa società è fondare una nuova idea del nostro stare al mondo, basata sull’eguaglianza tra esseri umani e non umani.
In che modo l’antropologia può cambiare il nostro rapporto con l’ambiente?
Perché permette di comprendere meglio il concetto di ambiente sulla base delle esperienze di altre società. Comunità altre ed estranee alla visione antropocentrica e turbo-capitalista per cui la natura e l’ambiente sono qualcosa da cui estrarre merci o possibilità, ma per cui invece la natura è qualcosa con cui relazionarsi: un intreccio di vite. L’antropologia è come una bussola che non solo ci aiuta a muoverci in un mare di culture, ma ci orienta verso le possibilità da costruire per il futuro.
Quali sono queste mentalità e pratiche alternative?
Se sono un abitante Maori vedo la terra che calpesto come una mia divinità, perciò starò molto attento a non farle del male, a non inquinare. Se quando mangio una patata dolce penso che sia il corpo dei miei antenati non sprecherò quel cibo. Se quando vedo un fiume lo vedo come una persona non danneggerò i suoi argini. Sono solo alcuni esempi di come si possa pensare alla natura non come qualcosa da dominare, ma come qualcosa che ha una soggettività. Molte delle comunità indigene che ho conosciuto non si sognerebbero mai di distruggere quello che le circonda. Perfino in Europa è stato così per lungo tempo. Se la natura diventa soggettiva, cioè se gli altri esseri viventi sono soggettivi, chiaramente acquisiscono anche dei diritti, come avviene nelle lotte portate avanti in Nuova Zelanda, in Bolivia e in Ecuador da movimenti indigenisti o in Chiapas dagli zapatisti, che hanno prodotto il concetto di “foresta giuridica”.
Nel libro racconta che da cinque anni ha scelto di non vivere in città, perché?
È vero che il libro è a metà tra il saggio e una narrazione delle mi esperienze personali, sia su un campo lontano di ricerca come il sud-est asiatico ma anche sul campo di ricerca della mia vita quotidiana. Da cinque anni a questa parte ho deciso di abbandonare la città come quotidianità e vivere in una relazione più profonda con quello che mi circonda, cioè con gli altri esseri viventi non umani, vegetali o animali. Non penso che questa sia ‘la scelta giusta’, non mi piace questo termine. Per me è innanzitutto una scelta dettata dal fatto che quando tornavo a vivere in città dopo i miei viaggi di ricerca etnografica mi sentivo costretto in una gabbia di cemento. Per me è stato abbastanza facile questo passaggio, un modo per non avere troppo distacco fra teoria e pratica.
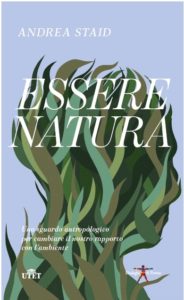 E dedica alcune pagine a spiegare che in campagna non ci si annoia…
E dedica alcune pagine a spiegare che in campagna non ci si annoia…
Quando hanno saputo che sarei andato via da Milano per vivere in cima a un monte in un paese di 200 abitanti (in Liguria, ndr), molti colleghi e amici mi dicevano ‘ti annoierai tantissimo’. In realtà non mi annoio mai, anzi mi annoiavo di più in città. Non voglio fare una fiction, chiariamoci: insegno all’Università quindi vedo un sacco di gente e vado in città a lavorare. Ho relazioni con altri umani, non sto solo con cinghiali, lepri, querce o castagni. Detto questo, però, avendo mutato la mia visione, quando cammino fra gli alberi, so che sembrerà strano, sento le loro presenze soggettive esattamente come le sentivo quando ero in Laos e in Thailandia. Mi faccio stupire dai cambiamenti quotidiani di questi alberi e delle piante, o delle verdure nell’orto. E la relazione è ancora più forte con gli animali, presenze con le quali scambiare in altro modo o con altri linguaggi.
Per questo evoca anche l’idea della natura come cura?
Non lo dico io, esistono una marea di studi scientifici anche occidentali, che attestano lo attestano. L’ortoterapia ormai si fa negli ospedali, da Buenos Aires a Stoccolma. Oggi il disagio psichico o la depressione si curano non solo con la terapia farmacologica ma anche coltivando, piantando fiori, raccogliendo pomodori. Ci sono studi che dicono che negli ospedali, quando dalla finestra si vedono degli alberi invece che un muro i pazienti si riprendono prima. Tutto ciò ci fa capire come l’esserci separati completamente nella natura in alcuni casi ci fa ammalare, e riprendere una relazione profonda con quello che ci circonda ci può far stare meglio tutti. Un’altra delle pratiche molto è quella degli orti urbani e del critical gardening: spazi abbandonati o lasciati alla speculazione, riqualificati dai cittadini e cittadine e utilizzati per fare giardini. Il tema non è solo mangiare quello che produci, ma creare relazione: è la cosa più ecologica che si può fare nella città.
In una appendice del libro lascia spazio invece alle auto-narrazioni di persone che hanno scelto di cambiare vita, chi sono e cosa raccontano?
Sono persone che sulla scia dei vecchi studi di Serge Latouche ho chiamato ‘disertori della crescita’. Persone diverse tra loro che vivono in Europa, non indigeni dell’Amazzonia né Maori, e che però ‘si sentono natura’, hanno una relazione con la loro professione e con lo stare al mondo completamente diversa da quella che viene sbandierata come l’unica possibile nella società occidentale, ossia produrre, consumare e vivere velocemente. Sono architetti che lavorano sulla bioedilizia, professionisti con approcci etici, fino alle scelte più radicali di donne e uomini andati a vivere nei boschi producendo quello che li mantiene e considerandosi, appunto, una parte della natura.
È davvero possibile trasformare queste scelte individuali in una linea di condotta per le comunità?
Tutte le persone che ho intervistato sono inserite in movimenti, associazioni, lotte che propongono dei cambiamenti della società. C’è chi ha fondato una biblioteca nelle valli del Piemonte, chi anima gruppi d’acquisto solidale. Sono relazioni politiche allargate oltre l’individuo, oltre la casa in mezzo al bosco. La mia stessa esperienza è così. Poi non sempre ci si riesce, però credo sia importante unirsi per produrre un cambiamento, sperimentando e confrontandosi, anche in modo conflittuale, con le istituzioni sorde e disattente.

