Ha ragione Marret Feddersen a vedere la fine del mondo dappertutto. La fine del mondo è dappertutto. Nel rintocco, imprevedibile e impercettibile, dell’istante nel quale le cose scompaiono. Un attimo prima erano qui accanto a noi; un attimo dopo non ci sono più. Sembra un gioco di prestigio e, invece, è la realtà. Fa bene Marret la “svitata” ad andare di casa in casa, con lo scampanio irriverente dei suoi zoccoli, per scuotere Brinkebüll – immaginario borgo della Frisia – dal suo livido torpore nordico. “Il tempo sta per scadere!”, grida l’opuscolo che porta sempre con sé: “Svegliatevi!”. Il villaggio, però, è sordo di una routine secolare. E poi la verità si è travestita da follia. Forse perché sa benissimo che non le crederemmo comunque. Chissà? Magari così riuscirà almeno a strapparci un sorriso. Del resto, in quell’antica terra morenica, rimasta “sepolta sotto un ghiacciaio per un’eternità”, persino per Dio il lavoro del pastore è difficile. Il suo gregge sembra “refrattario a ogni credenza”, “impermeabile a qualsiasi senso di devozione”. “Pazzi e pastori, che chiacchierassero pure”.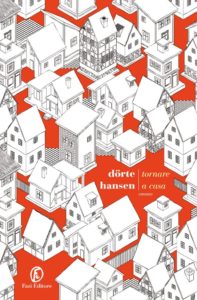
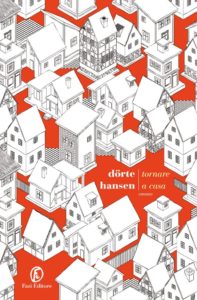
Non capita spesso, nella narrativa di oggi, di trovare una donna di questa forza. Surreale eppure violentemente reale; apparentemente assente eppure visceralmente presente; muta eppure drammaticamente e profeticamente loquace. Marret “sembrava vivere dietro una parete di vetro. Dovevi gridare o sbracciarti per raggiungerla, e a volte il vetro era pure appannato”; “era qualcosa di fugace, in balia dei venti, che cambiava forma di continuo, duna di sabbia, nuvola, mercurio, non aveva confini”. È lei la vera protagonista di Tornare a casa (da domani in libreria per Fazi, euro 18.50), l’intenso romanzo firmato Dörte Hansen – considerata una delle voci più significative della narrativa di lingua tedesca – eletto, non a torto, da Der Spiegel e librai “libro dell’anno”.
Marret svetta in una narrazione tutt’altro che avara di personaggi felicemente fuori pentagramma. Il maestro Steensen: uomo che appartiene al neolitico, e a guardare avanti non pensa proprio, che deve “essere venuto al mondo già maestro, con il suo abito scuro e quelle spalle larghe simili a due pagnotte bruciate”; Dora Koopmann che ce l’ha con tutta la gente ingrata e insolente che si serve al suo minimarket e, ogni tanto, tira i barattoli di conserva dietro a qualche rompiscatole; Heiko Ketelsen, che tutti chiamano “lo Sceriffo”, che vive in un Western tutto suo, e ha messo su un gruppo di “line dance” – i “Brinkebüll Buffalos” – che si esercita il giovedì alla locanda Feddersen. E, naturalmente, Ella Paulsen – la bella figlia del calzolaio, alta e bionda, che non parla mai, per la quale, da giovane, tutti i cavalieri di Brinkebüll erano disposti a fare a botte – e Sönke Feddersen, l’oste: l’unico che riusciva a far ridere la bella Ella e che l’ha sposata, in uniforme. Otto giorni di congedo dal fronte, prima di ripartire per mille giorni in un campo di prigionia, dal quale sarebbe tornato pelle e ossa. E, oggi, che Ella e Sönke stanno per festeggiare le nozze di ferro, nessuno sa quasi nulla dell’altro.
Sono loro i genitori di Marret-Fine-del-mondo, alla quale solo una cosa piace più del predire l’Apocalisse: le ballate pop. Canzoni che canta ogni volta che può e nelle quali tutti vogliono avere diciassette anni come lei. “A diciassette anni si sogna, poi arriva la fortuna, e allora tutto si aggiusta”. Oppure arriva “un bambino, e allora si diventa pazzi”. O forse si era pazzi già prima: “Nel caso di Marret l’ordine non era chiaro”. “C’ho una cosa che non va più via”, dice alla madre, fissandola con gli occhi sbarrati. E comincia a darsi botte sulla pancia. “Deve andarsene da lì! io non lo voglio più!”. Cerca di liberarsi di quella “cosa” in tutti i modi, finendo col fracassarsi costole e piedi. “Non saltare più, Marret”, le dice la madre: “Non te lo togli così”.
Per Marret, la fine del mondo arriva ad aprile: partorisce e, per venti ore, crede di morire. Quando Ella va all’ospedale a prenderla, deve ingoiare la filippica stizzita della Caposala Magda. La ragazza è stata “assistita, curata e istruita al pari di ogni altra puerpera”, con pazienza: “tanta pazienza!”. Il fatto, però, che non si degni di accudire il suo bambino, è inconcepibile. Ne avevano viste tante lì dentro, ma “una madre che si comportava come se suo figlio non la riguardasse!” era il colmo. Il padre? Thomas, Wolfgang o Andreas: Marret non lo rivelerà mai. Era uno dei giovani ingegneri che, nell’estate del 1965, erano venuti per misurare campi, strade e corsi d’acqua e progettare la ricomposizione fondiaria di Brinkebüll. Alloggiavano alla locanda Feddersen e una sera avevano preso la giovane cantante sottobraccio, l’avevano fatta bere e baciata. Diciassette anni: mai fatta una cosa del genere. Figurarsi tre in un giorno solo. I tre avevano cambiato il futuro di Brinkebüll e anche quello di Marret. La fine non di uno ma di due mondi.
Ma chi è Ingwer, l’archeologo quarantesettenne che – dopo trent’anni – ha deciso di “Tornare a casa” e, mentre guida, ascolta Don’t Let It Bring You Down di Neil Young? E perché chiama Ella e Sönke “Mamma” e “Papà”?
“Il cielo sopra Brinkebüll era pieno di segni, ma all’infuori di Marret non li vedeva nessuno”. Grazie a Dörte Hansen per averli visti e interpretati per noi. Non li dimenticheremo.

