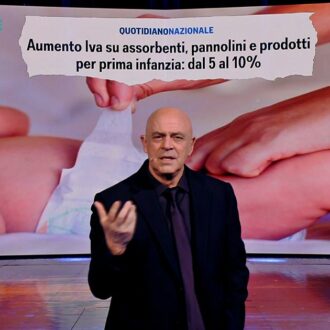Era il 1994. Eravamo adolescenti di provincia, sommessi e un po’ annoiati. Nel turbinio di quell’età dove senti crescere dentro i conflitti e solo gli amici possono capirti. A scuola anche i prof ci dicevano che era normale sentirsi così, e adesso lo sappiamo. Ma allora no. Erano turbamenti nuovi che arrivavano con un’intensità sconosciuta. In radio passava un pezzo, sempre e più degli altri. Zombie. Chitarre pesanti, una voce sexy, affilata, sottile e potente, fatta di scalini imprevisti e armoniosi. Sciolta in un lamento. Il timbro di un angelo, sconvolgente. Il video sempre in rotazione su VideoMusic, a quel canale ci eravamo incollati. Dolores O’Riordan era fatta di treccine color oro come il vestito e il suo corpo, un crocifisso di legno enorme dentro la scenografia dell’inferno. Non capivamo che quello era un video politico, sull’Ira, su un Paese che viveva conflitti distanti da noi. Ci interessava poco. Prima del contesto veniva quella voce cristallina che si infilava dentro. Mettevamo Rec sui registratori quando la radio la mandava – noi che registravamo su Vhs o dalla tv anche il Festivalbar per metterlo su cassetta -, e speravamo che lo speaker non coprisse troppo l’intro così la canzone assomigliava quasi alla versione del cd originale dei Cranberries.
Dolores non seduceva intenzionalmente. Non ammiccava, non fingeva di piacere. Non sorrideva, si vestiva come se si fosse buttata addosso cose a caso dall’armadio e questo ci piaceva. Perché allora valeva tutto, era stile anche quello e rompeva gli argini di quello che ti sta bene e quello che no. Passava dalla canotta bianca con bretella nera alla tutina superaderente fatta con la bandiera americana fino al gilet di paillettes rosso fuoco e alle cuffie ad uncinetto. Sulle orecchie una sfilza di anelle d’argento, che in tanti abbiamo imitato. A volte sembrava una gitana, a volte una post punk molto folk. Senza il suo dress code apripista ci avrebbero preso in giro per come ci vestivamo.
I capelli cortissimi, quasi rasati. Bionda platino, rosso fuoco o viola. Mascara e eyeliner nero. Ombretto deciso e sfumato verso l’esterno, scuro. Sul palco non diceva niente, ci andava spesso scalza. Ballava a modo suo – schiena inarcata, braccia lanciate energiche e rapide dritte ai lati, il viso imbronciato e lo sguardo sottile rivolto verso le luci e il suo mondo interiore. Non verso il pubblico. Uno stile che potevamo riconoscere in mezzo alla moltitudine, non modaiolo, intimista e senza ambiguità. Allora era vero quello che lei diceva, perché lo vedevamo: si può essere sexy anche se si è bassine e casual. Conta la voce, le melodie che senti dentro. Niente glamour, niente stereotipi da gattina piaciona. Non doveva convincere nessuno, voleva solo suonare e cantare.
Loro quattro, seri e seduti sul divano marrone nelle copertine dei primi due cd, quelli della svolta. I Cranberries ci piacevano perché erano autentici, perché erano un po’ depressi (ma non troppo) come noi, anche se loro, di Limerick, erano più grandi. La differenza d’età non la vedevamo neanche e loro erano all’apice del successo. Ci sentivamo capiti, con quelle canzoni mai canzonette che parlavano di amicizie, amori. Di nostalgia, di attaccamento e affetti, di giovani adulti che senza urlare instillavano il riscatto e l’orgoglio di essere noi stessi. Non pensavano alla grande città, non scrivevano del loro successo. Potevamo capirli. Si guardavano dentro, e con loro lo facevamo anche noi. Erano lontani anni luce dalle boyband da cuoricini sulla Smemo che esplodevano in quegli anni. Erano sensibili ed emotivi ma lucidi, mai sdolcinati. Ci piacevano perché entravano nelle nostre penombre in bianco e nero. Non erano una truffa, erano veri. Compravamo le riviste di settore dove c’erano loro in copertina, attaccavamo i poster in camera. Eravamo un po’ delusi quando ce li rubavano riviste di massa come Tv Sorrisi e Canzoni, perché sapevamo che così finivano tra le mani di persone che non potevano capirli come facevamo noi. Erano dappertutto, ma non erano mai primedonne. L’egocentrismo non era la loro casa, lo sentivamo. E come noi, conoscevano le sabbie mobili di quell’età dove in potenza sei tutto ma puoi fare quasi niente. Ci acquietavano, ci facevano sfogare, rilassare, pensare. Con loro abbiamo imparato a suonare la chitarra, perché “alla fine sono quattro accordi” si poteva dire per i loro pezzi e per nostra fortuna. E alla fine con Zombie e una chitarra cantavamo tutti e tutti provavamo a imitare il suo timbro, il suo marchio.
Buon per noi, che con loro qualche parola di inglese abbiamo anche imparato. Abbiamo preso familiarità con l’accento irlandese, lo stile yodel che affiorava sempre, di più nella scia finale di Dreams. Lei si vantava di parlare gaelico con gli irlandesi che la additavano come la starlette che si sarà dimenticata delle sue radici perché ormai era famosa anche in America. E noi con lei ci vantavamo delle nostre radici, non dovevamo fingere di essere qualcun altro. Chi di noi aveva la fortuna di avere comprato il cd lo masterizzava agli altri, e con il lusso di una fotocopia a colori della copertina era come avere l’originale. Ricordiamo chi ci aveva fatto quella copia (Letizia, nel mio caso) e di quanto l’avessimo ascoltata. Abbiamo scoperto Everybody Else is Doing It so Why Can’t We (un regalo di compleanno delle mie tre compagne di classe: Rita, Nunzia e Benedetta) dopo avere imparato a memoria No Need To Argue.
Tra il ’95 e il ’96 – per chi aveva genitori automuniti o una data del tour nei paraggi – il sogno era di andare a un concerto. Era il primo per tanti, e il primo di un certo livello, visto che erano famosi nel nostro universo di riferimento musicale. Tutto anglosassone, Regno Unito e Usa. Allora si andava a fare il pellegrinaggio nel negozio di dischi in città per capire se fossero già arrivati i biglietti o quando arrivavano o “se ti do già i soldi adesso me ne tieni due? No, non possiamo. Ripassa nei prossimi giorni“. Non c’erano i social, c’era solo il telefono fisso. Quindi, si chiamava il negozio rivenditore fino allo sfinimento (a Modena c’era Fangareggi). Eravamo emozionati e preoccupati, perché magari i biglietti sono già andati via tutti. Vabè, speriamo. Io e la Fra ci proviamo a metà anni Novanta e ce la facciamo, ma Dolores annulla le date perché già allora stava male. Riportiamo il biglietto in negozio tristissime e addio. Qualche anno dopo con Isa andiamo a segno all’Alcatraz, Milano. Ma era il periodo di Bury the Hatchet e noi due in realtà speravamo che tagliasse corto coi pezzi del nuovo album e di To The Faithful Departed, dove i suoni dei primi anni Novanta erano stati scalzati da un’impronta di morte che aleggiava volutamente sulle tracce.
I Cranberries come li conoscevamo noi erano già finiti, sapevamo che a quell’epoca non si tornava e anche noi, nel frattempo, eravamo cresciuti. Diventavamo grandi e iniziavamo a guardare Dolores con empatia, ma da lontano. Lei, che vedevamo divincolarsi tra la magrezza sospetta di Salvation, le sue giravolte pop, i video con le farfalle di Just My Imagination e quei capelli corvini e stirati che avevano messo ordine alla testa fosforescente. Apparteneva già al nostro passato, ai nostri pomeriggi in attesa di qualcosa per dare voce alla noia, alle emozioni forti e all’inquietudine, tra decine di cassette e i primi cd. Masterizzati. Anche se non la seguivamo più, le auguravamo tutto il meglio. E non sapevamo che quegli anni in cui era una di noi sono stati il suo massacro. Lo ha sempre detto, si era rotta dentro. E se n’è era accorta quando noi, nel frattempo, eravamo già cresciuti.
I have decided to leave you forever
I have decided to start things from here
Thunder and lightning won’t change
What I’m feeling
And the daffodils look lovely today
(Daffodil Lament. No Need To Argue, 1994)
Articolo Precedente
Dolores O’Riordan, i supereroi della musica se ne vanno sempre presto. Ma restano ‘nella tua testa’