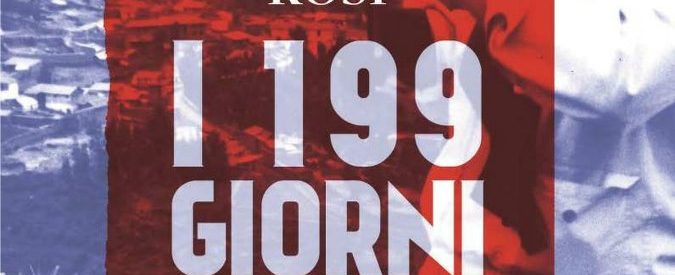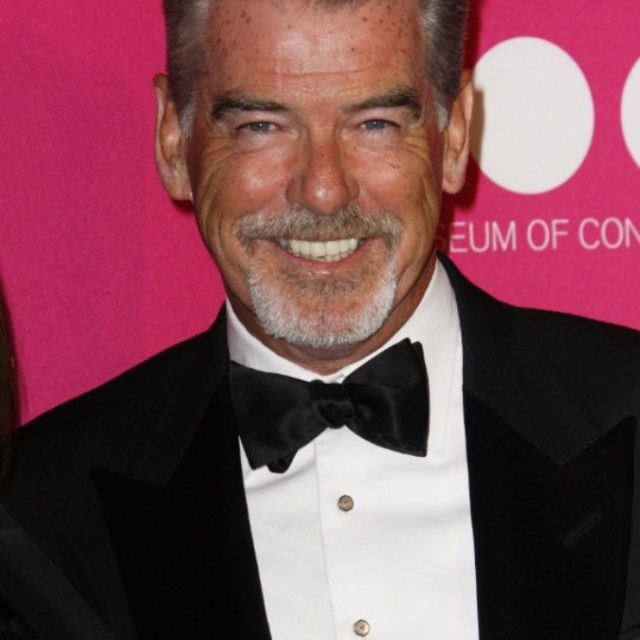“Di fronte ai politici la mafia è uno scherzo”. Se ne lamenta Francesco Rosi, il regista de Il Caso Mattei scomparso nel 2015, per giustificare uno dei suoi film incompiuti: quello su Che Guevara. Confessione spassionata contro il politburo cubano per il regista napoletano riportata in un libro impagabile e necessario come I 199 giorni del Che (Rizzoli). Raccolta di appunti, taccuini, impressioni e ricognizioni del nostro mentre cerca di portare a termine il progetto sul guerrigliero argentino caduto in battaglia in Bolivia mentre cercava di estendere la rivoluzione in America Latina. Il Che viene catturato e ucciso a La Higuera il 9 ottobre 1967. Rosi parte per un viaggio a Cuba, Perù e Bolivia nel gennaio del ’68. Praticamente un instant movie. Alberto Grimaldi titubante produce, Franco Solinas sceneggia e pure Tonino Guerra suggerisce qualcosa. Ma è Rosi con una fame di cinema e un’etica dello sguardo sul mondo da far impallidire che deve aprirsi la strada da solo in mezzo a ministri cubani e colonnelli boliviani, ambasciatori europei e contadini scalzi che masticano coca sugli altopiani sudamericani.
All’epoca 46enne Rosi si aggira per tre mesi tra cimiteri, asini e fango. Fotografa facce, scenari, si appunta una quantità di dettagli perfino tecnici: un “dollino” di qua, 16mm di là da gonfiare in 35mm. Vuole toccare con mano i luoghi della morte del Che, vuole parlare con Fidel Castro, vuole portare a termine un’idea impellente, una roba che gli brucia dentro. “Io come cineasta, come narratore, mi rivolgo a un fatto che riguarda la storia, tutto il mondo”. Con Salvatore Giuliano nel 1962 aveva sorpreso spettatori e critica, con Le mani sulla città aveva vinto il Leone d’Oro a Venezia nel 1963, poi per Rosi erano arrivati gli anni meno noti, ma anche meno ispirati, quelli dei due film meno conosciuti come Il momento della verità e C’era una volta con Carlo Ponti in produzione e la MGM a distribuire. Chiaro che una figura intellettualmente vulcanica, politicamente impegnata ma mai ideologizzata, non potesse che farsi travolgere dalla vita e dalla fine del Che. “Non è facile far capire a un uomo politico che un narratore può essere affascinato da un personaggio anche senza doverne necessariamente condivide ideologie e gesti”, scrive Rosi riferendosi agli intellettuali vicini al cinema del Partito Comunista Italiano dell’epoca.
Eccolo allora il viaggio del cineasta italiano, i cui pezzetti, stralci e tracce sono stati rimessi in ordine grazie a Maria Procino e alla figlia del regista, Carolina. Così se da un lato l’autore napoletano voleva riaggiornare con la vita di Guevara il discorso formale alla Salvatore Giuliano (“non voglio tirare le somme, voglio lasciare molti dubbi e molto alle interpretazioni”), e un’impostazione che si muove “tra l’emozione-commozione e il filo logico-politico del discorso”; dall’altro deve vivere sulla sua pelle, un po’ come il Werner Herzog che attende di girare Fitzcarraldo, il tormento dell’inazione di fronte ai problemi produttivi e quindi politici di cubani e boliviani che nonostante i complimenti al cineasta di fama mondiale non fanno sbloccare la realizzazione del film. Il tempo “perso” è però utile per comporre quell’intarsio di fondo, quella sovrastruttura che funge da ragionamento generale, per dimostrare almeno un fatto: perché la povera gente, gli indios, i contadini, gli operai, e il partito comunista boliviano non hanno seguito il Che in Bolivia ed anzi, l’hanno lasciato solo fino alla morte. Rosi incontra politici ed ex guerriglieri, perfino il “traditore” Regis Debray, ma è nell’osservazione della popolazione andina, nell’anima di quel luogo che affascina e respinge, in quella mancata presa di coscienza rivoluzionaria dei più umili che a Cuba, sulla Sierra Maestra dieci anni prima fece invece rivivere e infine vincere la rivoluzione del Che e Fidel, che le pagine di questo libro diventano preziose testimonianze di un uomo di cultura che studia, confronta, comprende la basi dell’arretratezza del Sud America, affondando le mani e la mente nel gorgogliare di miseria e paura. In quel lungo elenco di frasi secche che iniziano con una “e” emergono con forza i danni irreparabili del colonialismo europeo e poi americano che hanno impedito agli indigeni ogni evoluzione nei bisogni e nella coscienza.
Sarà un film di “suggestioni e non di ricostruzioni realistiche”, spiega il regista nei suoi appunti. Solo che il film si arena. Il tentennare dei funzionari cubani, le paure di Grimaldi, l’opera di Rosi non vedrà mai la luce. Eppure sarebbe stato qualcosa di straordinario e magmatico, di imperdibile e memorabile. Prima che Che! diventasse un film di Richard Fleischer nel 1969 con Omar Sharif ad interpretare il guerrigliero (Rosi aveva pensato a Gian Maria Volonté) il trattamento era già pronto, proprio quello spedito a Cuba per la firma del patto di produzione, qualcosa di parecchio differente dal polpettone hollywoodiano. Documento recuperato e pubblicato in questo libro al cui cospetto, pagina dopo pagina, inquadratura dopo inquadratura, bisognerebbe coprirsi gli occhi per non rimanerne abbagliati. Rosi avrebbe girato un capolavoro immortale.