Un mio professore, all’università, durante una lezione sulla narrazione cinematografica, disse una cosa che da allora mi ripeto spesso: c’è qualcosa, dell’essere umano, che è indicibile; che se ne sta lì accucciato nell’anima del genere umano, silenzioso e pesante, di cui tutti facciamo esperienza perché tutti ce lo abbiamo accucciato dentro. Questa cosa, secondo il mio professore, non è sempre raccontabile; e, forse, non è nemmeno il caso che si racconti perché è lì che risiede il mistero della nostra vita accucciata.
Quando ho letto Un bene al mondo (Einaudi, 2016) di Andrea Bajani, ho pensato a questo. A quello che di indicibile dice questo libro. Però non l’ho pensato subito. Subito, quando cioè ho chiuso il libro dopo la sua fine, ho pensato solo a una parola: oddio. E non solo perché ero turbata dalla sua bellezza, ma perché ho dovuto fare i conti con qualcosa di lacerante eppure invisibile che mi era salita a galla nell’anima, come una piuma che rifluisce dall’acqua.

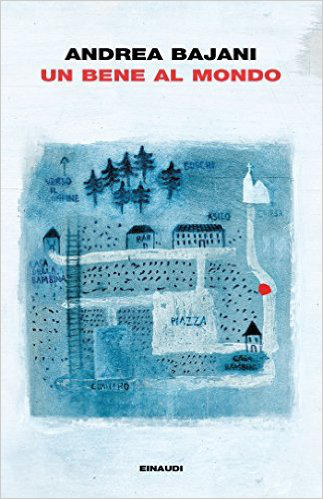 Allora sono stata ferma un attimo, in attesa che il dondolio di questa botta passasse, e solo dopo, molto dopo, dopo aver riportato giù la piuma, ho capito che ciò che la storia di Un bene al mondo mi aveva svelato, era tutto il mio indicibile. Questa indicibilità si è tradotta in forma concreta dopo, quando ho provato a scriverne o semplicemente a parlarne con amici: quando ho scoperto di non avere le parole per raccontarlo, perché Bajani se l’era prese tutte ed erano finite tutte per comporre questo breve romanzo che più che archetipico, definirei mitico.
Allora sono stata ferma un attimo, in attesa che il dondolio di questa botta passasse, e solo dopo, molto dopo, dopo aver riportato giù la piuma, ho capito che ciò che la storia di Un bene al mondo mi aveva svelato, era tutto il mio indicibile. Questa indicibilità si è tradotta in forma concreta dopo, quando ho provato a scriverne o semplicemente a parlarne con amici: quando ho scoperto di non avere le parole per raccontarlo, perché Bajani se l’era prese tutte ed erano finite tutte per comporre questo breve romanzo che più che archetipico, definirei mitico.
Nel senso letterale del termine: una storia, per dirla alla Malinowski, in grado di far risorgere una realtà primigenia che soddisfa i bisogni morali e spirituali dell’uomo, attraverso la narrazione di un archetipo. Questa storia, infatti, narra di un bambino che ha un dolore – ereditato a sua volta dai dolori dei genitori – che lo accompagna fedelmente come una cane, attraverso tutta la sua infanzia fino alla sua vita di adulto. Niente di più difficile, niente di più archetipo e indefinibile: Bajani trasforma, resuscitandolo, il succo primordiale della nostra esistenza e lo fissa, attraverso una narrazione, nella storia letteraria e spirituale della nostra epoca umana. Un mito, appunto, l’unica narrazione che possegga gli strumenti per poter dire qualcosa di indicibile.
Nonostante ciò, poiché il libro è bello, e chiunque lo legga viene colto dalla botta che ha scosso me, ovviamente se n’è parlato tanto; e se n’è parlato in molti modi bellissimi che, però, a me non hanno mai soddisfatto del tutto; c’è chi mette in primo piano la scrittura poetica e lucidissima di Bajani, chi la forma fiabesca della narrazione, chi si addentra più profondamente negli aspetti psicologici della storia. Tutto vero e sacrosanto. Ma ogni cosa detta lascia sempre fuori molto, moltissimo altro, perché la verità è che questo libro nasconde una forza potentissima e misteriosa – tipica dei sogni – che non può più essere ri-narrata (siete mai riusciti a riprodurre il senso profondo di un sogno?) ma solo colta attraverso la sua lettura.
Una cosa del genere, se uno ci pensa, succede raramente, soprattutto nel nostro panorama editoriale in cui si ha paura di scrivere – e pubblicare – cose non complicate, ma complesse; succede più spesso di trovarne tra le tragedie greche. E, soprattutto, tra quelle di Sofocle, in cui la condizione umana viene rivelata da una narrazione esemplare che ci accompagna lungo una via precisa, fino ad allora inimmaginabile.
Il bambino di Bajani è un personaggio sofocleo, privo di qualsiasi enfasi letteraria ma pieno di un’umanità contraddittoria, guasta, dolce e, soprattutto, sola. Ma, al pari di un Edipo o di un Teseo, la bellissima drammaticità di questo bambino che sta crescendo, risiede tutta nello scontro che ingaggia con la vita; un duello niente affatto violento o aggressivo o brutale; soltanto fisiologico, in cui l’uomo esprime il suo naturale, leopardiano attaccamento alla vita (il titolo, non a caso, è tratto da una lettera di Leopardi a Giordani) e grazie al quale s’impunta, s’impenna, si arrabbia, e alla fine, forse, vince.
Articolo Precedente
Terremoto, come il governo ha scelto di non salvare il patrimonio artistico

Articolo Successivo
Omicidio stradale, c’è anche il dolore di chi uccide








