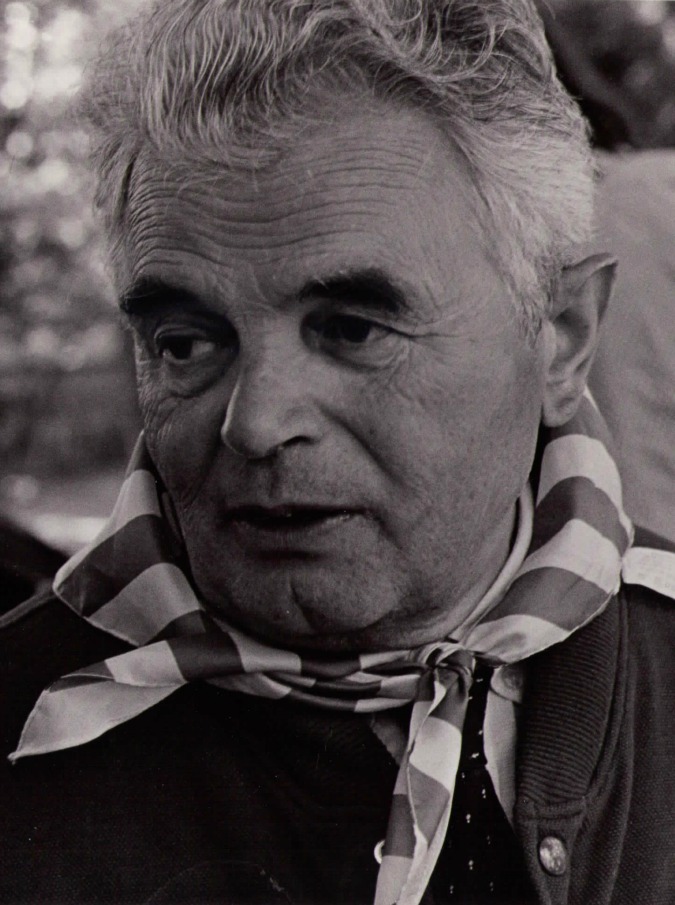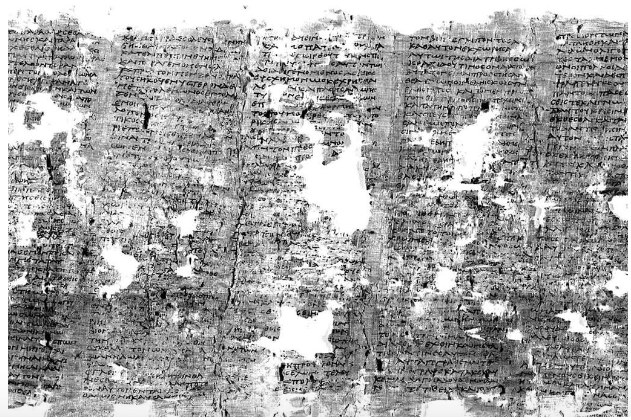“Da oggi tu non sei più Jolanda Dugoni. Da oggi sei la prigioniera numero 30562. Ricordatele bene queste cifre e imparatele a memoria, in tedesco”. A volte, in piena notte, queste parole rimbombano ancora nella testa di Jolanda, classe 1924, internata nel campo di sterminio nazista di Ravensbrück, in Germania, 90 chilometri a nord di Berlino. Il campo delle donne, dove i gerarchi nazisti rifornivano i loro bordelli e dove il famigerato dottor Karl Gebhardt eseguiva gli esperimenti sulla rigenerazione delle ossa, dei muscoli e dei nervi mutilando le prigioniere.
Jolanda, che vive a Mantova dove ormai è rimasta sola, senza parenti, si sveglia sudata e tira un sospiro di sollievo perché si tratta di un sogno, di un incubo. Quelle parole, però, le ha sentite con le sue orecchie 75 anni fa. A urlargliele in faccia la kapò del lager che, suo malgrado, diventa la sua casa per 4 lunghi, terribili anni. Anni nel corso dei quali Jolanda rischia più volte di passare la linea fra la vita e la morte. Anni in cui vede morire centinaia di compagne: di malattia, di fame, nelle camere a gas e nel forno crematorio.
Piange e si interrompe spesso, stretta dall’emozione dei ricordi, mentre racconta la sua storia. Tutto inizia nel 1941. Jolanda all’epoca vive in Francia, a Saint Raphael, dove la sua numerosa famiglia (in tutto nove persone: oltre ai genitori, sette fratelli) si è trasferita, una decina d’anni prima, perché il padre, minatore a Frejus, riesce a riciclarsi come muratore. Per sbarcare il lunario anche la madre si trova un’occupazione come donna di servizio da un ricco ebreo della zona. Jolanda va a scuola dove subisce una prima forma di discriminazione: era italiana e non francese. “Ci trattavano come cagnolini – ricorda – e ci emarginavano. Ai francesi era vietato parlare con gli italiani. Ci chiamavano ‘macaroni’ e ridevano di noi: ‘I macaroni suonatori di violino vanno dietro, in fondo all’aula. Vietato parlare con loro’, diceva la nostra insegnante”. Un’umiliazione quotidiana. Per questo, a 16 anni Jolanda lascia la scuola e si cerca un lavoro. Lo trova in un bar sulla promenade, la via principale di Saint Raphael.
 E’ il 1941. L’Europa è in fermento: la guerra voluta da Hitler la sta mettendo a ferro e fuoco. Un giorno, mentre si trova al lavoro, Jolanda vede passare moltissime persone con la valigia in mano. Chiede al suo titolare chi siano, ma questo le dice che non sono affari suoi e di continuare a lavorare. Lei, però, incuriosita si avvicina a uno di loro e gli chiede chi sia. “Mi dice di chiamarsi Martini e di essere ebreo. Mi racconta che stanno scappando in Italia: ‘Siamo perseguitati qui, non lo sai?’. Ma io non so nulla, non so nemmeno cosa significhi ebreo”.
E’ il 1941. L’Europa è in fermento: la guerra voluta da Hitler la sta mettendo a ferro e fuoco. Un giorno, mentre si trova al lavoro, Jolanda vede passare moltissime persone con la valigia in mano. Chiede al suo titolare chi siano, ma questo le dice che non sono affari suoi e di continuare a lavorare. Lei, però, incuriosita si avvicina a uno di loro e gli chiede chi sia. “Mi dice di chiamarsi Martini e di essere ebreo. Mi racconta che stanno scappando in Italia: ‘Siamo perseguitati qui, non lo sai?’. Ma io non so nulla, non so nemmeno cosa significhi ebreo”.
Quello che invee saprà è che la chiacchierata le costa molto cara. Il giorno dopo, mentre si trova al lavoro al locale, arriva una camionetta della polizia francese agli ordini di Pètain, capo dello Stato di Vichy, governo collaborazionista del Terzo Reich. Dal mezzo scendono due agenti che, senza tanti preamboli, le chiedono se è lei Jolanda Dugonì Macaronì. “Io rispondo di sì e, senza spiegazioni, mi caricano sul furgone e mi portano in questura”. La interrogano tutto il giorno e tutta la notte. Subisce violenze verbali, psicologiche e fisiche. “Mi chiedono perché stessi aiutando gli ebrei a fuggire. Mi domandano con quanti di loro fossi in contatto. Ma io cado dalle nuvole”.
Qualcuno l’ha vista parlare con l’ebreo Martini e l’ha denunciata, firmando la sua condanna. Dopo qualche giorno di prigione viene caricata su un treno merci, nel vagone del bestiame, insieme ad altri prigionieri. Destinazione ignota. “Eravamo ammassati come animali – racconta – e non riuscivamo a muoverci. Ci urinavamo addosso l’uno con l’altro. Uno gridava, l’altro piangeva. Nessuno ci dava da mangiare e da bere. Terribile”. Jolanda interrompe il racconto e piange, sopraffatta dai ricordi e dall’emozione. Dopo tre giorni di viaggio il convoglio arriva a Lipsia. Da lì i prigionieri vengono caricati su decine di camion e smistati nei vari campi di concentramento. Jolanda arriva a Ravensbrück.
Viene schedata, spogliata, lavata, rasata a zero e accompagnata in una baracca, la numero 7. Indossa un pigiama a righe con sopra un triangolo rosso, quello delle prigioniere politiche e un numero: 30562. La vita nel campo è quanto di più simile all’inferno Jolanda immagini. Sveglia all’alba, brodaglia “indecente”, la definisce, a colazione e poi al lavoro. A spalare sabbia tutto il giorno, senza sapere il perché. A pranzo un pezzo di pane, poi lavoro. E alla sera una minestra di rape. Jolanda diventa sempre più magra, più debole. Vede le compagne ammalarsi, morire. “Dovevo resistere perché se fossi crollata, se mi fossi ammalata, sarei finita all’ospedale e poi nel forno crematorio. L’unico modo di uscire dal campo, si diceva, era dal camino”. E gli esperimenti di Gebhardt? “Sì, si sapeva. Nel campo c’erano molte donne, soprattutto polacche, che zoppicavano. Le chiamavano le lapin, le conigliette. Avevano le gambe piene di cicatrici e ferite. Erano le vittime degli esperimenti del dottore”.
Una sera la prigioniera numero 30562 esce dalla baracca per andare al bagno. C’è nebbia e si perde. Quasi per caso arriva a un’altra baracca vicina al crematorio. Entra e si trova davanti a una scena spettrale: centinaia di donne nude, senza vita e ammassate l’una sull’altra in attesa di essere bruciate nel forno. Il racconto si fa straziante. Jolanda si ferma ancora, piange, riprende il racconto: “Un giorno mi ammalo e penso che per me è finita. Mi ricoverano all’ospedale. Ma i nazisti erano distratti. L’Armata Rossa era sempre più vicina e stavano organizzando la fuga. Si dimenticano di me“. Lentamente guarisce e torna al lavoro.
Ma i tedeschi stanno smobilitando. Cercano di eliminare il maggior numero di prigioniere con le camere a gas, i forni, le armi da fuoco. L’obiettivo era lasciare il minor numero di tracce dell’orrore. Ammassano le donne ammalate di tifo nelle baracche e le rinchiudono con quelle sane, nella speranza che la pestilenza faccia il suo corso e li aiuti a eliminare altre prigioniere.
Ma la fine dell’incubo è vicina per Jolanda. Un giorno, alla fine di aprile del 1945, i cancelli del campo si aprono e inizia la lunga marcia verso casa. Nel 2006 Jolanda, insieme agli studenti di un istituto superiore di Mantova, è tornata a visitare il campo, divenuto un museo della memoria.