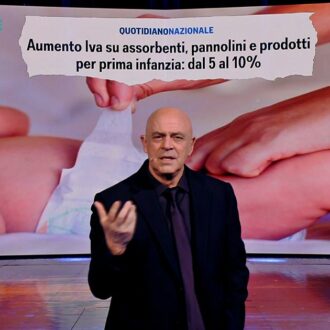Sono d’accordo con il post del collega Nanni Delbecchi: andate a vedere Django Unchained al cinema. Andateci, perché avete l’occasione di vedere un film di quelli come ne passano ormai pochi sui grandi schermi. Un film in grado non solo di intrattenere gli spettatori al livello più completo, ma anche di far discutere, di far calare tutti in un mondo che oggi non esiste più, quello degli Stati Uniti della schiavitù, e che tuttavia esiste ancora, in un certo senso. Nell’epoca delle società multietniche di oggi, le teorie razziste di cui si cibava ieri il Ku Klux Klan non sono certo scomparse: anzi, godono nel XXI secolo di un nuovo impulso, dettato dalla fatica della convivenza fra etnie diverse.
In questo blog ho sempre espresso il mio parere personale. Stavolta faccio un’eccezione e vi riporto quello della mia intera famiglia, che al momento vive su due continenti diversi e ha amato molto questa pellicola. Per un caso buffo del destino, è successo che mentre mia moglie e io andavamo al cinema in Canada a vedere Django Unchained, mio padre e mia sorella fossero invitati la stessa sera all’anteprima del film al cinema Adriano di Roma, per via del contributo dato al genere spaghetti-western di cui Tarantino è, non da oggi, un fine ammiratore, e che qui cita a piene mani, da I giorni dell’ira, definito da Tarantino “un’icona assoluta” a Il mio nome è nessuno, ambedue firmati dal grande, grande, Tonino Valerii.
Siccome Tarantino ha voluto far vedere un pezzo di storia americana dagli occhi di un nero protagonista, è stato molto utile guardare questo film con gli occhi di una nera discendente di schiavi: mia moglie. Lisa ha goduto moltissimo questo film. La scena iniziale, quella degli schiavi visti di spalle con i segni delle frustrate, l’ha fatta sobbalzare sulla poltrona, così le scene in cui Django viene liberato dalla cavigliera di ferro e in generale tutte le scene in cui il corpo di Django o della sua “Broomhilda” (uno dei vari giochi di parole tarantiniani fra il nome tedesco Brunilde e il concentto inglese del “che tiene la scopa”) vengono martoriati.
L’importanza del corpo, alternato alle massice dosi di ironia splatter, nel cinema di Tarantino non è certo un fattore introdotto in Django per la prima volta. Anche i più disattenti ricorderanno l’epica scena di Pulp Fiction in cui la bella protagonista deve essere salvata da un’overdose con una iniezione di adrenalina nel cuore. Il modo in cui quella scena fu filmata, l’effetto sonoro dell’ago che penetra i tessuti fino al cuore, la reazione violenta della donna, la dimensione esagerata della siringa: tutti dettagli voluti dal regista per ricordarci l’importanza delle nostre sensazioni corporali. In Django vediamo dettagli di bruciature, di frustate, corpi scolpiti dai muscoli del lavoro ma anche dal nerbo del cuoio o dal ferro delle catene, di cui appunto il protagonista “si scatena”, per dirla rispettando il doppio senso del titolo originale.
Al di là di questo elemento della corporizzazione, Tarantino è riuscito perfettamente nell’aspetto più delicato del film, quello criticato – a mio modo di vedere ingiustamente – da Spike Lee: il racconto storico, l’illustrazione dello sfruttamento corporale dello schiavo nero da parte del negriero e la normale considerazione di inferiorità espressa dall’intera società. Fate attenzione, quando sarete nel buio della grande sala, alle espressioni di stupore meravigliato delle facce degli attori secondari che guardano sbalorditi e quasi terrorizzati, come se avessero visto un marziano a cavallo, il nostro Django a cavallo. Certo: perché negli Stati Uniti di fine 1800, i neri (da loro chiamati soltanto “nigger”, con un’espressione non esistente in italiano, equivalente alla perifrasi “sporco negraccio”) sono oggetti, sono animali, sono esseri inferiori e, per paradigma, non sono mai stati visti a cavallo in quanto che non vanno mai a cavallo: quella è roba da uomini, da uomini bianchi e ricchi.
E’ proprio nella cura di dettagli di questo tipo che Tarantino è riuscito a mettere davanti alla cinepresa il razzismo dei bianchi contro i neri e dei neri contro i neri stessi, a renderlo una cosa plastica: esattamente com’era nell’America dell’epoca e un pochino com’è tuttora, se è vero che pochi giorni fa han dovuto sospendere una partita amichevole di calcio, Milan-Pro Patria, per i buu scimmiesco-razzisti di alcuni stronzi tifosi avversari, che hanno giustamente spinto al ritiro dal campo di Boateng, giocatore nero, e dei suoi compagni di squadra.
Il cinema, dai tempi dei fratelli Lumiere, è appunto questo: riuscire a illustrare, a far vedere concetti che sono scritti sulla pagina della sceneggiatura. Motivo per cui, tutte le volte che mio padre sente una voce narrante al cinema, gli viene da alzarsi e andarsene via: “Se voglio leggere un libro, o farmelo leggere, non me ne vengo al cinema.” Ecco, Tarantino non usa la voce narrante. Tarantino ve lo fa vedere, il razzismo. Vi ci porta con mano, attraverso quegli sguardi sbalorditi dei suoi caratteristi, certamente istruiti a puntino.
Tutto è perfetto in questa pellicola. La regia, certo, la fotografia, la splendida colonna sonora firmata fra gli altri da Luis Bacalov, Rocky Roberts (già autori principali del Django di Corbucci), Ennio Morricone ed Elisa, la sceneggiatura, finemente riadattata dall’originale italiano del 1966 per mano di Sergio e Bruno Corbucci. Rispetto al nostro spaghetti-western, Tarantino ha la felicissima intuizione di sfruttare il tema del razzismo – lì fra bianchi confederali e messicani – in chiave bianchi/neri. Ma un capitolo a parte merita la recitazione: al di là del gustoso cameo di Franco Nero (il Django del film di Corbucci), tutti sono assoluti nell’opera più bella di Tarantino: Jamie Lee Foxx è un Django bello, credibile, fiero, incazzato, statuario, che fa sognare e applaudire. In una recente intervista a Oprah Winfrey, ha raccontato alcuni atroci aneddoti razzistici di quando era un giovane musicista pagato per suonare nelle ville dei bianchi ricchi: sua nonna gli diceva “Diventa arredamento, quando senti battute razziste. Non reagire.” E signori: parliamo degli Stati Uniti degli anni Ottanta del secolo passato, non del 1800.
Tuttavia, quanto a recitazione ancora migliori se possibile, sono, nei panni del Dr. King Schulz, il già premio Oscar e Golden Globe Christoph Waltz, attore austriaco proveniente dalla televisione e mirabile scoperta di Tarantino in Bastardi senza gloria, ma su tutti un immenso, feroce, razzista, bastardo Samuel L. Jackson, in grado di inchiodare il personaggio di Stephen, vero e proprio kapò nero all’interno della residenza “Candieland” (in inglese, significa “paese delle caramelle”), proprietà dello schiavista negriero Calvin Candie, alias Leonardo Di Caprio. Tarantino riesce così anche a illustrare il razzismo introiettato da parte dei neri: una sorta di auto-razzismo egodistonico, un sentimento infame eppure così umano, che fu certo alla base della schiavitù d’America, ma anche dei campi di sterminio della Shoah, per alcuni kapò almeno. Davvero un capolavoro, per un regista di pelle non nera e di origine italo-americana. Andate al cinema, dicevo, e mettetevi l’abito buono: state per assistere a uno dei film più cinematografici della storia.
Articolo Precedente
Django Unchained di Quentin Tarantino libera la fantasia

Articolo Successivo
‘Un film nello zaino’, a Bologna quattro mesi di cinema ad altezza “bambino”